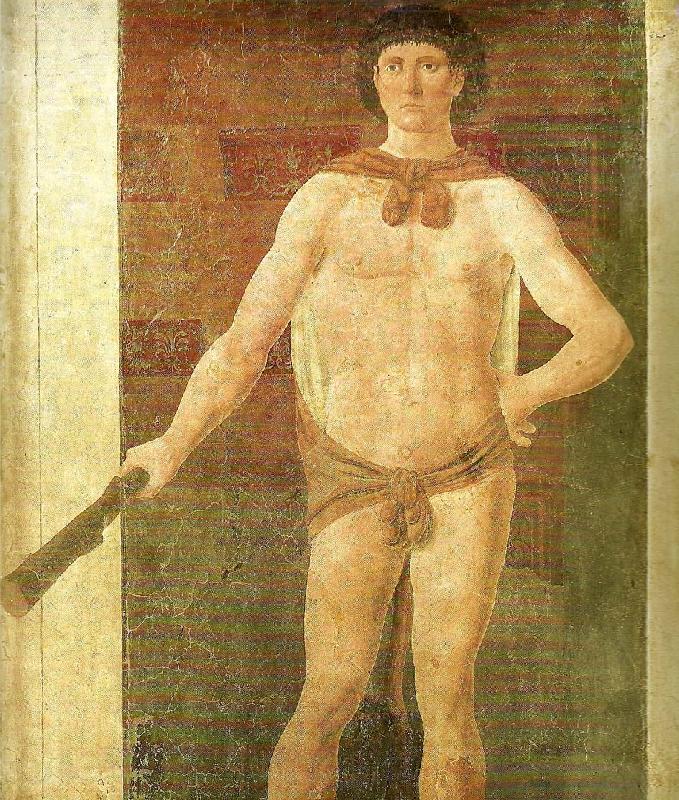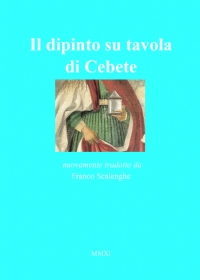La Diairesi in atto
Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι, ὦ φιλούμενε Ἀγάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν, ἐπεὶ Σωκράτει γε οὐδὲν χαλεπόν.
“Mio amato Agatone -replicò allora Socrate- è alla verità che tu non puoi opporre argomenti, giacché a quelli di Socrate non è affatto difficile opporne”
Platone ‘Simposio’ 201D
Il dialogo dimostra che la vita umana cosciente è un continuo flusso di azioni dettate dall’Antidiairesi dietro ordine della Diairesi oppure della Controdiairesi.
Il progetto era quello di godersi un delizioso bagno in un mare cristallino e tranquillo. Ma arrivati a Kedros, Raniero, Irene e Muriel si erano subito scontrati con una situazione che non avevano previsto e che non era gradevole come avevano immaginato. Infatti c’era chi giocava sulla spiaggia con i racchettoni, producendo un rumore costante e fastidioso che sembrava studiato apposta per coprire il piacevole suono del frangersi delle onde sulla battigia. C’era chi, facendo jogging, spruzzava coloro che erano sdraiati presso la riva. C’era chi lanciava al cane una palla che finiva sempre tra i piedi di qualcuno. C’era chi, scuotendo il proprio asciugamano, produceva nuvole di sabbia. C’era chi sbraitava ad altissima voce chiamando qualcuno dall’altra parte della spiaggia. Infine c’era chi, approfittando del bagno dei proprietari, rubava quello che trovava nelle loro borse incustodite.
-Ecco una situazione, disse Raniero, che sembra fatta apposta per farci mettere in atto la diairesi. Quando abbiamo deciso di venire qui a fare il bagno ci siamo anche detti: “Voglio fare il bagno, ma anche serbare la mia proairesi in accordo con la natura delle cose e tale non la serberò se fremerò di sdegno davanti a quanto altre persone ritengono essere utile per loro e che non è in mio esclusivo potere modificare”. Ve lo ricordate?
-Certo, disse Irene. Serbare la propria proairesi in accordo con la natura delle cose significa ricordare che non possiamo avere il controllo assoluto su ciò che non è in nostro esclusivo potere. E allora, adesso abbiamo davanti a noi due strade. La prima è quella di irritarci e di intervenire contro coloro che noi giudichiamo disturbatori. Ma è chiaro che, qui e ora, questo sarebbe inutile e forse anche controproducente. D’altra parte, se a loro piace così… La seconda è quella di usare la diairesi, non metterci in aperto conflitto con loro e scegliere quindi un altro atteggiamento. Ma quale?
-Anche a me non sembra il caso di protestare, aggiunse Raniero. Abbiamo trovato qui una bella occasione per esercitare la nostra tolleranza. Non è proprio quello che ci auguravamo, ma abbiamo in noi risorse sufficienti per fare fronte a questo e a ben altro. Loro si divertono così e così va bene per loro, ma non per noi. Trovo questa una magnifica dimostrazione di ciò che andavamo dicendo qualche giorno fa: una cosa è il nostro progetto di fare il bagno su una spiaggia tranquilla e un’altra cosa è che la spiaggia sia davvero tranquilla, giacché non è in nostro esclusivo potere renderla tale! Io so però che c’è un’altra spiaggia ancora più straordinaria di questa. È più lontana e molto meno frequentata: si chiama Livadi. Avete voglia di arrivare fin là?
-Sì, assentì Irene; però ci vuole parecchio tempo per raggiungerla a piedi e il cammino non è dei più agevoli.
Mentre si discuteva sul che fare, ecco affacciarsi da dietro il promontorio che sovrasta Kedros la grande barca blu di Nicola, già carica di un certo numero di persone e diretta proprio a Livadi. Con sorpresa Raniero, Irene e Muriel vedono la barca dirigersi verso di loro e notano che, ad una estremità della spiaggia, vi è un piccolo molo che serve per l’attracco. Subito l’idea appare luminosa ed essi si affrettano a raggiungere alcune persone che già aspettano sul molo. “Ecco la soluzione: andiamo anche noi a Livadi”. Saliti sulla barca, Muriel ha notato la presenza di un anziano signore vestito con una specie di leggera tunica chiara. Una fluente barba bianca ne incorniciava il viso sereno e dorato dal sole. Sedutasi accanto a lui, Muriel lo ha sentito distintamente chiedere ad uno dei giovani che lo accompagnavano di scrivere quello che gli avrebbe lentamente dettato. Le sue parole erano queste: “Soprattutto per questo aspetto ci si deve allenare. Subito avanzando all’alba, chi vedrai, chi sentirai, indaga, rispondi come ad una domanda. Cosa vedesti? Un magnifico giovanotto od una magnifica ragazza? Applica il canone. E’ aproairetico o proairetico? Aproairetico: rimuovi fuori. Cosa vedesti? Piangere per la fine di un figliolo? Applica il canone. La morte è aproairetica: rimuovi di mezzo. Ti venne incontro un console? Applica il canone: quale cosa è il consolato? Aproairetica o proairetica? Aproairetica: rimuovi anche questo, non è valido; buttalo via, non ti riguarda. Se facessimo questo ed a questo ci esercitassimo ogni giorno, dall’alba fino a notte, qualcosa accadrebbe, per gli dei! Ora invece, subito siamo presi a bocca aperta da ogni rappresentazione e soltanto a scuola, se proprio è così, ci risvegliamo un poco. E poi usciti, se vedremo qualcuno piangere diciamo: “Andò in malora!”. Se vedremo un console: “Beato lui!”. Se un confinato: “Disgraziato!”. Se uno povero di denaro: “Meschino, non ha donde mangiare!”. Questi malvagi giudizi bisogna stroncare, su questo concentrarsi. Giacché cos’è singhiozzare e mugugnare? Un giudizio. Cos’è la cattiva fortuna? Un giudizio. Cos’è conflitto, cos’è divergenza, cos’è biasimo, cos’è accusa, cos’è empietà, cos’è chiacchiere? Questi sono tutti giudizi e null’altro, e giudizi sull’aproairetico come bene e male. Uno alloghi questi sul proairetico ed io mi obbligo con lui che rimarrà stabile, comunque starà quel che lo circonda.” Scesi dalla barca, Muriel ha notato che il vecchio si appoggiava ad un bastone e che zoppicava visibilmente.
Livadi è una grande spiaggia di sabbia bianchissima, assai poco frequentata, con un mare dai colori splendidi e un’acqua trasparente e calma. Al di là della spiaggia si intravedono alcune tende e, all’ombra di una grande tamerice, su dei teli colorati sta seduto in cerchio un gruppo di giovani che, nudi, parlano tranquillamente tra di loro. Intorno vi sono persone che fanno il bagno o prendono il sole o passeggiano lungo la riva del mare. Alcuni indossano il costume, ma la maggioranza della persone si è liberata di ogni abbigliamento.
Dopo avere fatto il bagno, Raniero e Irene si sono avvicinati al gruppo. In quel momento è sopraggiunta Muriel che, rivolgendosi ai suoi due amici, ha detto:
-Scusate, vi avevo perso di vista perché mi ero fermata a scrivere le cose terribili che ho sentito dire da un anziano signore mentre eravamo in barca. Se poi vorrete, più tardi ve le posso leggere-
I giovani li hanno accolti con naturalezza e hanno offerto loro dell’acqua. Un ragazzo di nome Iorgos raccontava che quella mattina, dopo aver smontato la loro tenda, due cari amici sono partiti per tornare a casa loro. Questa separazione lo ha molto toccato, lo fa sentire infelice, e si nota bene il suo bisogno di condividere con gli altri i suoi sentimenti.
-Sentimenti? Cosa intendi dire, chiese Tom, quando usi questa parola?
-Per me, gli rispondeva Maria, i sentimenti sono l’espressione delle emozioni che provo nei confronti degli altri. Tu hai detto ai due amici che partivano che volevi loro bene. Per me il sentimento è essenzialmente il sentimento d’amore. Ce ne sono anche molti altri, ma di questo stiamo ora parlando, ed è questo che tu ora provi-
-Sono d’accordo con te, diceva Tom. Ma devo anche ripetere, come dicevo poco fa a Iorgos, che il condividere questo sentimento con altri non mi toglie il dolore e l’infelicità che provo per questa separazione
-Se tu, intervenne Raniero, ti lasci invadere dalla nostalgia e ti affliggi per la separazione, sembri dare un giudizio puramente negativo della situazione e dunque un giudizio che ti procura infelicità. A che ti serve?
-Non è qui il punto, ribatté Iorgos. Io semplicemente mi do il diritto di provare ciò che provo e di comunicarvelo. Se anche voi provate la stessa cosa, ciò mi rende più sopportabile l’infelicità della separazione. Io penso cioè che il poter condividere con altri i propri sentimenti sia utile e importante
-Guarda che se ci pensi bene, disse Raniero, anche i sentimenti sono dei giudizi
-In che senso? chiese Iorgos-
-Quelli che tu chiami sentimenti, spiegò Raniero, sono giudizi perché possono sempre essere tradotti così: “Stare con queste persone mi piace”. Se il giudizio fosse diverso e fosse del tipo “Stare con queste persone non mi piace”, ecco che tu lo chiameresti un sentimento di avversione e non proveresti infelicità per la separazione
-Mi sembra, insorse Tom, una gran banalità! Mi stai dicendo semplicemente che se la situazione fosse diversa il mio sentimento sarebbe diverso. E allora?…
-Va benissimo quello che tu dici, rispose con calma Raniero. È un’ovvietà, ma l’importante è che tu ammetta che i sentimenti sono dei giudizi, che “tu” sei i tuoi giudizi e che essi sono in tuo esclusivo potere.Soltanto tu puoi cambiarli. Nessun altro può farlo al posto tuo, né tu puoi chiedere a qualcun altro di farlo per te: tu sei libero nei tuoi giudizi
-Quindi, continuò Iorgos, dovrei modificare il mio giudizio sulla situazione e dire che non me ne importa niente che i miei amici siano partiti? In questo modo potrei evitare di starci male, vuoi dire questo?
-Dei nostri giudizi la natura ha fatto padroni noi e soltanto noi, rispose Raniero. Quando si parla di sentimenti come se fossero entità indipendenti dai nostri giudizi, si corre il rischio di credere che i sentimenti siano padroni di noi e non noi dei nostri sentimenti. Se davvero i sentimenti fossero padroni di noi e tu fossi una persona conseguente, questa separazione dovrebbe trascinarti a decisioni estreme. Questo dovresti fare: suicidarti per l’infelicità che ti dà la separazione, come fece Didone quando Enea la abbandonò. Se questi vostri amici non fossero soltanto partiti ma fossero già adesso morti in un incidente e tu non potessi vederli mai più, cosa faresti? Per essere coerente, visto che loro sono davvero un bene per te, che la sottrazione di quel bene è per te un male che ti rende infelice e che tu non puoi vivere se non hai quel bene che la loro partenza ti ha tolto, dovresti appunto suicidarti
-Quello che tu dici mi pare esagerato, replicò Iorgos. Nella vita di una persona non ci sono soltanto gli amici ma molte altre cose. Dunque perché suicidarmi? Io sono semplicemente triste
-Vedi, gli rispose Raniero, che tu fai -senza rendertene conto- queste operazioni: in primo luogo frammenti il bene in tanti beni diversi quante sono le persone o gli oggetti esterni che giudichi importanti per te. In secondo luogo giudichi di avere su di essi un potere per cui il loro possesso ti procura felicità e la loro perdita infelicità. In terzo luogo decidi tacitamente che non ve ne sia però mai uno decisivo e che quindi, per scegliere di suicidarti, dovrebbero esserti tolte tutte insieme queste persone e tutti questi oggetti esterni. Ma queste persone e questi oggetti -se ci ragioni bene-non ti appartengono, perché sono persone e oggetti fuori di te, sono cioè -come abbiamo già detto- entità aproairetiche sulle quali tu non hai alcun potere esclusivo. Tu ti comporti, insomma, come chi crede che si possa morire annegati soltanto in mare aperto e profondo mentre dimostri che per annegare te bastano due dita d’acqua
-Si, intervenne Maria, sarà così; ma questo non toglie che io provi infelicità nella separazione
-Questo accade, continuò Raniero, perché tu equipari la separazione a una perdita e dai ad essa un valore soltanto negativo. Invece i tuoi amici sono per te, in quanto esterni a te, né bene né male e dunque la separazione da loro non è la separazione da un bene ma da qualcosa che è né bene né male
-Vuoi dire, disse Maria, che tutto ciò che è esterno non vale nulla e conta solo ciò che sono io? Mi sembra una posizione molto egocentrica e mi convince assai poco
-Sono allibito, rispose Raniero. Se tu togli a tutto ciò che è esterno la qualità di essere bene o male, vuol forse dire che con ciò tu togli importanza a ciò che è esterno? Se una cosa è né bene né male vuol forse dire che non continua a rimanere fredda o calda, colore o incolore, pesante o leggera, dolce o salata e, nel caso di una persona, avvenente o ripugnante, alta o bassa, maschio o femmina, triste o gaia, felice o infelice e tutte le altre infinite possibili determinazioni che la specificano e caratterizzano?
-Quando tu dici, riprese Irene, che una persona è né bene né male a me sembra che tu dica che non vale niente, ed è questo che mi turba. Il fatto è che nella nostra cultura le parole ‘bene’ e ‘male’ sono strettamente connesse al valore ed è ciò che crea l’equivoco e la difficoltà di comprensione di ciò che tu dici
-Tutto ciò che è esterno a noi (persone, cose, situazioni, ecc.) è né bene né male, rispose Raniero. Bene e male stanno soltanto nell’uso che ne facciamo, e questo uso è in nostro esclusivo potere. Per esempio. I pezzi degli scacchi non sono né bene né male: sono i pezzi degli scacchi. Il buon giocatore saprà però usarli nel modo corretto e vincerà la partita; il cattivo giocatore la perderà. In questo non c’è un giudizio di valore sugli scacchi in quanto tali ma soltanto sul loro uso. La nave è né bene né male e tu dici che non esiste o che non vale nulla? Il buon pilota la sa portare in porto anche con un mare agitato, il cattivo pilota la farà affondare
-Ho capito, disse Tom. Tutto ciò che è esterno è né bene né male mentre bene e male stanno soltanto nell’uso che noi facciamo di ciò che è esterno a noi
-Sì, è così; annuì Raniero. Tu conservi intatta la facoltà di giudicare piacevole, desiderabile e utile la presenza dei tuoi amici partiti, giacché questo è un giudizio che dipende esclusivamente da te. Ma la separazione, al contrario, non dipende esclusivamente da te. Su di essa tu hai il tuo giudizio: ma perché questo è sempre negativo e causa di infelicità per te? Ciò che ti fa soffrire è, in realtà, la paura di soffrire-
-Forse tu hai davvero ragione, mormorò con profonda concentrazione Iorgos. Ma cosa possiamo fare di diverso?
-Puoi fare un’altra scelta, sospirò Raniero, e considerare la separazione da un altro punto di vista. Sei libero di formulare altri giudizi. Per esempio che la separazione renderà più gradevole il ritrovarsi; oppure che la separazione è necessaria e che produrrà qualcosa di nuovo; e così via. Allora la diairesi in atto, modificando i tuoi giudizi cambierà anche i tuoi sentimenti. Se togli valore di bene e di male a ciò che è aproairetico perché ne trai la conseguenza che non potrai più mostrare sentimenti? Accetta di provare questo “languore”, non resistergli, non temere la separazione, non avere paura di provare qualcosa che immagini ti possa schiacciare mentre puoi sperimentare di essergli superiore
-Io per esempio, disse Penelopi, quando provo un dolore lo censuro; penso ad altro e mi metto a fare un sacco di cose perché non mi va di stare male. Non faccio come dici tu, non accetto il dolore e vado altrove
-Io invece, spiegò Muriel, quando provo dolore non ho più voglia di fare nulla. Nulla più mi pare interessante e tutto mi sembra negativo. Entro insomma in una bella depressione in cui nulla ha più valore per me e comincio a pensare che io stessa non ho alcun valore, altrimenti non ci sarebbe stata separazione. Questo mi capita soprattutto se la separazione è la fine di una storia sentimentale!
-Quando dici, riprese Raniero, che sei colpevole della separazione e che non vali per questo, tu implicitamente giudichi che la separazione è qualcosa -anche se in negativo- in tuo esclusivo potere e che sei stata soltanto tu a causarla: dunque sei anche origine della tua stessa afflizione. Vedi che se tu giudicassi che la separazione non è dipesa esclusivamente da te, già eviteresti di entrare in quel circolo vizioso che hai descritto e che ti costringe a vivere oltre che la separazione anche la depressione
-Io invece, intervenne Sofia, trovo che sia importante stare nella situazione anche se di nostalgia o di infelicità e accettarla, come diceva Raniero, in modo da integrarla. Se la rifiuti o la demonizzi diventa sempre più grande; se la accetti e non te ne fai dominare puoi essere felice anche nel crepuscolo!
-Ma scusa, protestò Iorgos, non puoi dirmi che puoi essere felice e infelice nello stesso tempo…
-Hai fatto bene a dire questo, intervenne Raniero, perché se si usano termini contraddittori non si capisce più niente. Quindi non chiameremo mai infelicità tutta la gamma di teneri, delicati, nostalgici sentimenti di chi ha appreso ad usare correttamente la sua proairesi e a non impiegare alcun giudizio senza averlo prima ben analizzato. Come essere dunque affettuosi? Da uomini liberi, da uomini fortunati. Giacché la nostra ragione non sceglierà mai che noi siamo servi nell’animo, né di svigorirci né di farci penzolare da questo o da quest’altro. Noi possiamo dunque essere affettuosi così, con l’intenzione di serbare questo. Se invece a causa dell’affettuosità, qualunque cosa sia quello che chiamiamo affettuosità, stiamo per essere servi e meschini, non ci è vantaggioso essere affettuosi
-No, scusa, disse Irene; stai forse dicendo che per non rischiare di essere dipendenti o meschini o servi sia meglio non essere affettuosi per niente?
-Io sto dicendo, rispose Raniero, che la tua presenza mi è cara, anche necessaria; ma se tu parti io, pur provando il senso della mancanza, la nostalgia o il languore che segue a una separazione, saprò vivere la tua assenza da uomo libero, da uomo che non si fa travolgere da sentimenti legati ad eventi che non sono in suo potere
-Mi sembra, disse Muriel, che tu in questo modo subisci passivamente le scelte altrui
-Io posso anche cercare di condizionare le scelte di Irene in modo da facilitare od ostacolare una scelta che non mi piace, ma certamente non è in mio potere far sì che lei scelga ciò che io preferisco. Dunque io non tolgo significato al sentimento di tristezza, languore o nostalgia che segue ad una separazione. Possiamo definire questi sentimenti come sentimenti improvvisi e di breve durata. Ma io non perdo di vista il fatto che questi sentimenti non mi possono travolgere essendo essi stessi eventi aproairetici, ossia eventi che non sono in mio esclusivo potere. A questo punto quel che posso e devo fare è mettere in atto la diairesi, analizzarli alla luce del fatto che essi non sono in mio esclusivo potere ed aprire la porta ai sentimenti stabili, di lunga durata, che ora sappiamo essere in realtà giudizi. Questo è ciò che dipende esclusivamente da me. Sono quindi io che scelgo di stare molto male o un po’ male o addirittura abbastanza bene!
-Io che mi sono separato da mia moglie l’anno scorso, intervenne Dimitri, non riesco proprio ad accettare questa separazione. Vado cercando continuamente tracce sotto forma di lettere, di fotografie, di persone che mi ricordino mia moglie, in modo da sentirmi come ero prima
-Il giudizio che tu hai su tua moglie, disse Penelopi, è che ella era sicuramente per te un bene, essendo separato dal quale tu vivi infelicemente. Cerchi così di ricostituire quella situazione che era buona per te, ma ormai non è più possibile: che cosa intendi fare?-
-Io rinuncio, sospirò Dimitri, a vivere nuove cose e voglio stare solo nel ricordo di ciò che era un bene per me
-Nessuno al mondo, annuì Raniero, potrà convincerti del contrario e io ritengo che sia un peccato perdere un amico come te, che sceglie di vivere solo. È un peccato perdere la tua compagnia, la possibilità di confrontarci e di discutere insieme. Ma se tu lo decidi, noi non possiamo farci niente anche se ci dispiace. Tu, caro Dimitri, mandi in malora un uomo, cioè te stesso, che non ha commesso alcuna ingiustizia
-Io invece, intervenne Irene, ho fatto l’esperienza della diairesi in atto, di quello che tu hai chiamato il cambiamento del giudizio sulla separazione. Per me la separazione non è soltanto negativa e fonte di dispiacere anche se, ovviamente,questo sentimento non mi è sconosciuto.La vivo anche come un momento che mi consente di vedere con più lucidità ciò che ho vissuto e di provare sentimenti di gratitudine per ciò che ho avuto, essendo consapevole che ogni cosa ha un suo inizio e una sua fine. Mi è venuto in mente, e lo penso, che è proprio il contrario di quello che aveva scelto di fare Medea la quale, a causa della sua separazione dolorosa da Giasone, aveva scelto di svalutare e mortificare tutto ciò che c’era stato tra di loro prima-
-Allora mi pare di capire, disse Maria, che tu Raniero non neghi l’esistenza dei sentimenti e la legittimità di provarli. Semplicemente dici che sono riconducibili a giudizi dei quali noi siamo padroni e che bisogna vedere l’uso che se ne fa
-E’ proprio così ed è ovvio, concluse Raniero, che ne farai un uso oppure un altro a seconda del giudizio che ti guida al riguardo. La parola stessa diairesi significa separazione: separazione da che cosa? Separazione dei giudizi di bene o male da qualunque cosa esterna a chi giudica e attribuzione della qualità di essere bene o male soltanto alla nostra proairesi individuale quando essa operi rettamente e, cioè, quando sappia distinguere tra ciò che è in nostro potere e ciò che non lo è, oppure non rettamente quando essa pretenda di avere potere là dove non ce l’ha. A proposito di ciò di cui abbiamo discusso non nego quindi la tristezza della separazione, ma non dimentico che la separazione non dipende esclusivamente da me e nego che il giudizio sulla separazione debba essere sempre causa di infelicità. D’altra parte noi non possiamo fare a meno di interagire con le persone o le cose esterne a noi. Ebbene non dobbiamo avere timore di questi rapporti e non dobbiamo aspettarci da essi alcun male bensì un bene, qualora noi sappiamo, grazie alla capacità di usare la diairesi, tenere fermo il loro valore. Così nessun calciatore disputa sul peso o sulla dimensione del pallone ma l’abilità di ciascuno si dimostra nella capacità di usare un oggetto che è uguale per tutti. Non dipende da noi com’è il pallone ma dipende da noi superare gli ostacoli, compresa la paura di vincere, e decidere di segnare un goal!
Era ormai pomeriggio inoltrato ed improvvisamente un borbottio lontano ma inconfondibile annunciò l’imminente arrivo della grande barca blu di Nicola.
-Chi vuole tornare a Kedros in barca insieme con noi? chiesero Maria e Dimitri. La barca è già in vista e occorre prepararci in fretta
-Il mare è calmo e io torno senz’altro con voi in barca molto volentieri, disse Muriel
-Io ho un grande desiderio di riguardare dalla barca la magnifica costa rocciosa che abbiamo ammirato venendo qui stamattina. Anch’io vengo con voi. E tu Raniero, cosa fai? chiese Irene
-A me piace di più l’idea di camminare. Desidero guardare il mare dall’alto e deliziarmi ancora del profumo dei cespugli di timo e di elicriso che punteggiano l’aspro sentiero che porta fin qui. Ci vediamo più tardi alla taverna di Nikitas per una birra?