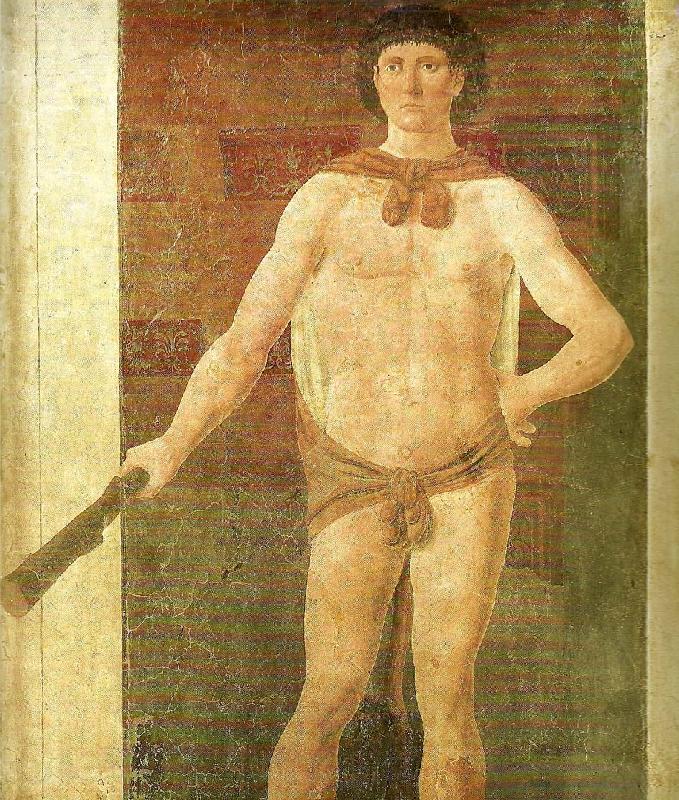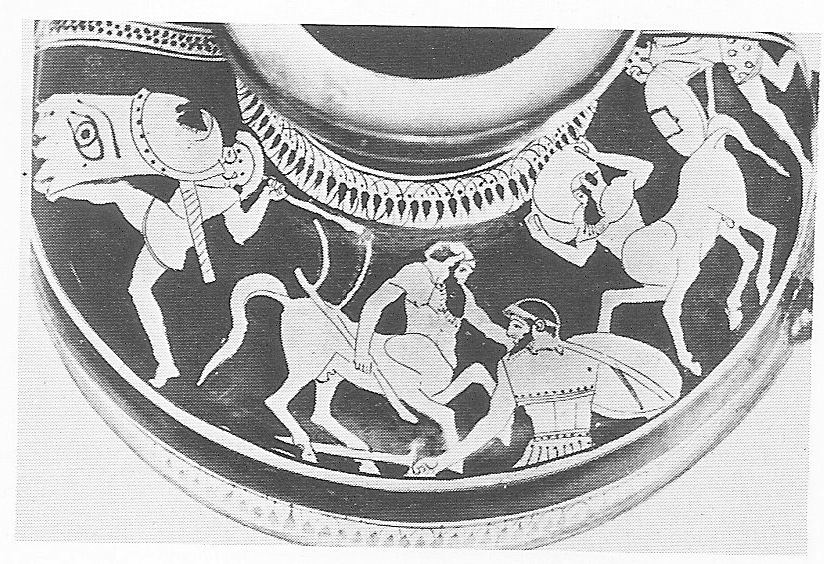De Communibus Notitiis
Adversus Stoicos
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΩΙΚΟΥΣ
§ 1. [1058E] UN COMPAGNO. Diadoumeno, è verosimile che a te importi poco o nulla se a qualcuno la vostra [1058F] filosofia pare in contrasto con i concetti di comune buonsenso. Anche tu ammetti di non pregiare granché le sensazioni sulle quali si fondano quasi tutti i concetti di comune buonsenso; i quali certo, quanto alla fiducia per le apparenze fenomeniche, poggiano sicuramente su quelle. Ma poiché, come mi pare, sono giunto a questo riguardo a sentirmi pieno [1059A] di un grande e inspiegabile sconcerto: ti prego di non tardare a curarmi in proposito con qualche discorso ragionato o qualche scongiuro o qualche altra forma di lenimento che conosci. Sono stati gli Stoici a mettermi nello stato di agitazione che vedi e a farmi diventare titubante. Essi sono per il resto ottime persone e pure, per Zeus, miei amici intimi; ma contestano molto aspramente ed hanno un’avversione assai profonda per l’Accademia. Quando io ho fatto loro alcune obiezioni, poche e in modo molto rispettoso, essi (non dirò una falsità) hanno ribattuto con dignità e con mitezza; ma gli antichi Accademici li hanno chiamati con rabbia sofisti, persone che disonorano e insudiciano chi fa filosofia, gente che butta per aria dottrine che invece seguono sistematicamente un metodo; e dopo avere detto e ripetuto molte cose ancora più strambe di queste, [1059B] alla fine si sono diffusi a parlare dei concetti di comune buonsenso, sostenendo che gli Accademici apportano in questo ambito confusione e frammentazione. Dopo di che uno di loro ha affermato che si potrebbe quasi legittimare l’idea che Crisippo sia nato dopo Arcesilao e prima di Carneade non per divina opera della Fortuna ma della Prònoia; giacché di quelle due personalità, Arcesilao diede principio all’oltraggio e alla prevaricazione contro la comune consuetudine di fiducia nelle sensazioni, mentre Carneade rappresentò il fiore all’occhiello degli Accademici. Pertanto Crisippo, nascendo tra i due, con le sue repliche polemiche ad Arcesilao sbarrò anche il passo alla valentia dialettica di Carneade, poiché lasciò molti presidi a difesa della sensazione, come fossero aiuti in caso di assedio; ed eliminò del tutto i motivi di sommossa tra i preconcetti e i concetti, correggendo ciascuno e ponendolo al proprio posto; [1059C] di modo che quanti decidessero di sbattere un’altra volta fuori dalla porta i fatti oppure di violentarli, non concludessero nulla ma fossero contestati come malfattori e gente che sofisteggia. Io dunque, arroventato come sono stamattina da siffatti discorsi, ho bisogno di un estintore che mi levi l’incertezza dall’animo, come si trattasse di un’infiammazione acuta.
§ 2. DIADOUMENO. Ciò che hai sperimentato tu è simile a ciò che forse hanno sperimentato in molti. Ebbene, se i poeti riescono a persuaderti quando affermano che il sovvertimento e la distruzione dell’antica città di Sipilo avvenne per decisione della divina Prònoia, giacché gli dei intendevano in questo modo castigare Tantalo; allora credi pure ai tuoi compagni Stoici quando affermano che la Natura fece venire al mondo Crisippo non per opera della Fortuna bensì della Prònoia, [1059D] giacché essa Natura aveva bisogno di mettere sottosopra e soprasotto ogni cosa. Come Catone soleva dire che nessuna persona sobria e sana di mente, eccetto il famoso Giulio Cesare, s’era mai avvicinata agli affari pubblici allo scopo di gettare nello scompiglio più completo la Repubblica; così mi sembra che quest’uomo, dico Crisippo, sovverta e demolisca le comuni consuetudini con la massima solerzia e valentia, come talora testimoniano anche coloro che lo esaltano e però non sono d’accordo con lui a proposito del ragionamento detto del ‘Mentitore’. Giacché l’affermare che un assunto in forma indefinita, formato da proposizioni contrapposte e copulativamente coordinate non è a iosa falso; [1059E] ed inoltre l’affermare che esistono dei ragionamenti aventi premesse vere e linee di trattamento logico sane, per i quali ciononostante sono veri pure i contrapposti delle conchiusioni: quale concetto di dimostrazione o quale preconcetto di affidabilità non sovverte? Si dice che il polipo smangiucchi i suoi stessi tentacoli durante la stagione invernale; e allora la dialettica di Crisippo, la quale leva di mezzo rosicando torno torno le parti principali e le fondamenta di se stessa, quali altri concetti può mai lasciare al riparo dal sospetto? È certo che i piani superiori di un edificio filosofico non possono essere ritenuti poggiare su una base salda e ben fissa, quando i piani inferiori dello stesso non lo sono, essendo soggetti a tali aporie e a tali scossoni. [1059F] Come coloro che hanno corpi infangati o impolverati pensano che chi li tocca o si sfrega loro contro non rimuove ma aggiunge altra materia irritante, così gli Stoici accagionano gli Accademici e ritengono che siano loro a causare ciò di cui essi mostrano di essere imbrattati dalla testa ai piedi: poiché chi più degli Stoici perverte proprio i concetti di comune buonsenso? [1060A] Se sei d’accordo, tralasciando di muovere loro accuse ci difenderemo da ciò di cui essi ci incolpano.
§ 3. UN COMPAGNO. Diadoumeno, oggi mi sembra d’essere diventato un uomo variegato e multiforme. Testé infatti, sentendo il bisogno d’una difesa, mi avvicinavo a te mogio mogio e con l’animo in tumulto. Adesso invece mi trasformo in accusatore e voglio godermi la vendetta di vedere contestati gli Stoici proprio sullo stesso punto, cioè quello di avere una filosofia che è in pieno contrasto con i concetti e i preconcetti di buonsenso, dai quali essi invece credono che la loro Scuola sia germogliata come da dei semi e che affermano essere la sola coerente con la natura.
DIADOUMENO. È dunque il caso di cominciare il cammino da quei comuni e notori concetti che gli stessi Stoici, [1060B] prendendone alla leggera l’assurdità, denominano paradossi: su chi soltanto è re, su chi soltanto è ricco, per bene, cittadino e giudice? Oppure vuoi che questi paradossi li mettiamo da parte per il mercato dei concetti stantii e gelidi, e invece facciamo l’indagine della dottrina degli Stoici sui loro concetti quanto più possibile aderenti ai fatti pratici ed attentamente ragionati?
UN COMPAGNO. A me piace di più questa seconda strada; giacché delle contestazioni ai loro paradossi chi non ne ha ormai fin sopra i capelli?
§ 4. DIADOUMENO. Allora considera subito in primo luogo questo, cioè se sia un concetto di buonsenso e se siano coerenti con la natura coloro i quali legittimano come ‘indifferenti’ cose che sono secondo natura, e ritengono salute, benessere, avvenenza, [1060C] potenza del corpo cose che possono essere non scelte, anzi essere né giovevoli, né vantaggiose, né completive della nostra perfezione secondo natura; e ritengono che anche gli opposti come storpiature, sofferenze, laidezze, malattie possano essere non fuggiti ed essere non dannosi. Di tutte queste cose sono gli stessi Stoici a dire che verso le une la natura ci estrania e verso le altre essa ci imparenta; ed anche questo è davvero un concetto del tutto contrario al buonsenso, ossia concepire che la natura ci imparenti a cose né utili né buone e che ci estranei da cose che sono né cattive né dannose. Inoltre, e questa poi è la cosa più importante da notare, la natura ci estrania e ci imparenta ad esse a tal punto che coloro i quali non centrano ciò cui la natura ci imparenta e incappano in ciò da cui la natura ci estrania, escono fuor di vita [1060D] a ragion veduta e rinunciano ad essa.
§ 5. Io ritengo che sia contrario al buonsenso affermare che la natura di per sé è indifferente, e però sostenere che il sommo bene consiste nel vivere secondo natura. Infatti virtuoso non è il conformarsi alla legge né l’obbedire alla ragione, se legge e ragione sono né virtuose né civili. Ma questo è il meno. Se poi, come ha scritto Crisippo nel primo libro dei ‘Discorsi esortativi’, soltanto nel vivere secondo virtù consiste il vivere felicemente e “tutto il resto”, egli dice, “è nulla per noi e non coopera al raggiungimento di questo scopo”; allora la natura è non soltanto indifferente, ma è anche dissennata e stupida, [1060E] in quanto ci imparenta a cose che sono nulla per noi. E stupidi siamo anche noi a credere che la felicità consista nel vivere secondo natura, quando proprio questa natura ci conduce verso cose che non cooperano affatto all’ottenimento della felicità. Eppure quale concetto è maggiormente in accordo con il comune buonsenso di questo: come le cose che scegliamo le scegliamo perché ci giovano, così le cose secondo natura sono quelle che ci servono per vivere secondo natura? Gli Stoici però non parlano così e invece, dopo avere stabilito che il nostro fine è quello di vivere secondo natura, ritengono che le cose secondo natura siano indifferenti.
§ 6. Un altro concetto non meno in contrasto col comune buonsenso è quello secondo cui l’uomo di senno, l’uomo saggio, non si comporta allo stesso modo verso beni di pari importanza; e invece mentre ad alcuni non dà valore, per altri è disposto a sopportare e subire qualunque cosa, [1060F] pur se essi sono né più piccolo né più grande uno dell’altro. Gli Stoici infatti sostengono che per chi è saggio sono la stessa cosa l’astenersi con temperanza dal contatto carnale con una Laide od una Frine, e il rifiutare con temperanza quello con una vecchia con un piede già nella fossa. Oppure il farsi forza e sopportare virilmente tagli e bruciature e il sopportare virilmente il morso di una mosca, giacché tutti e due gli individui compiono un’azione similmente retta. Eppure per le prime azioni, in quanto grandi e illustri, essi sarebbero disposti a morire; [1061A] mentre il darsi un’aria solenne per le seconde è secondo gli Stoici vergognoso e ridicolo. Anche Crisippo nella sua compilazione ‘Su Zeus’ e nel terzo libro ‘Sugli dei’ dice: “È una freddura, è assurdo, è improprio lodare cose del genere: ‘resse virilmente la puntura di una mosca’ e ‘con temperanza s’astenne da una vecchia con un piede già nella fossa’, come azioni derivanti dalla virtù”. Non è dunque forse vero che la filosofia degli Stoici è contraria al comune buonsenso, visto che essi si vergognano di lodare quelle azioni delle quali ammettono però che non esiste nulla di più bello? Dove sta un’azione degna di scelta ovvero come può un’azione essere approvabile se non è degna d’essere lodata né d’essere ammirata, anzi se gli Stoici ritengono coloro che la lodano dei fredduristi in vena di assurdità?
§ 7. [1061B] Ed ancor più ti apparirà, io credo, contrario al concetto di comune buonsenso, il fatto che l’uomo saggio non si preoccupi né della presenza né dell’assenza dei più grandi beni e che invece si comporti riguardo ad essi esattamente al modo in cui si comporta nel trattamento e nella amministrazione delle cose indifferenti. Tutti noi certo
‘quanti ci nutriamo del frutto della spaziosa terra’
capiamo che questo frutto è degno di scelta, buono e giovevole quando la sua presenza ci è di conforto e la sua assenza ci è causa di un senso come di carenza e di desiderio; mentre capiamo che è indifferente il frutto per cui nessuno si darebbe da fare neppure per scherzo o per infingardaggine. Grazie a nessun altro criterio, infatti, noi definiamo l’uomo laborioso distinguendolo da colui che si occupa di sciocchezze pur essendo assai attivo, [1061C] se non perché quest’ultimo si affatica indiscriminatamente per cose del tutto futili, mentre invece il primo lo fa per cose utili e vantaggiose. Ma questi qua pensano il contrario. Per gli Stoici, infatti, fra molte apprensioni certe e ricordi di apprensioni certe, l’uomo diventato sapiente e saggio ritiene che poche lo riguardino direttamente; e senza preoccuparsi delle altre crede di avere né di meno né di più se si rammenta che l’anno scorso ebbe l’apprensione certa di Dione che starnutiva o di Teone che giocava a palla. Seppure, nell’uomo sapiente, ogni apprensione certa e ogni ricordo sicuro e saldo siano anche direttamente scienza e un bene grande, anzi sommo. [1061D] E dunque in modo simile, quando la sua salute viene meno, i suoi sensi si ottundono e le sue sostanze vanno in malora, il sapiente non è preoccupato e ritiene che tutto ciò sia nulla per lui? Oppure: “Quando è ammalato paga l’onorario ai medici, e allo scopo di fare denaro naviga per raggiungere Leucone, sovrano nel Bosforo; e si mette in viaggio per recarsi presso Idantirso lo Scita”? Non è forse Crisippo ad affermare: “Delle sensazioni, ve ne sono alcune perdendo le quali il sapiente non sopporta più di vivere”? Perché dunque gli Stoici non ammettono che la loro filosofia è contraria al comune buonsenso, dal momento che essi si danno industriosamente da fare per delle cose indifferenti e invece sono indifferenti alla presenza e all’assenza di grandi beni?
§ 8. [1061E] Un’altra dottrina contraria ai concetti di comune buonsenso è che lo Stoico, il quale è pur sempre un uomo, non si rallegri quando abbia fatto il passaggio dai più grandi mali ai più grandi beni. Questo infatti sperimenta il sapiente Stoico: giacché quando egli si trasforma passando dal colmo del vizio al colmo della virtù e sfugge la più meschina delle vite mentre acquisisce la più beata, una così enorme trasformazione non comporta alcun segno manifesto di gioia, non lo esalta e non lo smuove pur se egli si è allontanato da ogni sorta di infelicità e di depravazione ed è pervenuto al sicuro e saldo culmine dei beni. Inoltre è contrario al comune buonsenso che l’immutabilità e la saldezza delle determinazioni sia il massimo dei beni, ma che chi si muove [1061F] verso la vetta del progresso morale non abbia bisogno di ciò né gli dia importanza quando gli è presente; e che spesso egli non protenda neppure un dito al fine di ottenere questa sicurezza e questa saldezza da loro legittimata come un bene grande e perfetto. I nostri Stoici non dicono soltanto questo, ma affermano pure che l’aggiunta del tempo non accresce il bene, [1062A] e che se uno sarà saggio anche per un solo istante in nulla resterà indietro, quanto a felicità, rispetto a chi eternamente usa virtù ed in essa beatamente vive. Dopo avere con così giovanile baldanza insistito su ciò, essi però poi affermano che una virtù di breve durata non è di alcun pro: “Che pro, infatti, viene a colui cui la saggezza sopravverrà mentre è sul punto di naufragare o di essere gettato in un precipizio? Che pro per Lica, se egli muterà dal vizio alla virtù nell’attimo in cui è scagliato in mare da Eracle come il sasso da una fionda?”. Queste sono tesi non soltanto in contrasto con i concetti di comune buonsenso, ma di filosofi che fanno un guazzabuglio delle loro stesse dottrine, quando ritengono che il possedere per breve tempo la virtù non sia cosa da meno del colmo della felicità e [1062B] contemporaneamente che questo breve possesso non abbia assolutamente alcun valore.
§ 9. Ciò che degli Stoici ti stupirebbe in particolar modo non è comunque questo, bensì la loro credenza che quando virtù e felicità sono diventate presenti, chi ne entra in possesso spesso non ne ha contezza e rimane all’oscuro del fatto che se poco prima egli era la persona più meschina e più stolta, del pari adesso è diventato una persona saggia e beata. È del tutto inconsistente, infatti, non soltanto che il saggio sia l’unico a non tenere in pregio proprio questo, ossia l’essere saggio, e che non riconosca la scomparsa della sua ignoranza; ma anche che, per dirla tutta, gli Stoici facciano del bene qualcosa privo di peso, qualcosa di evanescente, visto che quando esso si è reso presente non genera la sensazione di se stesso. Secondo gli Stoici, infatti, esso non è per natura impercepibile; [1062C] e Crisippo afferma in termini precisi nei libri ‘Sul sommo bene’ che il bene è un’entità sensibile e, com’egli crede, lo dimostra anche. Pertanto, qualora la presenza del bene rimanga ignorata e non percepita da coloro che lo possiedono, la sola spiegazione che rimane è che esso sfugga alla percezione dei sensi a causa della sua debolezza e piccolezza. Inoltre, se è assurdo ritenere che degli oggetti bianchissimi sfuggano alla vista che percepisce la presenza di oggetti debolmente e moderatamente bianchi, e che il tatto che rileva la presenza di oggetti tiepidi e tenuemente caldi sia insensibile alla presenza di quelli caldissimi; è ancora più assurdo che una persona la quale ha il concetto di cosa il comune buonsenso ritiene essere secondo natura, ad esempio la salute e la buona complessione fisica, [1062D] ignori però la presenza della virtù, che gli Stoici pongono quale cosa specialmente ed eminentemente secondo natura. Come può non essere contrario al buonsenso l’afferrare la differenza tra la salute e la malattia e però non afferrare quella tra la saggezza e la stoltezza, e invece credere presente quella che si è allontanata e ignorare che è presente quella che si possiede? Ora, poiché gli Stoici sostengono che è al colmo del progresso morale che gli uomini vanno incontro a quella trasformazione che li fa diventare felici e virtuosi, necessariamente delle due l’una: o il progresso morale è né vizio né infelicità, oppure la virtù non si diversifica molto dal vizio né la felicità dall’infelicità, ed è piccola ed insensibile la differenza tra i mali e i beni; [1062E] giacché altrimenti agli uomini non sfuggirebbe di avere gli uni invece degli altri.
§ 10. Qualora gli Stoici non vogliano abiurare nessuna delle loro proposizioni contraddittorie ed insistano invece ad asserire che esse sono tutte coerenti: ossia che coloro i quali stanno facendo progressi sono dissennati e viziosi; che coloro i quali sono saggi e virtuosi non hanno contezza di esserlo; che esiste una grande differenza tra la saggezza e la stoltezza: ebbene ti sembra forse che in questo modo essi stiano rinsaldando splendidamente l’intrinseca coerenza teorica della loro dottrina? Ed inoltre che la stiano rinsaldando soprattutto nei fatti, quando dichiarano che i non sapienti sono tutti altrettanto viziosi, ingiusti, sleali e stolti; e invece alcuni di costoro [1062F] li scansano, ne provano disgusto, quando li incontrano non rivolgono loro la parola; mentre ad altri danno in gestione del denaro, affidano incarichi di comando, danno in spose le figlie? Se queste cose gli Stoici le dicono per scherzo, allora che abbassino il loro cipiglio. Se le dicono sul serio e ne fanno la loro filosofia, allora è contrario ai concetti di comune buonsenso [1063A] il denigrare e vilipendere similmente tutti gli uomini e poi trattarne alcuni come persone equilibrate ed altre come sentine dei peggiori vizi; essere colmi di ammirazione per Crisippo e invece ridicolizzare Alessino; credere che tutti gli uomini siano fuori di testa né di più né di meno uno dell’altro. “Sì” essi dicono, “ma come chi è un braccio al di sotto della superficie del mare annega non meno di chi è affondato cinquecento tese, così coloro che stanno approssimandosi alla virtù sono non meno nel vizio di coloro che ne sono ben lungi. E come i ciechi sono ciechi anche qualora siano sul punto di recuperare poco dopo la vista, così i progredenti restano dissennati e depravati fino a che non apprendano la virtù”. [1063B] Che coloro i quali stanno facendo progressi non somiglino a ciechi bensì a gente che ci vede di meno, né a gente annegata bensì a dei nuotatori prossimi ad arrivare in porto, lo testimoniano gli Stoici stessi nella loro pratica. Essi, infatti, non utilizzerebbero consiglieri, generali, legislatori per farsi condurre per mano da dei ciechi e non emulerebbero le opere, le azioni, i discorsi, le vite di taluni uomini se li vedessero tutti annegati allo stesso modo nella stoltezza e nella depravazione. A parte ciò, stupisciti pure del modo in cui neppure dai paradigmi della loro stessa dottrina gli Stoici imparano a buttare nella spazzatura quei sapienti a loro insaputa, che sono sapienti anche se non capiscono né si rendono conto [1063C] che hanno cessato di annegare, che vedono della luce, che sono diventati superiori al vizio e che sono tornati a respirare.
§ 11. È contro il comune buonsenso pensare che per un uomo al quale sono presenti tutti i beni e al quale nulla manca di ciò che serve per la felicità e la beatitudine, sia doveroso suicidarsi se non gli sopravverrà qualcuna delle cose che sono, per Zeus, indifferenti; ed ancor più pensare che un uomo il quale non possiede né possiederà mai alcun bene e cui anzi sono presenti e saranno presenti fino alla fine tutte le cose più terribili, più spiacevoli e tutti i mali, sia doveroso non sciogliersi dalla vita. Eppure, questa è la legislazione vigente nella Stoa; e gli Stoici suggeriscono a molti saggi di trapassar di vita, giudicando meglio cessare di vivere mentre si è felici. Rattengono invece in vita molti insipienti, giudicando per loro doveroso che vivano essendo infelici. [1063D] Eppure il sapiente è opulento dei veri beni, beato, interamente felice, sicuro, al riparo dai pericoli; mentre l’insipiente è invece tanto dissennato da poter dire:
‘trabocco di mali e non v’è più dove se ne possano mettere’.
Nonostante questo, gli Stoici credono che per costoro sia doverosa la permanenza in vita e invece, per quegli altri, che lo sia il trapassar di vita. “E ciò è verosimile” afferma Crisippo, “giacché la vita non va parametrata ai beni e ai mali ma a ciò ch’è secondo la natura delle cose ed a ciò ch’è contro la natura delle cose”. Questo è il modo in cui gli Stoici salvaguardano la comune consuetudine di fiducia nelle sensazioni e praticano una filosofia che sostengono sia conforme ai concetti di comune buonsenso. Che ne dici? Colui che prende in considerazione le questioni di vita e di morte non deve considerare
‘quel che di cattivo e di buono c’è nella magione’
ed appurare, come mettendole su una bilancia, [1063E] quali siano le cose distintive che più giovano alla felicità o all’infelicità? Oppure deve fare i conti circa il continuare a vivere o meno, sulla base delle cose che né giovano né danneggiano? Dinanzi a siffatta alternativa fondamentale, chi sceglierà come doverosa per sé la vita alla quale non manca una sola delle cose da evitare; e rifuggirà la vita nella quale sono presenti tutte le cose che meritano d’essere scelte? Eppure, mio caro compagno, se è illogico rifuggire la vita quando non si sia incappati in alcun male, ancora più illogico è il buttar via il bene perché non s’è ottenuto qualcosa che è di per sé indifferente: come fanno gli Stoici i quali, buttano nella spazzatura [1063F] la felicità e la virtù presente in cambio di una salute e di una integrità del corpo che neppure ottengono.
‘Allora, però, il Cronide Zeus tolse a Glauco il senno’
poiché egli stava per scambiare armi d’oro del valore di cento buoi con armi di bronzo del valore di nove buoi soltanto. Eppure le armi di bronzo erano di utilità ai combattenti non meno di quelle d’oro, mentre invece né la bella apparenza del corpo né la salute sono secondo gli Stoici di utilità alcuna né di alcun conforto in vista della felicità: [1064A] e nonostante ciò essi sono disposti a permutare la saggezza con la salute. Anche per Eraclito e Ferecide, essi affermano, sarebbe stato doveroso, se l’avessero potuto, tralasciare virtù e saggezza pur di disfarsi dei pidocchi e dell’idropisia. E di Circe che mescesse due farmaci, uno che rendeva stolti i saggi lasciando loro l’aspetto umano; e un altro che trasformava gli uomini in asini saggi, ad Odisseo sarebbe convenuto bere il farmaco che rendeva stolti piuttosto che mutare forma e prendere aspetto animale pur conservando la saggezza, ed evidentemente insieme con la saggezza anche la felicità. Essi affermano poi che la saggezza stessa lo fa capire e lo dice quando esorta: [1064B] “Lasciami e spregiami pure, dal momento che vado in malora e mi rovino prendendo l’aspetto di un asino”. Ma, dirà qualcuno, se la saggezza e la felicità sono un bene, e invece l’andarsene in giro con un brutto aspetto è cosa indifferente, la saggezza che prescrive una cosa del genere è la saggezza di un asino. Si dice che esista una popolazione Etiope presso la quale a regnare è un cane, che ha l’appellativo di re ed ha diritto alla parte di bottino e agli onori riservati ad un re; mentre gli uomini effettuano le funzioni spettanti ai capi militari e ai magistrati delle città. In modo simile, non è forse vero che per gli Stoici il nome e il rango di ‘bene’ appartengono alla virtù, che soltanto la virtù essi chiamano degna di scelta, giovevole ed utile; e che poi però essi tutto effettuano, [1064C] e filosofano, e vivono e muoiono come se obbedissero alle ingiunzioni delle cose indifferenti? Eppure mentre nessun Etiope uccide quel regale cane, ed esso siede solennemente sul trono mentre loro gli si prostrano innanzi, gli Stoici mandano in malora e rovinano la loro stessa virtù, aggrappandosi unicamente alla salute e all’assenza di dolore fisico.
§ 12. Il tocco finale che Crisippo stesso ha apposto alle sue dottrine sembra dispensarci dalla necessità di aggiungere ulteriori parole sull’argomento. Giacché esistendo in natura dei beni, dei mali, e delle cose che stanno frammezzo a questi e che sono chiamate indifferenti: [1064D] non c’è uomo il quale non voglia il bene piuttosto che l’indifferente e <l’indifferente piuttosto che> il male. Di ciò facciamo testimoni anche gli dei, giacché con le nostre preghiere noi chiediamo di ottenere da loro soprattutto il possesso dei beni e, se ciò non è fattibile, di poter sfuggire ai mali; e non vogliamo ottenere ciò ch’è né bene né male al posto del bene, mentre lo vogliamo ottenere al posto del male. Crisippo invece, capovolgendo la natura e rivoltando l’ordine delle cose, trasloca ciò ch’è mediano dal posto centrale e lo pone all’ultimo posto; prende l’ultimo e lo colloca nel posto centrale, come fanno i tiranni i quali danno i posti privilegiati ai malvagi; poi stabilisce per legge che per primo bisogna perseguire il bene, per secondo il male e ritenere ciò ch’è né male né bene [1064E] l’ultima e peggior cosa da perseguire; come se uno ponesse subito dopo le cose celesti quelle dell’Ade e sospingesse la terra e gli astri che le stanno intorno nel Tartaro
‘lontanissimo, dove il baratro sotto la terra è più fondo’.
Nel terzo libro ‘Sulla natura’, dopo avere detto che è vantaggioso vivere da stolto piuttosto che non vivere pur se si dovesse non diventare mai saggio, Crisippo soggiunge testualmente: “Per gli uomini i beni sono siffatti che, in un certo modo, anche i mali vengono per importanza prima delle cose intermedie. Ma quelli che per importanza vengono prima non sono questi ma la ragione, con la quale piuttosto spetta a noi vivere anche se saremo stolti”; il che manifestamente significa: anche se saremo ingiusti, fuorilegge, nemici degli dei e infelici, [1064F] giacché nessuna di queste caratteristiche manca a coloro che vivono da stolti. Secondo Crisippo agli uomini spetta dunque essere infelici piuttosto che non esserlo, subire danno piuttosto che non subirlo, commettere ingiustizie piuttosto che non commetterle e trasgredire la legge piuttosto che non trasgredirla: cioè spetta fare ciò che spetta non fare, ed è doveroso vivere anche in contrasto con ciò ch’è doveroso? “Sì, giacché è peggio essere privi di ragione ed insensibili piuttosto che essere stolti”. Dopodiché, sperimentando tutti questi mali, perché gli Stoici non ammettono che vi è un male peggiore del male? Perché dichiarano che il solo male da fuggirsi è la stoltezza, [1065A] se quella che ci spetta fuggire di più e non di meno, è la disposizione che non accoglie la stoltezza quale sua condizione permanente?
§ 13. Ma chi se la prenderebbe a male per queste parole, se appena costui ricorda quelle che Crisippo ha scritto nel secondo libro ‘Sulla natura’ e con le quali dichiara che la generazione del vizio non è stata improficua per il cosmo nella sua interezza? Merita apprendere questa teoria dalle parole di Crisippo stesso, affinché tu impari quale posto riservano al vizio e quali ragionamenti pronunciano su di esso coloro i quali accusano Senocrate e Speusippo di non ritenere la salute un indifferente e la ricchezza una cosa del tutto futile: “Rispetto alle pur terribili disavventure accidentali, il vizio ha una sua peculiare ragione, giacché anch’esso nasce [1065B] in un certo senso in armonia con la ragione della natura e, per dir così, non è improficuo in relazione al cosmo nella sua interezza, dal momento che altrimenti non esisterebbero neppure le opere virtuose”. Pertanto negli dei non esiste alcun bene poiché neppure esiste alcun male. E qualora Zeus abbia risolto in sé tutta la materia diventando l’Uno ed eliminando ogni differenza, non essendo presente alcun male, anche allora non c’è alcun bene. Ma il canto di un coro è ben intonato quando nessuno dei suoi membri stona, e la salute del corpo si ha quando nessuno dei suoi pezzi è malato. Invece la virtù non ha genesi senza il vizio. E come il veleno del serpente e il fiele della iena sono necessari in taluni dei rimedi medici, [1065C] così l’idoneità di Meleto alla depravazione era funzionale alla giustizia di Socrate, e l’idoneità di Cleone all’improntitudine era funzionale alla virtuosità di Pericle. E come avrebbe potuto Zeus trovare il modo di far nascere Eracle e Licurgo, se non avesse fatto nascere per noi anche Sardanapalo e Falaride? È ora che gli stoici dicano che la tisi viene all’uomo per migliorarne la complessione e la podagra per farlo correre più veloce, e che Achille non avrebbe una folta chioma se Tersite non fosse calvo. In cosa differiscono da questi vaneggiamenti e da queste chiacchiere, quanti affermano che l’impudenza non è senza proficuità per la padronanza di sé e l’ingiustizia per la giustizia? A questo fine [1065D] preghiamo allora gli dei che esistano sempre la depravazione
‘le menzogne, i discorsi insinuanti e il carattere astuto e ingannevole’
giacché se queste cose spariscono la virtù si dilegua e va in rovina.
§ 14. Vuoi essere messo al corrente della straordinaria finezza di Crisippo e della sua capacità persuasiva? Ecco quel che dice: “Come le commedie contengono delle battute ridicole che di per sé sono triviali ma conferiscono una certa grazia all’opera nel suo insieme, così il vizio di per se stesso tu lo denigreresti, ma esso non è senza proficuità per il cosmo nella sua interezza”. In primo luogo, che il vizio sia venuto al mondo per opera della provvidenza divina, come la battuta triviale per volontà del suo autore, è qualcosa che va al di là di ogni immaginabile assurdità. [1065E] Perché mai, allora, gli dei saranno dispensatori più di beni che di mali? Come potrà più il vizio essere nemico agli dei e ad essi inviso? Cosa avremo noi più da dire contro blasfemie di questo genere:
‘il dio tra i mortali fa germogliare una colpa,
quando voglia assolutamente far del male ad un casato’
ed anche
‘e quale degli dei fece venire a contesa e combattersi i due?’
In secondo luogo, la battuta triviale abbellisce la commedia e coopera all’ottenimento del suo fine, giacché essa mira a far ridere o comunque a gratificare gli spettatori. Ma Zeus padreterno, sommo signore, giusto giudice e, secondo Pindaro, artefice sopraffino, creando il cosmo non come un grande, intricato e sensazionale spettacolo teatrale, [1065F] bensì come una città comune di dei e di uomini che vivranno insieme con giustizia e virtù, concordemente e beatamente: ebbene, per questo bellissimo e solennissimo fine perché avrebbe avuto bisogno di pirati, di omicidi, di parricidi e di tiranni? Il vizio non è nato quale elegante interludio gradito alla divinità; [1066A] e non è per la sua inconsistenza, perché fa ridere, perché è una buffonata che l’ingiustizia si è appiccicata alle faccende umane: vizio e ingiustizia a causa dei quali non ci è possibile vedere neppure il sogno della coerenza con la natura cui inneggiano gli Stoici. Inoltre, la battuta triviale è soltanto una frazione dell’opera, occupa comunque un piccolo spazio nella commedia e i versi che le contengono non abbondano né rovinano o guastano la grazia dei versi che appaiono ben scritti. Del vizio sono invece zeppe tutte le faccende umane; e tutta la vita, subito dalla prima entrata in scena fino al suo coronamento, indecente com’è, degenerata, piena di sconcerti, priva di una qualunque parte pulita e irreprensibile, come dicono gli Stoici, [1066B] è di tutti i drammi il più vergognoso e il più sgradevole.
§ 15. Laonde io chiederei con piacere di sapere da Crisippo per che cosa il vizio sia stato proficuo al cosmo nella sua interezza. Egli certo non dirà che lo è stato per le cose celesti e divine. Sarebbe infatti ridicolo sostenere che se tra gli uomini non fossero nati e non esistessero il vizio, l’insaziabilità, la menzogna e se noi non ci recassimo a vicenda danni e rovine, non ci calunniassimo e ci uccidessimo, il sole non percorrerebbe il suo corso ordinato, il cosmo non utilizzerebbe le sue divisioni di tempo e i suoi cicli periodici, e la terra, la quale occupa il centro dell’universo, non darebbe principio ai venti e alle piogge. Rimane quindi la possibilità che il vizio sia nato per essere proficuo a noi e alle nostre cose: e forse è questo che gli Stoici affermano. [1066C] Siamo noi forse più in salute o abbiamo maggiore abbondanza delle cose che ci sono necessarie perché siamo viziosi? Il vizio è stato proficuo in vista della nostra bellezza o della nostra prestanza fisica? Gli Stoici dicono di no. Dove sta allora la proficuità del vizio su questa terra? Oppure il vizio è ‘soltanto un nome e una vacua sembianza di visioni notturne’? Ma il vizio è una visione ben reale che sta davanti a tutti ed è chiara agli occhi di tutti; e nulla c’è che sia meno proficuo del vizio per condividere qualcosa con la virtù, per gli dei, per la quale invece siamo nati. E poi non è strano che mentre le cose proficue all’agricoltore, al pilota e all’auriga sono favorevoli e cooperano al raggiungimento del fine di ciascuno di loro, ciò che il dio ha generato per la virtù ha invece rovinato e distrutto la virtù? [1066D] Ma forse è ormai tempo di volgersi ad un altro argomento e lasciare da parte questo.
§ 16. UN COMPAGNO. Per amor mio, caro amico, non farlo. Smanio dalla voglia di sapere in che modo i signori Stoici possano dare la precedenza ai mali rispetto ai beni, e al vizio rispetto alla virtù.
DIADOUMENO. Ne vale, caro compagno, senza dubbio la pena. Dopo molto blablabla, alla fine quel che essi dicono è che la saggezza, essendo scienza dei beni e dei mali, sarebbe integralmente abolita se fossero aboliti i mali; e così come, essendoci il vero, è impossibile che non ci sia anche il falso, similarmente essi credono che, se esistono i beni, conviene che esistano anche i mali.
[1066E] UN COMPAGNO. Di questa loro affermazione io credo che una parte non sia sbagliata; però neppure mi sfugge l’altra. Infatti vedo una differenza tra le due parti, differenza per la quale se ciò ch’è non vero è ipso facto falso, ciò ch’è non bene non è ipso facto male. Laonde mentre nulla c’è di intermedio tra le cose vere e le cose false, le cose indifferenti sono invece intermedie tra i beni e i mali. E dunque non è necessario che questi coesistano con quelli, giacché basterebbe che la natura abbia il bene, non avendo alcun bisogno del male poiché già comprende in sé le cose che sono né bene né male. Se da parte vostra si dice qualcosa contro il ragionamento degli Stoici citato prima, è il caso di ascoltarlo.
§ 17. DIADOUMENO. Sono numerose le critiche che noi facciamo agli Stoici, ma tra di esse dobbiamo ora servirci soltanto di quelle necessarie. In primo luogo è da sempliciotti credere che la genesi dei mali e dei beni, sia la realtà sottostante al progetto di rendere possibile il conseguimento della saggezza. [1066F] Infatti, essendo i beni e i mali delle realtà esistenti di per sé, la saggezza sopravviene allo stesso modo in cui nasce l’arte medica, la quale nasce perché esistono di per sé degli stati di malattia e di salute. Dunque il bene e il male non sono realtà esistenti al fine di far nascere la saggezza, bensì è stata denominata saggezza la capacità grazie alla quale noi distinguiamo ciò ch’è bene e ciò ch’è male in quanto realtà esistenti di per sé. Così è anche nel caso della vista, la quale è il senso capace di percepire e distinguere gli oggetti bianchi da quelli neri. Ma questi oggetti non sono stati creati affinché noi avessimo la vista, bensì piuttosto siamo noi [1067A] che abbiamo bisogno della vista per distinguere gli oggetti di quel genere. In secondo luogo, quando fanno entrare il cosmo in conflagrazione universale, gli Stoici sostengono che esso non si lascia dietro alcun male, e che anzi allora è tutt’intero saggio e sapiente. Dunque la saggezza c’è anche in assenza del male, e non è necessario che esista il male perché sia possibile la saggezza. Comunque, se davvero bisogna assolutamente che la saggezza sia conoscenza certa dei beni e dei mali, cosa c’è di strano nel pensare che, essendo stati eliminati i mali, non ci sarà più la saggezza ma avremo al posto di quella un’altra virtù, che non è più quella dei beni e dei mali ma è la conoscenza certa dei soli beni? È come se tra i colori sparisse completamente il nero e in seguito a ciò uno si sentisse forzato a credere [1067B] che è sparita anche la vista, poiché non c’è più la sensazione degli oggetti bianchi e di quelli neri. Cosa impedisce di dire a costui: non c’è nulla di strano se noi non abbiamo più quella che tu chiami vista, ma al suo posto abbiamo un altro senso della vista, ossia una facoltà con la quale riusciamo a cogliere gli oggetti bianchi e quelli che sono di colori diversi dal bianco? Per parte mia io non credo che il senso del gusto svanirebbe se sparissero le cose amare, né il senso del tatto qualora si eliminassero le sofferenze, né la saggezza se fosse assente il male; ma credo che quei sensi permarrebbero, e con loro permarrebbe la capacità di cogliere le sensazioni delle cose dolci e piacevoli e di quelle che tali non sono; e quella saggezza che è conoscenza certa delle cose che sono beni e di quelle che sono non beni. [1067C] E coloro ai quali così non pare, si portino pure via il nome e lascino a noi la sostanza della faccenda.
§ 18. A parte ciò, cosa impedirebbe che vi sia intellezione del male, ma tanto intellezione che reale esistenza del bene? Così, io credo, accade tra gli dei, per i quali la salute è realtà presente, mentre della febbre e della pleurite essi hanno intellezione; giacché anche noi tutti, cui sono presenti in grande abbondanza i mali e nessun bene, come dicono gli Stoici, non siamo stati incapacitati per natura ad avere la cognizione della saggezza, del bene e della felicità. Stupefacente è anche il fatto che se ci sono coloro i quali insegnano che sorta di cosa è la virtù, pur in sua assenza, e ne infondono l’apprensione certa; allora del vizio, se esso fosse inesistente, neppure sarebbe possibile acquisire l’intellezione. [1067D] Ora, guarda un po’ di cosa vogliono persuaderci coloro i quali affermano che la loro filosofia è in pieno accordo con i concetti di comune buonsenso: che noi comprendiamo cos’è la saggezza solo grazie alla stoltezza, e che la saggezza senza la stoltezza è per natura incapace di comprendere tanto se stessa quanto la stoltezza.
§ 19. Se la natura avesse davvero assolutamente bisogno della genesi del male, uno o due modelli esemplari di vizio sarebbero sufficienti. Oppure, se proprio vuoi, dovrebbero esserci al mondo dieci, o mille o diecimila uomini malvagi, ma non esserci una profusione del vizio la cui moltitudine è tale che
‘i granelli di sabbia o la polvere o le piume degli uccelli dai variegati colori
non si innalzerebbero ad un numero così grande’,
mentre della virtù non c’è traccia neppure in sogno. [1067E] A Sparta i curatori incaricati delle mense comuni introducono a bella posta al banchetto due o tre iloti che hanno bevuto smodate quantità di vino puro e che quindi sono ubriachi, ed in questo modo mostrano ai giovani Spartani cosa voglia dire ubriacarsi, allo scopo che essi se ne tengano alla larga e siano temperanti. Nella vita la maggior parte delle nostre abitudini sono diventate modelli esemplari di vizio e neppure uno di noi è sobrio ed ha di mira la virtù, bensì camminiamo tutti ciondolando, ci comportiamo in modo indecente e siamo in preda all’infelicità. Essendo noi a questo punto, il discorso degli Stoici ci inebria, ci riempie di grande agitazione, ci fa vaneggiare così come avvenne alle cagne che, secondo il racconto di Esopo, mirando a cibarsi di certe pelli che galleggiavano sul mare, cominciarono a berlo, [1067F] col risultato di scoppiare prima di riuscire ad addentare quelle. Infatti noi speriamo di diventare in futuro felici grazie alla ragione e di essere da essa portati alla virtù, ma purtroppo essa ci ha già rovinato e distrutto ben prima di raggiungere la virtù, sovraccarichi come siamo di tanta pura ed amara viziosità; se è vero, come dicono gli Stoici, che anche per coloro i quali sono all’apice del progresso morale non c’è alleggerimento, non c’è sollievo, non c’è respiro dalla scempiaggine e dall’infelicità.
§ 20. [1068A] Colui il quale afferma che la genesi del vizio non è stata affatto improficua, guarda un po’ quale dimostrazione dà del fatto che per i viziosi esso è un bene utile e stabile. Infatti, nei libri ‘Sulle azioni rette’ Crisippo scrive: “Il vizioso non ha bisogno di nulla e non manca di nulla. Nulla gli è proficuo, nulla gli è appropriato, nulla gli è acconcio”. Come potrebbe dunque essere profittevole il vizio, in compagnia del quale neppure la salute è proficua, né lo sono la ricchezza di denaro né il progresso morale? Non si ha alcun bisogno di quelle cose che sono indifferenti promossi, di quelle che sono cose prendibili se offerte, di quelle che sono, per Zeus, profittevoli, e di altre che sono secondo natura, come le chiamano gli Stoici? E poi di queste cose nessuno ha bisogno, a meno che non sia diventato sapiente? Dunque il vizioso neppure ha bisogno di diventare sapiente. [1068B] Ma gli uomini non hanno sete e non hanno fame anche prima di diventare sapienti? E se hanno sete non hanno bisogno d’acqua, e di pane se hanno fame?
‘Voi siete simili ad ospiti miti
che approfittano soltanto di un tetto e del fuoco’.
Quest’uomo non ha mai avuto bisogno di ospitalità? Né di un mantello quell’uomo che dice:
‘Date un mantello a Ipponatte, perché ho i brividi per il freddo’.
Tu però vuoi dire qualcosa di paradossale, di straordinario e di originale? Allora dì che il sapiente non ha bisogno di nulla né manca di alcunché. Lui, il sapiente, è opulento dei veri beni, lui è il non bisognoso, lui è autosufficiente, beato, perfetto. Ora, che vertigine è mai questa, [1068C] per la quale chi di nulla è carente ha però bisogno dei beni che possiede; mentre il vizioso, che è carente di molte cose, di nulla ha bisogno? Questo infatti dice Crisippo, ossia che: “I viziosi non hanno bisogni e però sono carenti di molte cose”. Tu rialloghi i concetti di comune buonsenso come se si trattasse dei pezzi su una scacchiera. Infatti, tutti gli uomini legittimano l’idea che l’avere bisogno di qualcosa venga prima dell’esserne carente, ritenendo che sia carente colui il quale ha bisogno di cose che non ha a disposizione né può facilmente procurarsi. Pertanto nessun uomo è carente di corna o di ali, giacché di esse egli neppure ha bisogno; e invece diciamo che gli uomini sono carenti di armi, di denaro e di vestiti quando essi, giunti ad averne bisogno, non avendoli neppure riescano a procurarseli. Gli Stoici però smaniano a tal punto di apparire sempre coloro che dicono [1068D] cose contrarie ai concetti di comune buonsenso, che spesso si dipartono dalle loro stesse dottrine per smania di dire delle novità, come in questo caso.
§ 21. Adesso cerca di portarti più in alto e considera un poco questo. Una delle affermazioni che si fanno e che è contraria ai concetti di comune buonsenso, è che nessun vizioso può ricevere un giovamento. Eppure molti di noi quando siano educati fanno dei progressi, se sono schiavi vengono liberati, se sono assediati si salvano, se sono storpi vengono condotti per mano e se sono ammalati sono curati. “Ma quando capitino loro queste cose i viziosi non ne traggono giovamento né sperimentano alcunché di positivo, e neppure hanno benefattori né li trascurano”. Quindi i viziosi non sono ingrati, e invero neppure gli uomini assennati lo sono. [1068E] Dunque l’ingratitudine è inesistente, giacché questi ultimi non mancano di gratitudine quando ricevano una grazia, mentre i primi non sono nati per ricevere una grazia. Ora, guarda cosa dicono al riguardo gli Stoici. Essi affermano che la gratitudine pertiene agli atti intermedi e che il giovare ed il trarre giovamento è proprio dei sapienti, mentre capita anche ai viziosi di essere riconoscenti e grati. In tal caso coloro ai quali spetta essere grati non sono coloro ai quali è toccata un’utilità? E quando ci si mostra grati, non è in riferimento a qualcosa di proficuo per noi personalmente? Cos’altro rende un servigio un fatto degno di gratitudine, se non che chi ha reso quel servigio ha fatto una cosa profittevole a chi ne aveva bisogno?
§ 22. UN COMPAGNO. Per ora mettiamo da parte queste questioni. Cos’è, invece, questo tanto decantato giovamento [1068F] che gli Stoici riservano ai sapienti quale loro grande ed esclusivo appannaggio, non concedendo ai non sapienti neppure l’uso di tale nome?
DIADOUMENO. Se mai un solo sapiente, dove che sia, protenderà un dito a motivo della sua saggezza, tutti i sapienti in giro per il mondo ne traggono giovamento. Ciò è opera dell’amicizia tra di loro e questa è l’opera che le virtù dei sapienti portano a compimento con i comuni giovamenti che essi si recano. [1069A] Vaneggiava dunque Aristotele, vaneggiava Senocrate quando dichiaravano che gli uomini traggono giovamento dagli dei, traggono giovamento dai genitori, traggono giovamento dai maestri, perché ignoravano lo stupefacente giovamento col quale i sapienti si giovano l’un l’altro muovendosi secondo virtù, anche nel caso non siano insieme e capiti che non si conoscano. Invero, qualora si tratti di cose proficue e giovevoli, tutti gli uomini concepiscono come proficue e giovevoli le azioni di selezione, di conservazione e di amministrazione di esse; e il riccone fa comperare delle chiavi, [1069B] fa sorvegliare i suoi magazzini ma:
‘la dilettissima cassaforte la disserra con la sua propria mano’.
Invece il fare opera di selezione su cose che sono per nulla giovevoli, il conservarle con cura ed a costo di grandi fatiche è un’azione né solenne né bella, ma del tutto ridicola. Se dunque Odisseo, che aveva imparato da Circe a fare quello speciale nodo, avesse con esso suggellato nell’arca non i doni ricevuti da Alcinoo: tripodi, bacili, vesti preziose, oro; bensì dello strame, dei sassi e dopo avere messo insieme altri oggetti del genere avesse ritenuto il loro trattamento, la loro acquisizione e la loro conservazione un’opera conducente alla felicità e beata: chi avrebbe inteso emulare una tale dissennata previdenza e una così frivola diligenza? [1069C] Ma questo è proprio il bello, il solenne, il beato della Stoica coerenza con la natura: null’altro che la selezione e la conservazione delle cose del tutto futili e indifferenti. Giacché siffatti sono gli indifferenti secondo natura e ancor più gli oggetti esterni; se appunto gli Stoici paragonano la più grande ricchezza di denaro a frange dorate e pitali d’oro e, quando loro capiti, per Zeus, pure a delle fiaschette. Poi, come coloro i quali pensano bene di oltraggiare e di ingiuriare in modo oltracotante gli altari di certi dei o di certi demoni, ma appena cambiano opinione subito si prostrano, si fanno piccini piccini e si sperticano in lodi del divino e ne esaltano la grandezza; così gli Stoici i quali fanno un gran baccano urlando che la sola cosa nobile, bella, solenne è la selezione e l’amministrazione delle cose indifferenti, quando incappano in una sorta di nemesi per questa loro iattanza [1069D] e il loro vuoto parlare sono a loro volta smentiti proprio da queste cose indifferenti e che per loro sono di nessun valore, giacché non ottenendole dichiarano che la vita non è più degna di essere vissuta e che, pur esprimendo molti ringraziamenti alla virtù, è però meglio tagliarsi la gola o lasciarsi morire di inedia. E quindi gli Stoici ritengono Teognide una persona infame e piccina perché afferma:
‘Per fuggire la povertà di denaro è d’uopo anche gettarsi
nello smisurato mare e da rupi scoscese, o Cirno’
e fa così [1069E] il codardo davanti alla povertà di denaro, che è invece una cosa indifferente. Ma essi prescrivono con un discorso terra terra le stesse identiche cose, dicendo che quando si tratta di fuggire una malattia grave e una sofferenza intensa, delle quali né l’una né l’altra sono cose dannose, né sono un male, e neppure cose sconvenienti né rendono infelici coloro che vi incappano, se non si ha a disposizione una spada o della cicuta, è d’uopo buttarsi in mare o gettarsi giù dalle rocce.
§ 23. Crisippo dice: “Da dove, dunque, comincerò? E quale principio di ciò ch’è doveroso e quale materiale della virtù prendere, se tralascio la natura e ciò ch’è secondo natura?” Da dove cominciano Aristotele, mio caro, e Teofrasto? E cosa prendono quali principi Senocrate e Polemone? E Zenone non seguì forse costoro [1069F] che suggerivano la natura e l’armonia con la natura quali elementi della felicità? Tuttavia quei maestri rimasero fermamente dell’idea che degne di scelta, buone e giovevoli sono le cose secondo natura. Aggiunsero inoltre che la virtù operava con esse, utilizzandone ciascuna in modo appropriato; e credevano che a partire da esse si potesse completare e conchiudere una vita perfetta ed integra, restituendoci così una coerenza con la natura che alla natura è davvero conforme e consona. Essi non propugnavano la sconcertante confusione di coloro che fanno salti per aria e poi ricadono di nuovo a terra denominando le medesime cose, [1070A] come cose che possono essere prese se offerte ma che possono essere non scelte; appropriate ma non beni; del tutto futili ma profittevoli; cose che sono nulla in relazione a noi ma che sono fondamenti di quanto è doveroso. Invece, quale era la dottrina tale era la vita di quei maestri, ed essi facevano sì che le loro azioni fossero esattamente corrispondenti ed in armonia con i discorsi che facevano. Invece la scelta degli Stoici è come quella della donna di cui Archiloco dice:
‘con una mano portava dell’acqua,
quella meditatrice di inganni, e con l’altra del fuoco’,
giacché con alcune delle loro dottrine essi mettono in primo piano la natura, mentre con altre la spingono fuori scena; e soprattutto quando si tratta di opere e di faccende pratiche essi tengono per buone e degne di scelta le cose secondo natura, ma quando si tratta di nomi e di frasi le cose secondo natura essi le rigettano e le coprono di fango come indifferenti, improficue e [1070B] prive di peso per il conseguimento della felicità.
§ 24. Poiché tutti gli uomini senza distinzione alcuna concepiscono il bene come qualcosa di rallegrante, auspicabile, fortunato, dotato di grandissimo valore, autosufficiente e bisognoso di nulla: mettigli accanto il bene come lo concepiscono gli Stoici e guardalo. Protendere il dito a motivo della propria saggezza è forse ‘rallegrante’? Cosa? È ‘auspicabile’ una saggia tortura? È ‘fortunato’ chi si butta in un precipizio ragionevolmente? È ‘di grandissimo valore’ ciò che spesso la ragione sceglie di abbandonare invece di abbandonare ciò che un bene non è? È perfetto e ‘autosufficiente’ quel bene pur in presenza del quale gli Stoici, qualora non ottengano delle cose indifferenti, né vogliono né sopportano più di vivere? C’è mai stata al mondo un’altra dottrina dalla quale la comune consuetudine di fiducia nelle sensazioni sia stata più ingiustamente maltrattata, [1070C] che le abbia portato via e strappato dal seno, quali figli legittimi, i genuini concetti di comune buonsenso e gliene abbia attaccati altri, figli bastardi, concetti bestiali e d’altra specie, costringendola ad allevare ed a nutrire affetto per questi invece che per quelli? E tutto ciò è avvenuto nell’ambito delle questioni riguardanti i beni e i mali, ciò ch’è degno di scelta e ciò ch’è da fuggirsi, ciò ch’è nostro proprio e ciò ch’è allotrio: tutte cose nelle quali ci dovrebbe essere un’evidenza ancor più luminosa di quella riguardante le cose calde e fredde, e le bianche e le nere. Le rappresentazioni di queste ultime, infatti, si fanno strada e diventano sensazioni provenendo dall’esterno, mentre le rappresentazioni dei beni e dei mali hanno una genesi da principi che sono in noi connaturati. Gli Stoici, tuttavia, affrontando la discussione sulla felicità armati di quella dialettica [1070D] con la quale affrontano i ragionamenti sul ‘Mentitore’ e sul ‘Dominatore’, non hanno risolto alcuna ambiguità ed anzi ne hanno introdotto miriadi.
§ 25. Nessuno ignora che di due beni: il ‘fine’ e ‘ciò che mira al fine’; il maggiore e più perfetto è il ‘fine’. Anche Crisippo riconosce questa differenza, come è manifesto nel terzo libro ‘Sui beni’, quando egli dissente dall’opinione di coloro che ritengono essere la scienza il ‘fine’ e stabilisce che essa è un bene in vista di un fine e per ciò stesso non è un fine. Nei libri ‘Sulla giustizia’ Crisippo non crede che si possa salvaguardare la giustizia se si suggerisse che il piacere della carne è il ‘fine’, mentre crede che ciò sia possibile se si suggerisse che esso è non il fine ma semplicemente un ‘bene’. E non credo che tu abbia bisogno di udirmi esporre le sue parole, dal momento che il terzo dei suoi libri ‘Sulla giustizia’ [1070E] è disponibile dovunque. Pertanto, amico caro, qualora gli Stoici ripetano che nessun bene è più grande o più piccolo di un altro bene, ma che quello che non è il fine è pari al fine, essi si mostrano in contraddizione non soltanto con i concetti di comune buonsenso ma anche con le loro stesse dottrine. Inoltre, se ci sono due mali a causa di uno dei quali noi diventiamo peggiori qualora esso divenga presente, mentre l’altro ci danneggia sì ma non ci rende peggiori: è contro il comune buonsenso affermare che il male a causa del quale noi diventiamo peggiori sia non maggiore di quello che ci reca danno ma non ci rende peggiori, e negare che sia più funesto il danno che risulta renderci più malvagi. E Crisippo ammette che vi sono certe paure, afflizioni, inganni i quali ci danneggiano, ma che non ci rendono peggiori. Leggi a caso il primo dei libri scritti da lui contro Platone [1070F] ‘Sulla giustizia’ giacché, anche per altri motivi, merita investigare lì la speciosità dell’uomo, una speciosità che schiettamente non ha riguardo per i fatti e per i giudizi, sia propri che altrui.
§ 26. È contro il comune buonsenso sostenere che la vita abbia due fini o scopi e che il riferimento di tutte le azioni che noi effettuiamo non sia ad uno solo di essi. [1071A] Ancor più contrario al comune buonsenso è credere che il fine sia una certa cosa, e che invece ciascuna delle nostre azioni faccia riferimento a qualcos’altro; ed è necessario che gli Stoici accettino di scegliere o l’una o l’altra di queste alternative. Se infatti le cose per natura primarie sono non beni, ed invece lo sono la loro selezione razionale e la nostra presa di possesso di esse, e che ciascuno faccia tutto ciò che può per centrare le cose per natura primarie, allora bisogna che tutte le nostre azioni facciano riferimento a quello scopo che è il centrare le cose per natura primarie. Non sarebbe infatti possibile avere il fine di centrarle se noi non le tenessimo come bersaglio e non le prendessimo di mira, e qualora il sommo bene fosse diverso dalle cose alle quali le nostre azioni devono fare riferimento, ossia se avessimo di mira la loro selezione e non le cose per natura primarie in quanto tali. [1071B] Il sommo bene, insomma, è quello di selezionare e prendere saggiamente possesso delle cose per natura primarie, mentre invece le cose per natura primarie in quanto tali e il centrarle non è il sommo bene, ma una sorta di materiale soggiacente e dotato di un valore degno di selezione. Questa, io credo, è la formulazione con la quale, parlando e scrivendo, essi mostrano la differenza.
UN COMPAGNO. Col coraggio di un vero uomo hai menzionato ciò che gli Stoici dicono e come lo dicono.
DIADOUMENO. Considera che gli Stoici sperimentano la stessa cosa che sperimentano coloro i quali mirano a saltare aldilà della propria ombra, giacché essi non si lasciano affatto alle spalle quell’assurdità che se ne sta distantissima dai concetti di comune buonsenso, ma se la trasportano dietro ben dentro la loro dottrina. Se qualcuno dicesse che un arciere fa tutto ciò ch’è in suo potere non per centrare il bersaglio [1071C] bensì per fare tutto ciò ch’è in suo potere, sembrerebbe uno che fa discorsi mostruosi e simili ad enigmi. Allo stesso modo i rimbambiti i quali vogliono per forza che il fine di mirare alle cose secondo natura non sia quello di ottenere le cose secondo natura bensì quello di prenderle di mira e di selezionarle per noi stessi; i quali vogliono per forza che per ciascuno di noi il mirare alla salute e l’inseguimento di essa non finiscano con il suo ottenimento bensì, tutt’al contrario, che quando si parla di essere in salute ci si riferisca al semplice aver di mira ed inseguire la salute; i quali fanno diventare certe passeggiate, degli esercizi vocali, delle operazioni chirurgiche e pure, per Zeus, l’uso razionale dei farmaci i fini della salute, e non invece la salute il fine di tutte queste azioni: ebbene tutti costoro vaneggiano come colui che dice:
‘orsù mangiamo al fine di sacrificare agli dei, al fine di fare un bagno purificatore’.
[1071D] Il personaggio che recita questo verso altera qualcosa di solito e di legittimato dall’uso capovolgendone l’ordine, mentre le dottrine che gli Stoici sostengono hanno la caratteristica di rappresentare un completo sovvertimento e di introdurre una totale confusione nelle nostre faccende pratiche: “Noi non ci prendiamo la briga di fare una passeggiata al momento opportuno per poter digerire il cibo, bensì digeriamo il cibo per poter fare una passeggiata al momento opportuno”. Senza dubbio, dunque, la natura ha creato la salute per l’uso dell’elleboro e non l’elleboro per ottenere la salute. Cos’altro resta agli Stoici da dire per colmo di paradosso, più che vaneggiare affermazioni di questo genere? Colui il quale afferma che la selezione dei farmaci, la loro composizione e il loro utilizzo sono da scegliersi più della salute stessa, in cosa differisce da chi dice che [1071E] la salute è stata creata per l’uso dei farmaci e non i farmaci per l’ottenimento della salute? E per di più ritiene che la salute non sia il vero oggetto degno d’essere scelto e così pone il fine nel trattamento di quei farmaci, e quindi dichiara che il fine è l’avere di mira il conseguimento e non invece il conseguire ciò che si ha di mira: “Giacché, per Zeus, il ‘razionalmente’ e il ‘saggiamente’ appartengono all’avere di mira”? Noi diremo dunque certamente corretta questa affermazione se lo Stoico intendesse quale fine l’ottenimento e il possesso delle cose che persegue; ma in caso contrario il mirare a qualcosa perde ogni razionalità giacché si riduce semplicemente al fare tutto il possibile per ottenere ciò il cui ottenimento è né solenne né beato.
§ 27. [1071F] Poiché siamo giunti a questo punto del discorso, cosa diresti tu essere più contrario al comune buonsenso del fatto che gli Stoici prendano di mira e perseguano il bene senza avere afferrato e senza attenersi al concetto di buonsenso del bene? Tu vedi, infatti, che anche Crisippo caccia Aristone in questo vicolo cieco, dal momento che i fatti non ci permettono di pensare la ‘indifferenza’ verso ciò ch’è né bene né male, se noi non abbiamo già pensato in precedenza cosa è bene e cosa è male. In tal modo, se è impossibile avere la cognizione di ‘indifferenza’ senza avere prima avuto la cognizione di ciò ch’è ‘bene’, [1072A] l’indifferenza appare preesistere a se stessa: ma allora essa soltanto e null’altro è ‘bene’. Orsù considera come e da dove questa che la Stoa nega essere indifferenza e chiama invece ‘coerenza con la natura’ sia riuscita a far avere di se stessa la cognizione di essere un bene. Se infatti senza la cognizione del bene è impossibile pensare l’indifferenza verso il non bene, a maggior ragione la saggezza in fatto di cose nobili e buone non concede il divisamento di se stessa a coloro che non hanno prima pensato il bene. E come la cognizione dell’arte in fatto di cose salutari e di cose malsane non nasce in coloro i quali non abbiano prima acquisito la cognizione di esse, così non è possibile afferrare il concetto di scienza dei beni e dei mali se non a coloro che hanno prima concepito [1072B] cosa siano i beni e cosa siano i mali.
UN COMPAGNO. E dunque cos’è il bene?
DIADOUMENO. Null’altro che la saggezza.
UN COMPAGNO. E cos’è la saggezza?
DIADOUMENO. Null’altro che la scienza dei beni.
UN COMPAGNO. Dunque molto ‘Corinto, figlio di Zeus’ si è intrufolato nella dottrina degli Stoici.
DIADOUMENO. Lascia stare ‘i giri del pestello nel mortaio’, affinché non paia che tu stia schernendo gli Stoici; seppure si tratta proprio di una malattia simile al ‘Corinto, figlio di Zeus’ quella che affligge la loro dottrina. È infatti evidente che per avere la cognizione del bene, lo Stoico ha bisogno di avere la cognizione della saggezza; e che, a sua volta, ricercando la saggezza nella cognizione del bene, è costretto ad inseguire continuamente l’una e poi l’altra e così finisce per lasciarsi dietro sia la precedente che la seguente, giacché ha bisogno di avere una cognizione precedente, della quale però egli non può avere cognizione se è sprovvisto della seguente. C’è anche un altro modo che permette di discernere a fondo [1072C] non tanto la perversione ma la vera e propria stortura della dottrina degli Stoici, e finalmente il suo ridursi a nulla. Gli Stoici pongono infatti la sostanza del bene nella selezione razionale delle cose che sono secondo natura; e una selezione non è razionale se non avviene in vista di un qualche fine, come è già stato detto in precedenza. Qual è dunque questo fine? Null’altro, essi affermano, che l’operare razionalmente nella selezione delle cose che sono secondo natura. In primo luogo, pertanto, qui il concetto di buonsenso del bene è sparito e risulta fuggito chissà dove, giacché il procedere razionalmente nella selezione è nient’affatto un accidente fortuito ma nasce invece da una postura abituale dell’animo a procedere razionalmente. Perciò, siccome noi siamo costretti ad avere la cognizione di procedere razionalmente dal fine che ci poniamo, e però non si dà una cognizione del fine senza il procedere razionalmente, ecco che ci viene meno [1072D] la cognizione di entrambi. In secondo luogo, ed è la cosa più importante, a stretto rigor di logica la selezione razionale dovrebbe essere selezione di beni che sono giovevoli e che cooperano verso il fine; giacché come può essere razionale il selezionare per sé cose né utili né onorevoli e, in complesso, neppure oggetto di scelta? Sia dunque concesso trattarsi, come essi dicono, di una selezione razionale delle cose dotate di valore in vista dell’essere felici. Guarda allora come il loro ragionamento giunga così al suo punto capitale bellissimo e solenne. Infatti, come sembra, secondo loro, il ‘fine’ diventa l’operare razionalmente nella selezione delle cose che hanno valore al fine di operare razionalmente.
UN COMPAGNO. Se espressa in questi termini, caro compagno, la formulazione suona assai stramba agli orecchi di chi ascolta. [1072E] Inoltre ho bisogno di comprendere bene come tutto ciò accada.
DIADOUMENO. Allora fa’ bene attenzione, giacché risolvere un enigma non è cosa che possa fare il primo che capita. Ascolta e rispondimi. Dunque, secondo gli Stoici il fine non è forse l’operare razionalmente nella selezione delle cose che sono secondo natura?
UN COMPAGNO. Sì, essi così dicono.
DIADOUMENO. Le cose secondo natura sono selezionate in quanto sono beni, o cose dotate di un certo valore o degne d’essere promosse in vista di un certo fine, oppure sono selezionate in vista di qualche altra cosa?
UN COMPAGNO. Non ritengo che lo siano in vista di qualcos’altro, bensì in vista del fine.
DIADOUMENO. Bene, allora renditi conto che hai già disvelato ciò che accade agli Stoici, ossia il fatto che per essi il fine è l’operare razionalmente nella selezione delle cose che hanno valore al fine di operare razionalmente. Infatti i nostri uomini affermano che il bene e la felicità non hanno, e non si può pensare che abbiano, altra sostanza [1072F] che questa tanto onorata razionalità nella selezione delle cose dotate di valore. Tuttavia vi sono alcuni i quali credono che questa obiezione sia rivolta contro il solo Antipatro e non contro tutta la scuola Stoica: in quanto Antipatro, sotto la pressione di Carneade, si sarebbe squagliato in queste ragioni speciose.
§ 28. I concetti filosofici sulla passione amorosa elaborati nell’ambito della Stoa sono contrari ai concetti di comune buonsenso e hanno tutti dell’assurdo. [1073A] Infatti gli Stoici affermano che i giovani sono brutti poiché sono viziosi e dissennati; mentre belli sono i giovani sapienti; e che nessuno di quei giovani belli è oggetto di passione amorosa né è degno di passione amorosa. Ma non è ancora questa la parte terribile, giacché essi dicono pure che coloro i quali provano passione amorosa per dei giovani brutti, cessano di amarli se essi diventato belli. Chi mai conosce una passione amorosa del genere, la quale alla vista della depravazione del corpo e insieme dell’animo, si sostenta e s’infiamma; mentre quando s’ingenera la bellezza e insieme la saggezza accompagnata da giustizia e temperanza, la passione amorosa si estingue ed appassisce? Simili amanti io credo che non differiscano affatto dalle zanzare, giacché esse si deliziano di feccia e d’aceto, mentre volano lontano dal buon vino e lo evitano. [1073B] In primo luogo non è plausibile che quello che essi chiamano e denominano ‘palesamento della bellezza’ sia ciò che trasporta all’amore, giacché nei giovani più brutti e più viziosi non potrebbe avvenire palesamento alcuno della bellezza; se appunto, come essi dicono, la depravazione del carattere infetta anche l’aspetto. In secondo luogo, è completamente contrario al buonsenso che il giovane brutto sia degno di passione amorosa perché un giorno forse avrà o si suppone che otterrà la bellezza, e che una volta acquisitala e diventato bello e virtuoso non sia più oggetto della passione amorosa di alcuno.
UN COMPAGNO. Essi affermano che la passione amorosa è caccia ad un adolescente imperfetto certo, ma con una disposizione da purosangue alla virtù.
DIADOUMENO. Ma, mio caro, cos’altro stiamo noi adesso facendo se non contestare la scuola Stoica per il suo sforzo di [1073C] distorcere e di stravolgere i nostri concetti di comune buonsenso attraverso l’indicazione di comportamenti inverosimili e l’introduzione di termini bislacchi ed inauditi? Nessuno impedirebbe di designare come ‘caccia’ o ‘stringere amicizia’ l’attenzione piena di premure dei sapienti verso i giovani, quando a questa non sia congiunta la passione. Ma bisognerebbe chiamare ‘passione amorosa’ quello che tutti gli uomini e tutte le donne capiscono e chiamano con questo nome:
‘e bramarono tutti di stendersi in letto con lei’
ed anche
‘mai così desiderio di dea o di donna mortale
mi vinse, spandendosi dappertutto nel petto’.
§ 29. Inoltre gli Stoici, mentre scacazzano la loro Etica su faccende di questo genere
‘cose distorte, e nulla di sano ma tutto <pensando> in modo tortuoso’
svillaneggiano e dileggiano gli altri filosofi, sostenendo di essere loro i soli a rimettere la Fisica sulla retta via: via che, com’è d’uopo, è quella della comune consuetudine di fiducia nelle sensazioni; e poi istituendo [1073D] di rifiutare ogni altra Logica e di riportare ciascuno di noi con le sue mire, i suoi perseguimenti e i suoi impulsi alla condizione di uomo che gli è appropriata. Però la comune consuetudine di fiducia nelle sensazioni, una volta diventata un filtro della Dialettica, nulla di utile né di sano ha fatto loro ritrarre da essa, e come un senso dell’udito malsano la loro Dialettica è stata invece riempita di durezza d’udito e di incertezza di suoni ad opera di vuoti echi. Circa la Logica, se vuoi, discuteremo però un’altra volta cominciando da un diverso punto di partenza. Adesso passiamo invece in rassegna nei suoi punti cruciali la Fisica degli Stoici la quale, non meno della loro dottrina sui fini, mette a soqquadro i preconcetti di comune buonsenso.
§ 30. In generale, è assurdo e contrario ad ogni concetto di comune buonsenso sostenere che qualcosa è, e che però è un non-ente. [1073E] Che gli Stoici dicano che qualcosa è, e che però è un non-ente, diventa il colmo dell’assurdità quando ciò sia detto dell’universo. Dopo avere messo una cintura di vuoto infinito al di fuori del cosmo, essi infatti affermano che l’universo è né un corpo né un incorporeo. A ciò s’accompagna l’affermazione che l’universo è un non-ente, giacché essi chiamano enti soltanto i corpi; e siccome proprietà dell’ente è quella di fare o subire un’azione, l’universo è un non-ente: sicché esso né farà né subirà mai qualcosa. Ma allora esso neppure sarà in un certo luogo, giacché ciò che occupa un luogo essendo necessariamente un corpo e l’universo essendo un non-corpo, l’universo è in nessun luogo. Inoltre, il corpo cui è accaduto di occupare sempre lo stesso luogo è quello che permane in quiete: sicché l’universo non permane in quiete giacché non occupa un luogo. Ma esso neppure si muove: in primo luogo, perché il corpo in moto abbisogna di un luogo entro cui muoversi e quindi di uno spazio che gli faccia da substrato, [1073F] in secondo luogo perché un corpo che si muove, per natura o si muove da sé oppure subisce l’azione di un altro corpo. Pertanto il corpo che si muove da sé ha di per se stesso certe inclinazioni e certe propensioni a seconda della sua pesantezza o leggerezza: pesantezza e leggerezza le quali sono stati relativi o facoltà o differenze in ogni caso di un corpo; mentre l’universo è un non-corpo: [1074A] sicché di necessità esso è né pesante né leggero e neppure ha di per se stesso un principio di moto. Ma l’universo neppure è mosso da qualcos’altro, giacché nulla vi è che sia altro dall’universo: sicché è necessario che gli Stoici dicano quel che dicono, ossia che l’universo né permane in quiete né è in moto. Insomma, poiché secondo gli Stoici non è assolutamente lecito chiamare corpo l’universo, e però sono corpi il cielo, la terra, gli animali, i vegetali, gli uomini e le pietre: quello che è un non-corpo avrà come sue parti dei corpi, e di quello che è un non-ente saranno parti degli enti; ciò che è non-pesante utilizzerà pezzi pesanti, e ciò che è non-leggero dei pezzi leggeri. Tutte fantasticherie delle quali neppure nei sogni è possibile trovare equivalenti maggiormente in contrasto con i concetti di comune buonsenso. [1074B] Eppure nulla è così evidente ed aderente ai concetti di comune buonsenso quanto il dire che se qualcosa è non-animato, esso è inanimato; e a sua volta che se qualcosa è non-inanimato, esso è animato. Gli Stoici quindi sovvertono questa evidenza ed ammettono, invece, che l’universo sia né inanimato né animato. A parte ciò, nessuno pensa imperfetto quel tutto cui non manca parte alcuna; mentre invece gli Stoici affermano che l’universo è non-perfetto, giacché perfetto è qualcosa di definito; mentre l’universo è indefinito per la sua infinità e pertanto, secondo loro, è qualcosa che è né imperfetto né perfetto. Ma l’universo non è una parte, giacché nulla è più grande di esso; e neppure è l’intero; [1074C] giacché, come essi dicono, è in riferimento a qualcosa di fisso e ben posizionato che si usa il predicato ‘intero’, mentre invece l’universo, a causa della sua infinità è indefinito e senza una posizione fissa. Quanto all’agente causativo, non c’è qualcos’altro che sia causativo dell’universo, poiché non esiste altro oltre l’universo; e l’universo non è causativo d’altro né di se stesso. Esso non è nato per il ‘fare’, mentre il causativo è pensato tale per la sua capacità di ‘fare’. Orsù, ammettiamo adesso che a tutti gli uomini sia chiesto quale cognizione abbiano del ‘niente’ e quale divisamento se ne facciano. Non risponderebbero tutti che ciò che non esiste come causa né ha una causa, è né intero né parte, né perfetto né imperfetto, né animato né inanimato, né in moto né in quiete da qualche parte, è né corpo né incorporeo: [1074D] questo e nient’altro è il niente? Pertanto, qualora tutti quanti quelli che il resto dell’umanità asserisce essere predicati del niente, per gli Stoici soltanto siano invece predicati dell’universo: è verosimile che gli Stoici appaiano identificare l’universo col niente. Ma allora si devono chiamare ‘niente’ anche il tempo, il predicato, la proposizione, il periodo ipotetico e quello copulativamente coordinato: insomma gli strumenti di cui essi soprattutto, tra i filosofi, si servono, proprio loro dicono che sono ‘inesistenti’. Sostenere che la realtà vera né c’è né esiste e che però possa essere afferrato e sia afferrabile e degno di fiducia ciò che non partecipa della sostanza dell’essere, come può dirsi che non vada oltre ogni assurdità?
§ 31. Tuttavia, affinché non sembri che l’assurdità di queste dottrine Stoiche sia principalmente di carattere logico, atteniamoci all’assurdità delle loro dottrine fisiche. [1074E] Poiché come dicono loro:
‘Zeus in principio, Zeus a mezzo, Zeus di tutto è il compimento’;
ove qualcosa di sconcertante o di erroneo si fosse ingenerato nei concetti di comune buonsenso circa gli dei, bisognerebbe soprattutto che gli Stoici procedessero ad aggiustarli e a riportarli sulla retta via al loro meglio; e altrimenti che li lasciassero così come ciascun popolo li ha, ossia ossequienti alla legge e alla comune consuetudine verso il divino
‘giacché non ora e non ieri, ma sempre vivono queste cose
e nessuno sa da quando esse apparvero’.
Gli Stoici, invece, come hanno cominciato a smuovere dalle fondamenta le istituite ed avite consuetudini e credenze circa gli dei così, per dirla in breve, non hanno lasciato sano ed integro alcun concetto di comune buonsenso. [1074F] Quale creatura diversa dagli uomini c’è o ci fu mai, la quale non abbia la cognizione che il divino è imperituro e sempiterno? Nessun’altra voce ha mai detto poeticamente ed in modo coerente con i preconcetti di comune buonsenso circa gli dei, parole più elevate di queste:
‘là il giorno intero godono beati gli dei’
e queste,
‘degli dei immortali e degli uomini che camminano sulla terra’
e queste altre [1075A]
‘essi infatti sono al riparo dalla malattia e dalla vecchiaia
né hanno esperienza di dolori, essi cui mai toccherà
la traversata cupa di grida dell’Acheronte’.
Qualcuno potrebbe forse imbattersi in popolazioni barbare e selvagge le quali non hanno la cognizione di dio, ma mai è nato anche un solo uomo il quale, avendo la cognizione di dio, non lo pensi come imperituro e sempiterno. Ora, questi che furono designati quali filosofi Atei: i Teodoro, i Diagora e gli Ippone, non ebbero l’ardire di sostenere che il divino sia perituro, ma erano bensì convinti che nulla esistesse di imperituro. In questo modo, non lasciando alcuno spazio all’esistenza dell’imperituro, quegli Atei si ponevano in realtà a difesa del comune preconcetto di dio. Ma Crisippo e Cleante dopo avere a parole, per così dire, infarcito di dei [1075B] il cielo, la terra, l’aria e il mare; a nessuno di tali e tanti personaggi hanno riservato vita imperitura e sempiterna, ad eccezione di Zeus, nel quale essi fanno consumare tutti gli altri. Sicché a Zeus è anche congiunta la caratteristica di far perire, che è cosa non più giusta e conveniente dell’essere fatto perire. Infatti, è certo una sorta di debolezza quella per cui una divinità perisce trasformandosi in una diversa, e quella diversa si preserva essendo nutrita dalle altre divinità che periscono e in essa si consumano. Queste, come molte altre, non sono assurdità che noi deduciamo come insite nelle loro premesse e conseguenti alle loro dottrine. Sono loro stessi, invece, nei loro scritti sugli Dei, la Prònoia, il Destino e la Natura, ad affermare a gran voce e in termini precisi che tutti gli altri dei [1075C] sono stati soggetti a nascita nel passato e saranno soggetti a perire in futuro nel fuoco, dal momento che secondo loro essi sono fusibili come fossero di cera o di stagno. Pertanto, com’è contrario al concetto di comune buonsenso sostenere che l’uomo sia immortale, altrettanto lo è il sostenere che dio sia mortale: insomma io non vedo più quale sarà la differenza tra dio e l’uomo se anche dio è un animale razionale e perituro. Qualora poi gli Stoici contrappongano questa sapiente e bella finezza, cioè affermino che l’uomo è mortale, mentre dio è non-mortale ma perituro, guarda un po’ cosa ne consegue per loro: infatti, essi staranno dicendo o che dio è contemporaneamente immortale e perituro, oppure che dio è né mortale né immortale. Affermazioni delle quali è impossibile oltrepassare l’assurdità neppure plasmando a bella posta [1075D] concetti altri e diversi, contrari al comune buonsenso. Intendo impossibile per altri filosofi, giacché non c’è alcuna delle affermazioni più assurde che gli Stoici abbiano pretermesso di pronunciare o di argomentare dialetticamente. Inoltre Cleante, nella sua gara a favore della conflagrazione universale, afferma che il sole assimilerà a sé e trasformerà in se stesso la luna e tutti i restanti astri. Ma allora gli astri, che pure sono dei, mentre danno il loro contributo alla conflagrazione universale cooperano con il sole alla loro rovina. Sarebbe pertanto ben ridicolo che noi li supplicassimo per la nostra salvezza e li legittimassimo come salvatori degli uomini, quando per natura essi affrettano [1075E] la loro stessa rovina e la loro eliminazione.
§ 32. Invero, in polemica contro Epicuro, gli Stoici non tralasciano alcun ‘ah! ah! oh! oh!’ e gridano che egli, levata di mezzo la Prònoia, mette in confusione i comuni preconcetti che noi abbiamo degli dei. Infatti, non basta anticipare e pensare dio immortale e beato soltanto, ma bisogna anche concepirlo filantropo, provvido e giovevole: il che è vero. Se però coloro i quali, non ammettendo l’esistenza della Prònoia, fanno sparire il comune preconcetto che noi abbiamo di dio; cosa fanno coloro i quali sostengono che gli dei provvedono sì a noi, ma non ci giovano; non sono datori di beni bensì di cose indifferenti; non elargendoci la virtù, ci elargiscono bensì la ricchezza, la salute, la generazione di figli e cose di questo genere, [1075F] neppure una sola delle quali è tuttavia giovevole, vantaggiosa e degna di scelta? Non è forse vero che mentre gli Epicurei fanno sparire i concetti di comune buonsenso circa gli dei, gli Stoici questi dei li oltraggiano in modo indegno e li espongono al ludibrio affermando che un certo dio è Epicarpio ossia Guardiano dei frutti, Genetlio ossia Protettore delle nascite, Peana ossia Soccorritore, Oracolare ossia Profetico; [1076A] quando né la salute né la generazione né l’abbondanza di frutti sono beni, bensì delle cose indifferenti e del tutto futili per coloro che le ottengono?
§ 33. La terza caratteristica saliente del concetto di comune buonsenso che differenzia gli dei dagli uomini, è che in nulla gli dei tanto differiscono da noi quanto in felicità e in virtù. Ma secondo Crisippo non resta agli dei neppure questa superiorità: “Giacché, quanto a virtù, Zeus è non più eminente di Dione. E Zeus e Dione, poiché sono sapienti, si recano l’un l’altro un giovamento simile, qualora uno dei due si imbatta nei movimenti dell’altro”. Infatti, questo e null’altro è il bene che esiste e che scorre dagli dei verso gli uomini e dagli uomini, quando siano diventati sapienti, verso gli dei. Gli Stoici sostengono inoltre che l’uomo il quale non si sia privato della virtù [1076B] è nient’affatto in difetto di felicità; e che l’uomo sfortunato il quale si toglie la vita a causa di una malattia cronica o di una grave menomazione corporale, a patto che sia un sapiente è altrettanto beato quanto lo è Zeus Salvatore. Ora, questo sapiente non si trova da nessuna parte su questa terra né mai è nato, mentre invece vi si trovano innumerevoli decine di migliaia di uomini i quali sono tutti sommamente infelici, pur essendo essi cittadini della repubblica che è sotto il comando di Zeus ed ha in assoluto il miglior governo possibile. Eppure cosa potrebbe essere più contrario al comune buonsenso del concetto che mentre Zeus ci governa nel miglior modo possibile, noi ce la passiamo nel peggior modo possibile? Se dunque, cosa che neppure è lecito dire, Zeus decidesse di essere non più Salvatore né Meilichio ossia Benigno, né Alessicaco ossia Allontanatore dei Mali, ma tutto il contrario [1076C] di questi belli appellativi, non vi sarebbe comunque la possibilità di assommare altri mali a quelli già esistenti, né per numero né per grandezza; visto che, come affermano gli Stoici, tutti gli uomini vivono al colmo della meschinità e della depravazione e che il vizio non è passibile di accrescimento né l’infelicità di innalzamento.
§ 34. La stranezza più grande non sta però qui, bensì nel fatto che gli Stoici si stizziscano con Menandro quando a teatro fa dire:
‘Massima causa dei mali tra gli uomini
è l’eccesso di beni’.
Essi sostengono, infatti, che quest’affermazione è contraria al buonsenso; e poi sono invece proprio loro a fare del buon dio il principio basilare dei mali. Infatti, non è stata la materia a procurare, traendolo da se stessa, il male; giacché la materia è priva di qualità, e tutte le differenziazioni che accoglie le ha avute [1076D] da ciò che la fa muovere e la foggia. Ed a muoverla e foggiarla è la ragione che esiste in lei, in quanto per sua natura essa è incapace di muovere e di foggiare se stessa. Sicché è necessario che il male esistente: se non ha causa, sia stato prodotto da ciò che è un non-ente; se la causa è un principio che lo muove, sia stato prodotto da dio. Infatti, se credono che Zeus non abbia completa padronanza delle sue stesse parti e che non utilizzi ciascuna di esse in armonia con la sua propria ragione, gli Stoici stanno parlando contro il comune buonsenso e plasmano una creatura vivente molti pezzi della quale sfuggono alla di lei volontà, giacché mettono in opera attività ed azioni di loro propria iniziativa, alle quali la creatura intera non dà impulso né delle quali ordina per prima il movimento. Nessuna delle creature [1076E] dotata di anima è mai stata messa insieme talmente male che contro la sua volontà i piedi si mettono a camminare, la lingua a pronunciare dei suoni, le corna a dare di cozzo o i denti a mordere. Eppure è necessario che dio sperimenti passivamente la maggior parte di queste azioni se contro la sua volontà ma essendone parti, i malvagi dicono menzogne, agiscono sconsideratamente, scassinano e si ammazzano l’un l’altro. Se, come afferma Crisippo, nulla può stare, neppure nel suo minimo particolare, altrimenti che in armonia con la decisione di Zeus, ma ogni essere animato è nato per stare e muoversi così come Zeus lo conduce, lo fa voltare, lo fa stare e lo fa disporre, allora
‘questo suono non è più esiziale di quello’.
[1076F] Sarebbe infatti diecimila volte più opportuno dire che dalla debolezza e impotenza di Zeus le sue parti si trovano per forza spinte a compiere molte azioni assurde e contrarie alla di lui natura e volontà, che invece affermare che non esiste non padronanza di sé né cattiveria della quale Zeus non sia causa. Invero essi dicono anche che il cosmo è una città e che gli astri ne sono i cittadini. Se è così, allora è manifesto che ci sono anche dei membri della Tribù e degli Arconti; che il Sole è un membro del Consiglio e che Espero è un Pritano [1077A] o un membro della Polizia Urbana. Io non so davvero se chi contesta affermazioni di questo genere non si dimostri così più assurdo di coloro che le dichiarano parlando.
§ 35. Delle affermazioni più strettamente fisiche degli Stoici, non è forse contrario al concetto di comune buonsenso il dire che un seme è qualcosa di più e di più grande di ciò che da esso si genera? Noi vediamo infatti nel caso di tutti gli esseri viventi che la natura prende quale origine per la generazione delle creature più grandi, sia animali che vegetali, tanto domestiche quanto selvatiche, degli elementi piccoli, glutinosi ed a stento visibili. Essa infatti non dà soltanto origine ad una spiga di grano da un granello né ad una vite da un vinacciolo, ma da un nocciolo o da una ghianda sfuggiti ad un uccello, come da una piccola scintilla essa attizza e fomenta la generazione di un virgulto di rovo, [1077B] di una quercia o di una palma o di un pino altissimo. Perciò gli Stoici affermano che lo sperma prende questo nome dalla ‘agglomerazione’ di una grande quantità in una piccola mole; e che la natura si chiama così perché è il rigonfiamento e l’effusione delle ragioni o numeri che da essa sono aperti e sciolti. D’altra parte gli Stoici affermano che il fuoco è come il seme del cosmo, e che nel corso della conflagrazione universale esso, mutato in seme, partendo da una massa corporea più piccola va incontro ad una grande effusione e s’espande occupando un’immensa regione di vuoto e pascendosene per la sua crescita. Quando poi per il cosmo è il momento d’una nuova generazione, [1077C] allora la sua grandezza impiccolisce e scema, poiché la materia sprofonda e si raccoglie in se stessa nel corso della generazione.
§ 36. È quindi possibile ascoltarli, e leggerli in molti loro scritti, litigare con gli Accademici gridando che questi confondono ogni cosa con la loro dottrina delle ‘indistinguibilità’, poiché forzano l’esistenza di un’unica qualità nel caso di due sostanze. Eppure non c’è uomo il quale, al contrario, non pensi e creda stupefacente e paradossale che nel corso di tutto il tempo non vi sia mai stato un colombo identico ad un altro colombo, un’ape ad un’ape, un chicco di grano ad un chicco di grano, il fico del racconto ad un altro fico. [1077D] In effetti è invece contrario ad ogni concetto di comune buonsenso quel che plasmano fittiziamente questi Stoici, i quali affermano che in una sola sostanza ci possono essere due peculiari qualificazioni qualitative, e che la medesima sostanza avente una sola e peculiare qualificazione qualitativa ne può accogliere in seguito un’altra e custodirle intatte entrambe. Giacché se si tratta di due, allora in una sola sostanza esse potranno anche essere tre o quattro o cinque o tante quante uno vuole a piacere: e intendo non in parti differenti della sostanza, ma infinite qualificazioni qualitative tutte similmente presenti nella totalità della stessa. Crisippo, in ogni caso, afferma che “Zeus e il cosmo sono simili al corpo dell’uomo e la Prònoia al suo animo. Quando avviene la conflagrazione universale, poiché Zeus è l’unico dio imperituro, egli arretra e si raccoglie in Prònoia; dopo di che, [1077E] resisi omogenei, entrambi persistono in un’unica sostanza che è l’etere”.
§ 37. Mettiamo ora in un canto il discorso sugli dei e, dopo avere auspicato che essi donino agli uomini il comune buonsenso e un comune modo di pensare, vediamo come, secondo gli Stoici, stanno le cose per quanto riguarda gli elementi. È contrario al concetto di comune buonsenso il sostenere che un corpo sia spazio per un corpo diverso; che un corpo si faccia spazio attraverso un altro corpo, quando nessuno dei due include in sé alcun vuoto; che vi sia del pieno che s’insinua nel pieno; che ciò che non ha rotture né posto al proprio interno per via della sua continuità, accolga quel che gli viene mescolato. Coloro che comprimono in un solo corpo non uno né due né tre né dieci corpi, ma che sbattono dentro ogni singolo corpo, qualunque sia, [1077F] tutte le parti del cosmo ridotto in spiccioli; e sono dell’avviso che il menomo oggetto sensibile non perda il confronto rispetto al più grande, sono mossi da giovanilismo acuto giacché, come accade loro in molti altri casi, gli Stoici fanno delle loro ipotesi, qualora siano contestate in quanto contraddicenti i concetti di comune buonsenso, un dogma dottrinario. Per immediata conseguenza di questo modo di ragionare, coloro i quali mescolano totalmente interi corpi con altri corpi interi, devono accettare delle conseguenze mostruose ed inusitate, [1078A] tra le quali vi è anche che ‘il tre è quattro’. Gli altri filosofi dicono questo per iperbole, come esempio di cose assolutamente impensabili. Secondo gli Stoici, invece, accade questo: un ciato di vino mescolato con due ciati di acqua, se il vino è destinato ad essere non da meno ed a pareggiarsi con l’acqua, distribuendosi in essa tutta e confondendosi con essa, pur essendo un ciato solo ne diventa due grazie al pareggiamento della sua mescolanza con l’acqua. Infatti il ciato di vino che rimane uno ma che si coestende a due ciati d’acqua equivale al pareggiarsi del singolo al doppio. E se ciò che misura uno, per pervenire nella mescolanza al due, nella sua effusione diventa della misura due, questa mescolanza è contemporaneamente della misura tre e della misura quattro: tre, perché ai due ciati di acqua s’è mischiato un ciato di vino; e quattro perché il vino, una volta mischiatosi ai due ciati di acqua, è diventato di misura pari alla quantità d’acqua con la quale si è mischiato. [1078B] Questo è il bel risultato che ottengono coloro i quali infilano corpi dentro corpi, e l’impensabile che è contenuto implicitamente nelle loro definizioni. Poiché nel mescolamento i corpi si fanno spazio reciprocamente uno nell’altro, è necessario che uno dei due non sia quello che include e l’altro quello che è incluso, uno quello che accoglie e l’altro quello che è accolto; giacché allora questo non sarà ‘mescolamento’ bensì tocco e contatto di superfici: quella interna come superficie rivestita e quella esterna come superfice che include, mentre le altre parti interessate rimangono invece intatte e fuori della mischia. Quando, secondo il loro parere, avviene la ‘compenetrazione’, è necessario che i corpi mischiati diventino gli uni gli altri, e del pari che l’essere incluso dell’uno sia identico all’essere accolto dell’altro, e che l’includere dell’uno sia identico all’accogliere [1078C] dell’altro. Accade allora che nessuno dei due possa di nuovo esistere singolarmente, poiché la mescolanza forza entrambi i corpi ad attraversarsi, a non lasciarsi dietro alcun pezzo di sé ed a riempirsi del tutto l’un l’altro. A questo punto, per calpestare e coprire di ridicolo le assurdità degli Stoici può entrare in scena a proposito la famosa gamba di Arcesilao, diventata addirittura un luogo comune nelle discussioni. Infatti, se le mescolanze sono di interi corpi con altri corpi interi, data una gamba amputata, in avanzato stato di putrefazione, scagliata in mare ed in questo dissoltasi completamente: cosa impedisce che attraverso quella gamba navighi non soltanto la flotta di Antigono, come soleva dire Arcesilao; ma che vi avvenga la battaglia navale tra le milleduecento triremi di Serse [1078D] e le trecento dei Greci? Il corpo più piccolo, infatti, non ometterà certo di iniziare a mescolarsi con il corpo più grande né smetterà di procedere nella mescolanza. Altrimenti essa avrà un limite e da ultimo, dove il corpo più piccolo ha il contatto di mescolamento con il corpo più grande, tale contatto non procederà oltre verso l’intero corpo più grande e sarà così impedito ai due corpi di mischiarsi. Se invece i due corpi si saranno mischiati intero con intero, non ci sarà bisogno di una intera gamba, per Zeus, per procurare ai Greci lo spazio per una battaglia navale, giacché a questo fine c’è bisogno della sua putrefazione e conseguente trasformazione. Di essa un solo ciato o una sola goccia cadendo nel mare Egeo o nel mare di Creta si estenderanno fino all’Oceano e al mare Atlantico, non entrando in contatto con essi soltanto superficialmente a pelo d’acqua [1078E] bensì espandendosi e compenetrandosi con essi completamente: in profondità, per il largo e per il lungo. Subito all’inizio del primo libro delle ‘Ricerche Fisiche’, Crisippo accetta queste argomentazioni, quando afferma che nulla preclude che una sola stilla di vino temperi il mare e, affinché noi non ci si stupisca di questo fatto, afferma che la stilla s’estende, col mescolamento, all’intero cosmo. Non so dire quale di queste affermazioni appaia più assurda.
§ 38. È contrario ad ogni concetto di comune buonsenso sostenere che nella natura dei corpi non vi sia un’estremità, né alcuna prima ed ultima parte entro le quali la grandezza del corpo sia conclusa; e invece, qualunque parte di esso sia presa in considerazione, che appaia sempre qualcosa che ne va al di là e rimanda l’oggetto materiale nell’infinito e nell’indefinito. [1078F] Dati due corpi, infatti, se per i costituenti di entrambi accade di poter similmente procedere all’individuazione di un numero infinito di parti, sarà impossibile pensare la grandezza di uno come minore o maggiore di quella dell’altro. Ma in questo modo sparisce la natura della loro ineguaglianza, giacché di due corpi pensati ineguali, è per le estremità non coincidenti che uno cede in grandezza e l’altro ne acquista una diversa e superiore. E se l’ineguaglianza è inesistente, ne consegue che neppure esistono l’irregolarità o la ruvidezza di un corpo; giacché l’irregolarità è l’ineguaglianza [1079A] di parti diverse di una stessa superficie, mentre la ruvidezza è irregolarità accompagnata da durezza. Nessuna di queste due è invece lasciata sussistere da coloro che nessun corpo fanno terminare in una sua parte estrema, ma che con una moltitudine di parti estendono tutti i corpi all’infinito. Eppure, come può non essere evidente che l’uomo consiste di un numero maggiore di pezzi di quelli che costituiscono un suo dito e che il cosmo, a sua volta, consiste di un numero maggiore di pezzi di quelli che costituiscono un uomo? Queste cose le sanno e le pensano tutti, a meno che non diventino Stoici. Ma una volta diventati Stoici, essi dicono però l’opposto ed opinano che l’uomo non abbia più parti del suo dito, né il cosmo dell’uomo; giacché la divisione in parti incrementa i corpi [1079B] e negli infiniti non ci sono un più e un meno. Una moltitudine non è mai troppa, e le parti del corpo restante non cesseranno di poter essere ulteriormente divise in parti e quindi di procurare da se stesse una moltitudine qualsivoglia.
UN COMPAGNO. E allora? Gli Stoici non si difendono da queste aporie?
DIADOUMENO. Accuratamente se ne difendono, con ingegnosità e coraggio. Infatti, quando ci viene domandato se abbiamo delle parti e quante esse siano, e di quali e quante parti constino a loro volta questi componenti, Crisippo dice che noi utilizzeremo una distinzione e quindi, mantenendoci sulle generali, diremo di constare di testa, torace e gambe; giacché in questo consisteva tutto ciò ch’era ricercato e incerto. Se però passeranno oltre fino a chiedere delle parti ultime: “Nulla, egli afferma, v’è da concepire di siffatte parti, ma sarà il caso di dire semplicemente che noi non consistiamo di tali parti ultime, senza far parola di quali né, [1079C] similmente, quante esse siano, e se siano infinite o in numero finito”. Credo di avere fatto bene ad utilizzare le sue stesse parole, affinché tu possa notare il modo in cui Crisippo custodiva intatti i concetti di comune buonsenso, ordinandoci di pensare che ciascun corpo consta né di quali né di quante parti, né queste di un numero infinito o finito di componenti. Infatti se esiste un’entità intermedia tra il finito e l’infinito, così come l’indifferente è un’entità intermedia tra il bene e il male, allora Crisippo dovrebbe sciogliere l’aporia dicendo cos’è questo elemento intermedio. Se invece noi pensiamo che il non-finito sia per ciò stesso infinito, così come pensiamo che il non-uguale sia per ciò stesso disuguale e il non-perituro sia imperituro, allora il dire che un corpo consta di un numero di parti né finito né infinito equivale a sostenere, io credo, [1079D] che un discorso si regge su assunti né veri né falsi, né semplici né non-semplici.
§ 39. Oltre a ciò, con giovanile baldanza Crisippo afferma che le facce della piramide sono costituite da triangoli; che lungo le loro linee di contatto scendendo verso la base queste facce sono disuguali; e che però non sono soprammisura dove sono più grandi. Questo era il suo modo di preservare intatti i concetti di comune buonsenso. Infatti, se qualcosa è più grande ma non è soprammisura, qualcos’altro sarà più piccolo ma non sottomisura, sicché qualcosa sarà disuguale pur essendo né soprammisura né sottomisura, cioè qualcosa di uguale sarà disuguale, qualcosa di più grande sarà non più grande e qualcosa di più piccolo sarà non più piccolo. [1079E] Guarda inoltre in che modo Crisippo ha replicato a Democrito il quale, da studioso della natura che coglie nel segno, era assai incerto sulla seguente questione: “Se un cono fosse tagliato da un piano parallelo alla sua base, cos’è d’uopo pensare delle superfici di queste sezioni? Sono esse uguali una all’altra o sono disuguali? Se sono disuguali, esse renderanno il cono un solido irregolare, con molte incisioni a gradino ed asperità. Se le superfici sono uguali, le sezioni saranno uguali ed il cono apparirà avere preso le proprietà del cilindro, il quale consta di sezioni uguali e non disuguali; il che è però del tutto assurdo. A questo proposito, dopo aver dichiarato che Democrito è un ignorante, Crisippo afferma [1079F] che le superfici sono né uguali né disuguali. Disuguali sono i corpi, per il fatto che le superfici sono né uguali né disuguali. Ora, legislare che se le loro superfici sono né uguali né disuguali allora i corpi sono disuguali, è caratteristico soltanto di un uomo che si concede la strabiliante potestà di scrivere qualunque cosa gli salti in testa. È di tutta evidenza, infatti, che il ragionamento ci permette di pensare il contrario, ossia che le superfici dei corpi disuguali sono disuguali [1080A] e che la superficie del corpo più grande è maggiore; a meno che la soprammisura per cui esso è più grande sia priva di superficie; giacché se le superfici dei corpi più grandi sono non più grandi delle superfici dei corpi più piccoli ma cedono loro in grandezza, di un corpo avente un limite ci sarà una parte priva di limite ossia illimitata. Se poi Crisippo intende per forza sostenere che pensare le superfici in questo modo salva il cono, ebbene egli si smentisce da solo quando è dell’avviso che: “le scalfiture a gradino torno torno al cono che Democrito ha in sospetto, le fa di sicuro la disuguaglianza dei corpi e non la disuguaglianza delle superfici”. Ma è ridicolo attribuire una riconosciuta irregolarità ai corpi eccettuandone però le superfici. E se prenderemo per buona l’ipotesi di Crisippo: cosa c’è di più contrario [1080B] al comune buonsenso che il plasmare congetture di questo genere? Se infatti porremo una superficie né uguale né disuguale ad un’altra superficie, sarà possibile affermare ciò anche per una grandezza rispetto ad un’altra grandezza, e dire che un numero è né uguale né disuguale ad un altro numero: e tutto ciò senza che noi si abbia modo di dire il nome e neppure di avere una cognizione di questo ente intermedio tra l’uguale e il disuguale e che è né l’uno né l’altro. Inoltre, se delle superfici sono né uguali né disuguali, cosa ci impedisce di pensare cerchi né uguali né disuguali? Le superfici delle sezioni del cono sono di sicuro dei cerchi, e se sono dei cerchi bisogna supporre che anche i diametri dei vari cerchi siano né uguali né disuguali. Ma se è così, bisogna supporre la stessa cosa valida anche per gli angoli, i triangoli, i parallelogrammi, [1080C] i parallelepipedi e i volumi dei corpi. Se infatti le lunghezze sono né uguali né disuguali una all’altra, né uguali né disuguali saranno anche le profondità e le larghezze, e quindi anche i corpi. Dopo di che, come possono gli Stoici avere l’ardire di rimproverare di contraddizione coloro che introducono e ipotizzano certi movimenti comuni e indivisibili che sono né di moto né di quiete; proprio loro che dichiarano essere falsi gli enunciati: ‘Se certe cose non sono uguali una all’altra, quelle cose sono disuguali una dall’altra’ e ‘non si dà che queste cose siano uguali una all’altra e però si dà che siano non disuguali una all’altra’? Poiché Crisippo sostiene che esiste qualcosa che è più grande ma che è non soprammisura, vale la pena di essere incerti se questi corpi si corrispondano esattamente l’un l’altro. Infatti, se si corrisponderanno esattamente [1080D] come può uno essere più grande dell’altro? E se non si corrisponderanno esattamente come può non essere necessario che uno dei due sia in soprammisura e l’altro in sottomisura? Oppure nessuno dei due sarà in soprammisura e non corrisponderà esattamente al più grande, o è l’altro che corrisponderà esattamente al più grande? È necessario che coloro i quali non difendono i concetti di comune buonsenso si trovino poi in mezzo ad aporie di questo genere.
§ 40. Invero, dire che nulla tocca nulla è contrario ad ogni concetto di comune buonsenso; e non lo è di meno il dire che i corpi si toccano sì, ma si toccano con nulla. Eppure è necessario che accettino ciò coloro i quali non lasciano questa proprietà alle parti minime del corpo, ma prendono sempre in considerazione una parte che è subito prima di quella che sembra toccare e non cessano più di procedere al di là. [1080E] L’obiezione principale che gli Stoici formulano contro i sostenitori dell’esistenza degli ‘indivisibili’ è che il contatto non è di interi con interi, né di parti con parti. Quello di interi con interi non fa un ‘contatto’ ma una ‘mescolanza’. Quello di parti con parti è impossibile, perché gli indivisibili non hanno parti. Com’è allora che essi non incappano in questa impossibilità, proprio loro che non lasciano sussistere parti, né prime né ultime? Perché, per Zeus, essi dicono che i corpi entrano in contatto reciproco ‘per limiti’ e non ‘per parti’, e che il limite è un non-corpo. Pertanto, corpo toccherà corpo con un incorporeo, ma nel contempo non lo toccherà giacché c’è di mezzo un incorporeo. Se però lo toccherà, il corpo farà e subirà un’azione ad opera di un incorporeo, [1080F] giacché è natura dei corpi quella di fare e di subire l’azione di altri corpi per contatto. E se il corpo è in stato di contatto per l’intervento di un incorporeo, allora si avranno: contatto o mescolanza o connaturazione di parti. Nei casi di contatto e di mescolanza di parti è necessario che i limiti dei corpi o permangano tali oppure che non permangano e che siano distrutti: ma entrambe queste cose sono contrarie al comune buonsenso, giacché gli Stoici non lasciano sussistere la distruzione e la generazione degli incorporei e, d’altro canto, la mescolanza e il contatto di parti [1081A] di corpi entro i loro propri limiti neppure potrebbero avvenire, poiché il limite definisce e stabilisce la natura del corpo. E se le mescolanze non sono semplici accostamenti di parti con parti ma sono, come sostengono gli Stoici, corpi che si mescolano e si confondono interamente gli uni con gli altri, allora bisogna lasciar sussistere la distruzione dei limiti nelle mescolanze e successivamente la loro genesi nel corso delle segregazioni dei componenti: processi questi, dei quali nessuno potrebbe farsi facilmente una cognizione. Ora, ciò grazie a cui i corpi si toccano l’un l’altro è anche ciò grazie a cui i corpi sono compressi, schiacciati, frantumati uno dall’altro; mentre è impossibile, e neppure pensabile, che un incorporeo possa fare o subire queste azioni: eppure questo è ciò che gli Stoici vogliono per forza che noi pensiamo. [1081B] Se infatti la sfera tocca il piano in un punto, è manifesto che essa rotola sul piano toccando una successione di punti; e qualora la superficie della sfera sia stata spalmata di minio essa lascerà quale traccia sul piano una linea rossa; qualora la sfera sia stata riscaldata, riscalderà il piano; ed è contrario a qualunque concetto di comune buonsenso che un corpo possa essere colorato o riscaldato da un’entità incorporea. Se poi noi immagineremo che una sfera di coccio o di vetro cada dall’alto sopra una superficie di pietra, è irragionevole pensare che essa non si frantumi, essendovi un impatto contro un corpo resistente all’urto; ed è ancora più assurdo pensare che essa sia frantumata perché impatta contro un limite e un punto incorporeo. Sicché in ogni caso è necessario che vadano a gambe all’aria [1081C] o ancor meglio che rovinino in macerie i preconcetti di coloro che ai corpi e agli enti incorporei associano molte nozioni impossibili.
§ 41. È contrario ad ogni concetto di comune buonsenso sostenere che ‘tempo’ è quello futuro e quello trascorso, e che invece il presente è un non-tempo; che il testé e lo ieri sono presupposti e che l’adesso non c’è affatto. Ma proprio questo accade agli Stoici, i quali non ammettono l’esistenza di un tempo minimo né vogliono che l’istante presente sia privo di parti, e sono invece dell’avviso che nell’istante in cui uno crede di star pensando al presente, esso è già il futuro o il trascorso del presente. Sicché se il tempo chiamato presente viene spartito [1081D] in pezzetti assegnati al futuro e in pezzetti assegnati al passato, neppure un pezzetto del tempo presente rimane coincidente con l’adesso. Ora delle due cose, o l’una o l’altra: o gli Stoici pongono come vera la proposizione ‘il tempo era e il tempo sarà’ e allora avviene loro di rendere falsa la proposizione ‘il tempo è’; oppure pongono come vera la proposizione ‘il tempo presente è’ e di esso un istante è il passato ed un istante è il futuro, e allora avviene loro di sostenere che una parte del tempo esistente è il tempo futuro e una parte è il tempo trascorso, e che dell’adesso una parte è precedente l’adesso ed una parte è successiva all’adesso: sicché l’adesso risulta essere il non ancora adesso e il non più adesso, giacché il tempo trascorso non è più adesso e il futuro non è ancora adesso. Poiché gli Stoici fanno queste distinzioni, è necessario che essi dicano: l’oggi è in parte ieri e in parte domani; quest’anno è in parte l’anno scorso e in parte l’anno prossimo; la simultaneità è in parte il prima e in parte il dopo. [1081E] E quando essi impastano i ‘non ancora’ e ‘già’ e ‘non più’ e ‘adesso’ e ‘non adesso’ ne sortiscono dei pasticci per nulla più ragionevoli. Tutti gli altri uomini, invece, pongono come vero, ne hanno la cognizione e legittimano l’idea che il ‘poco fa’ e il ‘tra poco’ siano pezzi di tempo ben diversi da ‘adesso’ e che l’uno viene dopo e l’altro viene prima di quest’ultimo. Tuttavia, tra gli Stoici, quando Archedemo dice che ‘l’ora presente’ è una giuntura e commessura del tempo trascorso e del tempo a venire, pare sfuggirgli che egli sta in questo modo abolendo il tempo intero. Se, infatti, l’ora presente non è un tempo ma il limite del tempo passato e futuro e se ogni pezzetto del tempo è tal quale l’ora presente, il tempo nella sua interezza [1081F] appare non avere parti ma risolversi al tutto in limiti, commessure e giunture. Crisippo poi, quando decide di lavorare con arte sulla suddivisione del tempo, nel libro ‘Sul vuoto’ e in altri suoi libri afferma che la parte trascorsa e quella futura del tempo non esistono davvero ma sono presupposte, e che soltanto il presente esiste davvero. Nel terzo, nel quarto e nel quinto libro ‘Sulle parti’ egli sostiene però che, del tempo presente, una parte è futuro e una parte è passato. [1082A] Sicché gli avviene di suddividere la parte esistente del tempo in parti che sono inesistenti e in quella che esiste, o piuttosto di lasciare esistente assolutamente nulla del tempo, se il presente non ha una parte che non sia o futuro o passato.
§ 42. Se l’intellezione del tempo che hanno gli Stoici equivale al tentativo di tenere in mano dell’acqua: acqua che invece, quanto più la mano la stringe, ci scorre e ci scivola via tra le dita; circa le azioni e i movimenti, la dottrina degli Stoici comporta la più completa confusione dell’evidenza. Infatti, se lo ‘adesso’ viene suddiviso in una parte che è passato ed in una che è futuro, è necessario che il movimento di un corpo nell’adesso consista in parte di un movimento che c’è già stato e in parte di un movimento che ci sarà; che siano stati aboliti il termine e il principio di qualunque movimento; che di nessuna opera ci sia stato un principio [1082B] né ci sarà mai una fine, visto che le azioni sono scompartite secondo il tempo. Infatti, siccome gli Stoici sostengono che del tempo presente una parte è passato e una parte è futuro, si può ben dire che delle azioni in effettuazione una parte è già stata effettuata e una parte sarà effettuata. Fare colazione, scrivere, incedere: quando mai ebbero principio e quando mai avranno fine; se chiunque stia facendo colazione la stava già facendo e facendola starà; e chi sta incedendo stava già incedendo e incedendo starà? E poi la più vituperosa e trista, come si dice, di tutte le cose vituperose e triste: se alla creatura vivente tocca d’essere già stata vivente e d’essere vivente in futuro, il suo vivere né ebbe inizio né avrà mai fine, e ciascuno di noi, a quanto pare, è venuto al modo senza che il suo vivere abbia avuto un inizio e morirà senza mai smettere di vivere. Infatti, se nessuna parte della sua vita è l’estrema, [1082C] ma sempre qualcosa dell’attualità presente dell’essere vivente si estende nel futuro, la proposizione ‘Se Socrate è vivente, sarà in vita’ non diventa mai falsa. E ogni volta che sarà vera la proposizione ‘Socrate è vivente’ altrettante volte sarà falsa la proposizione ‘Socrate è morto’. Sicché se la proposizione ‘Socrate sarà vivente’ è vera per infinite parti di tempo, in nessuna parte di tempo sarà vera la proposizione ‘Socrate è morto’. Tuttavia, cosa potrebbe diventare il termine finale di un’opera, dove potrebbe terminare l’opera iniziata se ogni volta che è vera l’affermazione ‘è in corso di effettuazione’, altrettante volte è vera l’affermazione ‘sarà in corso di effettuazione’? Dirà pertanto una falsità chi afferma di Platone che sta scrivendo o dialogando, che ad un certo punto Platone smetterà di scrivere o di dialogare; [1082D] giacché non è mai falso affermare di chi sta dialogando che ‘starà dialogando’, né di chi sta scrivendo che ‘starà scrivendo’. Inoltre, se nessuna parte di ciò che sta avvenendo è tale che non sia già avvenuta e che avverrà, cioè che sia passato o futuro; e se di ciò che è avvenuto e che avverrà, del tempo trascorso e del tempo a venire non c’è sensazione: semplicemente di nulla esiste una sensazione. Infatti, noi né vediamo il tempo trascorso né quello a venire, né abbiamo qualche altra sensazione delle cose già avvenute o di quelle che avverranno. Nulla, dunque, neppure in sua presenza è un oggetto sensibile, poiché di ciò che è presente sempre una parte ‘sta per’ e una parte ‘è trascorsa’, ossia una parte ‘è avvenuta’ e una parte ‘avverrà’.
§ 43. [1082E] Invero, proprio gli Stoici dicono che Epicuro fa un’affermazione scellerata e violentemente contraria ai concetti di comune buonsenso quando sostiene che tutti i corpi si muovono con la stessa velocità, e non ne lascia neppure uno essere più veloce di un altro. Ma molto più orribile e scellerata di questa ed ancor più discosta dai concetti di comune buonsenso è l’affermazione secondo cui nessun corpo in movimento può essere raggiunto da un altro corpo in movimento, neppure se si trattasse, come dice il proverbio, di una tartaruga inseguita dal veloce cavallo di Adrasto. Eppure è giocoforza che questo accada ai corpi in avanzamento verso il corpo che li precede se, come sostengono gli Stoici, gli intervalli che essi percorrono sono divisibili all’infinito. Infatti, ammesso che la tartaruga preceda il cavallo anche soltanto di un plettro, coloro i quali dividono all’infinito questa distanza e fanno muovere entrambi [1082F] da un punto precedente al punto successivo, non riusciranno mai a mettere l’animale più veloce davanti a quello più lento, giacché il più lento precederà sempre l’altro di un certo intervallo, visto che la distanza tra i due può essere suddivisa in infiniti intervalli. Come può non essere contrario ad ogni concetto di comune buonsenso affermare che l’acqua che viene versata da una coppa o da un calice non sarà mai versata fuori completamente? E come si potrà dire che simile affermazione non è una conseguenza delle dottrine che gli Stoici sostengono? [1083A] Infatti, essendo gli intervalli che i corpi percorrono divisibili all’infinito, non è pensabile che l’avanzamento di un corpo verso il corpo che lo precede possa essere portato integralmente a termine, giacché residuerà sempre un qualche spazio divisibile. E così ogni versamento, ogni scivolamento, ogni scorrimento di un corpo liquido, ogni spostamento di un corpo solido e ogni caduta di un peso lasciato a se stesso saranno sempre movimenti parziali e incompleti.
§ 44. Adesso metto però da parte le molte assurdità sostenute dagli Stoici e mi attengo alla discussione di quelle contrarie ai concetti di comune buonsenso. Il discorso sull’accrescimento è antico, giacché è stato prospettato interrogativamente, come afferma Crisippo, già da Epicarmo. Ora, dato che gli Accademici credono trattarsi di una questione non facile e di non pronta soluzione, gli Stoici hanno urlato loro contro, accusandoli di levare di mezzo le prolessi e di propugnare una filosofia contraria ai concetti di comune buonsenso: [1083B] proprio gli Stoici, i quali non difendono affatto i concetti di comune buonsenso, ed anzi stravolgono anche il modo di intendere le sensazioni. La questione comunque è semplice, e gli Stoici convengono con le premesse gli Accademici. Entrambi infatti assumono: che tutte le sostanze particolari siano in scorrimento e in spostamento, giacché talune parti di sé esse le emettono verso l’esterno, e talune altre provenienti dall’esterno esse le accolgono in sé; che questo andirivieni di parti non permanga costante né per numero né per quantità ma che sia variabile; e che questo permetta così ad ogni particolare sostanza di variare, grazie ai predetti processi di entrata e di uscita di parti. Entrambi sostengono poi che è ingiustamente invalsa la comune consuetudine di chiamare queste trasformazioni ‘accrescimento’ e ‘deperimento’, quando invece converrebbe chiamarle ‘generazioni’ e ‘distruzioni’, perché si tratta di trasformazioni che traghettano i corpi [1083C] da un certo stato ad uno stato diverso, mentre l’accrescimento e la diminuzione sono trasformazioni di un corpo che permane e che le subisce passivamente. E così, una volta dette queste cose e posti questi assunti da parte degli Accademici e degli Stoici, cosa ti sollecitano a credere questi vindici dell’evidenza, questi archipendoli dei concetti di comune buonsenso? Che ciascuno di noi è gemellare, che ha due nature e che è doppio, -non come i poeti credono che siano i Molionidi, ossia unificati per certe parti del corpo e separati per altre- che ha due corpi di identico colore, di identica figura, peso e spazio occupato: cose che prima di loro nessun uomo ha mai visto, giacché sono soltanto gli Stoici ad avere visto questa sintesi, questa duplicità, questa ambiguità per cui ciascuno di noi è due soggetti corporei: [1083D] uno, la sostanza; l’altro, <la qualità>. E che uno dei due sempre scorre ed è portato qua e là, senza aumentare né diminuire pur non restando affatto quello che è. L’altro invece che perdura, s’accresce e diminuisce e sperimenta cose speculari a quelle che sperimenta l’altro, pur essendogli connaturato, conciliato e confuso insieme, ed anche se non ci procura mai da nessuna parte la possibilità di toccare coi sensi la differenza. Eppure si racconta che il famoso Linceo vedeva attraverso le rocce e gli alberi; che un tale, stando in Sicilia, da una torre di osservazione riusciva a vedere le navi Cartaginesi, distanti un giorno e una notte di navigazione, che uscivano dal porto. Si racconta anche che i seguaci di Callicrate e di Mirmecide [1083E] sapessero costruire carri capaci di essere nascosti dalle ali di una mosca, e scrivere col cesello dei versi di Omero su un seme di sesamo. Questa alterità che è in noi, questa differenza, nessuno l’ha mai distinta né sceverata; e noi non abbiamo affatto la sensazione di essere doppi, giacché per un verso siamo sempre in uno stato di flusso ma per un altro verso dalla nascita alla morte rimaniamo sempre gli stessi. Io qui semplifico al massimo la dottrina degli Stoici, giacché essi per la verità individuano in ciascuno quattro soggetti corporei, o piuttosto fanno di ciascuno di noi quattro persone diverse: ma ne bastano già due per rendersi conto dell’assurdità di quanto essi sostengono. Quando nella tragedia noi sentiamo Penteo, [1083F] fuor di senno com’è e con la mente sconvolta, dire che sta vedendo due soli ed una doppia Tebe, non diciamo noi forse non che egli vede ma che ha le traveggole? E non daremo l’addio a questi Stoici i quali suppongono che non una città ma tutti gli uomini, gli animali, tutte le piante, le suppellettili, gli strumenti, i vestiti tutti sono doppi e di doppia natura, e così ci costringono alla paranoia piuttosto che a pensare? Forse in questo caso si possono [1084A] scusare gli Stoici se plasmano soggetti corporei di natura diversa giacché non appare loro possibile altro accorgimento, visto che si fanno un punto d’onore di salvaguardare e serbare intatta l’esistenza dei fenomeni di accrescimento.
§ 45. Quando gli Stoici fabbricano specie diverse di corpi -ho poco bisogno di dirlo- in numero infinito, uno non avrebbe modo di dire se essi lo facciano perché sperimentano qualcosa nel loro animo oppure, al contrario, se lo facciano semplicemente abbellendo delle ipotesi altrui Tuttavia si può ben affermare che essi sfrattano, o meglio ancora aboliscono completamente e trucidano, i concetti di comune buonsenso e la comune consuetudine di fiducia nelle sensazioni, e al loro posto introducono in casa concetti orribili e stranieri. È del tutto assurdo che gli Stoici, mentre fanno delle virtù e dei vizi, e oltre a questi delle arti e di tutti i ricordi, e inoltre delle rappresentazioni, delle passioni, degli impulsi e degli assensi, mentre fanno di tutte queste cose [1084B], ripeto, dei corpi; affermino però che essi non giacciono in alcun corpo né che esiste per essi un luogo, riservando loro soltanto quel poro puntiforme nel cuore dove costipano l’egemonico dell’animo, il quale rattiene in sé una tale quantità di corpi che una gran moltitudine di essi è sfuggita a quanti reputano di demarcarli e distinguerli uno dall’altro. Il farne poi non soltanto dei corpi ma anche degli esseri animati dotati di ragione e il confinare nei nostri cuori uno sciame tanto grande di creature né amichevoli né mansuete ma una turba avversa ed ostile, e il far apparire ciascuno di noi come un grande parco, una fattoria, un cavallo di legno o qualunque cosa uno possa pensare per designare le creature che gli Stoici plasmano, è un fatto di iperbolica illegalità ai danni della evidenza e della comune consuetudine. Gli Stoici sostengono poi che siano esseri viventi non soltanto le virtù e i vizi, non soltanto le passioni, le ire, le invidie, [1084C] le afflizioni, il godimento per i mali altrui, né le apprensioni certe, le rappresentazioni, le ignoranze, le arti; ma che lo siano anche la calzoleria e la metallurgia. Oltre a queste, gli Stoici fanno diventare corpi ed esseri viventi pure le attività: la passeggiata è un essere vivente; lo sono la danza, il mettersi le scarpe, il saluto e l’ingiuria. A queste s’accompagnano e sono esseri viventi anche la risata e il lamento. E se lo sono queste cose, è di tutta evidenza che lo sono anche la tosse, lo sternuto, il gemito e sicuramente lo sputo, il soffiarsi il naso e così via. Gli Stoici non siano dunque malcontenti d’essere condotti a queste conclusioni da un ragionamento passo passo; memori che Crisippo, nel primo libro delle ‘Ricerche fisiche’ [1084D] così s’appressa alle sue: “Non è che la notte è corpo, mentre invece la sera, l’alba e la mezzanotte non sono corpi. Né è corpo il giorno e invece non sono corpi il primo, il dieci, il quindici e il trenta del mese. Il mese è corpo, e lo sono anche l’estate, l’autunno e l’anno”.
§ 46. Queste conclusioni vanno per forza contro i preconcetti di comune buonsenso, ma quelle altre vanno contro i loro stessi preconcetti, giacché gli Stoici fanno generare l’entità più calda da un forte raffreddamento, e quella più finemente particellare da un infittimento. Infatti, l’animo è appunto l’entità più calda e più finemente particellare, che essi fanno però nascere da un forte raffreddamento e infittimento del corpo, [1084E] visto che lo pneuma si trasforma per tempra, diventando da pneuma vegetale pneuma animale. Essi dicono che anche il sole diventa ‘animato’ quando l’umidità si trasforma in fuoco cognitivo. Sembra proprio il caso di pensare che anche il sole sia generato da un forte raffreddamento. Una volta Senofane, quando un tale stava raccontando d’avere visto delle anguille che vivevano in acque calde, gli disse: “Dunque le faremo bollire in acqua fredda”. Secondo gli Stoici questa battuta sarebbe conseguente, se appunto il forte raffreddamento genera le cose più calde e se è per infittimento che si generano le cose più leggere; dal calore, a loro volta, si generano le cose fredde, per effusione le cose fitte e per diradamento le cose pesanti: giacché è con l’irrazionalità che gli Stoici preservano la intrinseca coerenza teorica delle loro dottrine.
§ 47. [1084F] Ma ciò che gli Stoici suppongono sostanza e genesi del concetto stesso non è già contrario al comune buonsenso? Il concetto è infatti una rappresentazione, e la rappresentazione è una impronta nell’animo. Natura dell’animo è quella di essere un’esalazione che è difficile e laboriosa da modellare a causa della sua radezza, ed è impossibile che essa serbi l’impronta che ha accolto. Infatti, poiché trae il suo nutrimento e la sua genesi da sostanze umide, [1085A] l’animo è in continua accrezione e in continua spendita; e la mistione del respiro con l’aria fa sempre nuova l’esalazione, che si altera e tramuta ad opera del canale d’aria che dal di fuori vi affluisce e poi ne defluisce. Infatti si potrebbe pensare che una corrente d’acqua in movimento conservi intatte fattezze, impronte e forme molto meglio di uno pneuma che si sposta su e giù entro vapori umidi e che si mescola continuamente con uno pneuma inerte ed estraneo proveniente dall’esterno. Ma gli Stoici sono così disattenti a quel che dicono, da definire i concetti come delle intellezioni messe bene in disparte, i ricordi come impressioni durature e stabilizzate; [1085B] da fissare assolutamente le scienze come conoscenze dotate di immutabilità e saldezza, e poi da sottoporre loro come base e come sede una sostanza lubrica e dispersa, sempre portata su e giù e sempre in fluire.
§ 48. Il concetto di comune buonsenso di ‘elemento’ o ‘principio’ che in tutti gli uomini è -per dir così- innato, è che esso sia semplice, pretto, incomposto: giacché né elemento né principio può essere ciò ch’è mescolato bensì ciò di cui una miscela risulta composta. Invece gli Stoici che fanno di dio, il quale è un principio, un corpo cognitivo ed una mente insita nella materia, lo rivelano con ciò né semplice, né puro, né incomposto, ma come un principio risultante da altro e attraverso altro. La materia invece, di per sé alogica e priva di qualità, [1085C] possiede il carattere di principio semplice e primigenio. Dunque dio, dato che è né incorporeo né immateriale, ha partecipato della materia come principio. Ora, se la materia e il logos sono un’unica e identica cosa, essi non hanno fatto bene a definire la materia come qualcosa di alogico. Se invece la materia e il logos sono cose distinte, dio potrebbe essere una sorta di dispensiere di entrambi, e non sarebbe semplice ma composto, avendo aggiunto alla cognitività la corporeità presa dalla materia.
§ 49. Benché designino col nome di primi elementi i quattro corpi: terra, acqua, aria e fuoco; io non so come gli Stoici possano fare degli uni, elementi puri e semplici; e degli altri, invece, corpi composti e mischiati. Infatti, essi affermano che la terra e l’acqua [1085D] non sono in grado di tenere insieme né se stesse né altro, e che serbano intatta la loro unità grazie alla partecipazione della forza propria di uno pneuma igneo. L’aria e il fuoco, invece, sono in grado di tenersi insieme grazie alla loro eutonia e, frammischiandosi a quegli altri due elementi, forniscono loro tono, durata e sostanzialità. Come può ancora essere considerato un elemento la terra, o l’acqua, se non è semplice né primo né bastante a se stesso, ma sempre bisognoso di ciò che dall’esterno la tiene insieme e la salvaguarda in essere? Gli Stoici non hanno lasciato una loro precisa nozione di ‘sostanza’, e così il discorso sulla terra come di per sé un corpo definito ma non una sostanza, resta circondato da molta confusione e oscurità. Inoltre, se è di per sé terra, come fa ad avere bisogno dell’aria che la consolida e la tiene coesa? [1085E] Ma tali non sono di per sé né la terra né l’acqua. Invece, la materia diventa ‘terra’ quando l’aria la combina ed infittisce in un certo modo; e diventa, al contrario, ‘acqua’ quando sia dissolta e rammollita in un certo modo. Nessuno di questi due è dunque un elemento, se è qualcos’altro a procurare ad entrambi sostanza e genesi.
§ 50. Essi dicono inoltre che la sostanza o materia fa da sostegno alle qualità, sì che questo fatto quasi ce ne dà la definizione; e poi fanno delle qualità, a loro volta, sostanze e corpi. Ciò è molto sconcertante. Infatti, se le qualità hanno una loro peculiare sostanza grazie alla quale sono chiamate e sono ‘corpi’, non hanno alcun bisogno di un’altra sostanza giacché posseggono già la loro. [1085F] Se invece fa loro da sostegno quest’unica entità comune che essi chiamano sostanza o materia, è manifesto che le qualità partecipano del ‘corpo’ ma non sono ‘corpi’, giacché ciò che fa da sostegno ed accoglie necessariamente è differente da ciò ch’è accolto e cui fa da sostegno. Essi insomma guardano solo alla metà dei fatti, giacché chiamano la materia ‘priva di qualità’ [1086A] e poi non vogliono chiamare le qualità ‘immateriali’. Tuttavia, com’è possibile pensare un corpo senza qualità, se non si pensa ad una qualità senza corpo? Infatti, il ragionamento che intreccia un corpo ad ogni qualità vieta all’intelletto di concepire un corpo che sia privo di una qualche qualità. Quindi sembra che chi si oppone all’incorporeità della qualità si oppone anche all’assenza di qualità della materia; oppure che chi esclude l’una dall’altra separa doppiamente entrambe. Il ragionamento che alcuni di loro ci mettono innanzi, denominando la sostanza ‘priva di qualità’ non perché ad essa manchi ogni qualità ma perché le ha tutte, è contrarissimo ad ogni concetto di comune buonsenso. [1086B] Nessuno infatti pensa privo di qualità ciò che le ha tutte, né impassibile ciò ch’è nato per sperimentare ogni passione, né immobile ciò che può muoversi in ogni direzione. E se la materia è sempre pensata associata ad una qualità, il pensarla altra e differente dalla qualità rimane tuttavia sempre possibile.