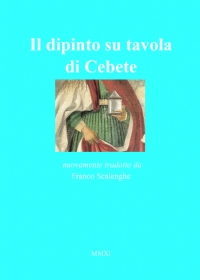Libro I
Introduzione
Quelli che la tradizione ha raccolto sotto il generico nome di ‘Memorabilia’, ovvero di ‘Detti e fatti memorabili’, sono appunti disparati che Senofonte scrisse in tempi diversi e senza un ordine preciso. L’unico elemento che appare tenerli uniti è la presenza costante del personaggio ‘Socrate’, come visto ed interpretato da Senofonte.
Per comodità, io ho raccolto ciascun appunto in altrettanti paragrafi. Gli appunti che formano il Libro I sono in totale 23, e l’argomento di ciascuno di essi è il seguente:
Appunto 1 – [I,I,1-9] Riflessioni di Senofonte circa la vacuità delle argomentazioni, con le quali gli accusatori riuscirono a convincere gli Ateniesi che Socrate meritava la condanna a morte.
Appunto 2 – [I,I,10-15] Perché Socrate non discusse mai della generazione del Cosmo, limitandosi a ritenere che tali questioni fossero per gli uomini di impossibile soluzione.
Appunto 3 – [I,I,16-20] Socrate giudicava uomini ‘virtuosi’ quanti conoscevano le risposte a domande sulle faccende umane, e giudicava ‘schiavi’ quanti ignoravano tali risposte.
Appunto 4 – [I,II,1-3] Senofonte nota con stupore come gli Ateniesi, pur contro ogni evidenza, fossero persuasi della colpevolezza di Socrate in quanto corruttore dei giovani.
Appunto 5 – [I,II,4-8] Socrate non trascurava la cura del corpo ma ne disapprova l’eccesso, tanto quanto disapprovava la smania per il denaro.
Appunto 6 – [I,II,9-11] Socrate era accusato di aizzare la gioventù a disdegnare le leggi vigenti e quindi alla violenza, in quanto criticava l’assegnazione a sorte delle cariche pubbliche.
Appunto 7 – [I,II,12-38] Senofonte racconta per filo e per segno come Crizia, Alcibiade e Caricle divennero dapprima amici di Socrate, e successivamente si trasformarono in delinquenti.
Appunto 8 – [I,II,39-48] Una discussione tra Pericle ed Alcibiade su cosa siano le ‘leggi’. Chi furono i veri amici di Socrate?
Appunto 9 – [I,II,49-55] Un’altra accusa rivolta a Socrate era quella di insegnare ad infangare la figura del proprio padre, e quella dei propri amici.
Appunto 10 – [I,II,56-57] Quali erano gli uomini che Socrate definiva ‘laboriosi’ e quali uomini definiva ‘oziosi’.
Appunto 11 – [I,II,58-59] La critica di Socrate ad alcuni versi dell’Iliade di Omero.
Appunto 12 – [I,II,60-61] Popolare e filantropo qual era, Socrate era sempre disponibile a discorrere con chiunque. E quanti discorrevano con lui, sempre se ne congedavano migliori di prima.
Appunto 13 – [I,II,62-64] Socrate non fu mai all’origine, né mai fu causa, di sedizione o di guerra.
Appunto 14 – [I,III,1-4] Per Socrate, il culto degli dei e la celebrazione di riti sacrificali andavano mantenuti entro i limiti delle possibilità economiche di ciascuno.
Appunto 15 – [I,III,5-7] Uno stile di vita capace di educare tanto l’animo quanto il corpo.
Appunto 16 – [I,III,8-15] Le esortazioni di Socrate a proposito del godimento dei piaceri sessuali. L’esempio di Critobulo e del figlio di Alcibiade.
Appunto 17 – [I,IV,1] La capacità di Socrate, non soltanto di esortare alla virtù ma anche di prendere gli uomini con sé e di condurli fino ad essa.
Appunto 18 – [I,IV,2-19] Ciò che una volta Socrate, a proposito degli dei e del proprio démone, disse discorrendo con Aristodemo.
Appunto 19 – [I,V,1-6] Socrate parla della virtù della temperanza.
Appunto 20 – [I,VI,1-10] Socrate discorre con Antifonte di felicità e di infelicità.
Appunto 21 – [I,VI,11-14] Socrate discute con Antifonte sulla possibilità di essere una persona giusta ed insieme una persona sapiente.
Appunto 22 – [I,VI,15] Socrate risponde ad Antifonte circa il miglior modo di occuparsi di politica.
Appunto 23 – [I,VII,1-5] Socrate spiega perché il tenersi il più lontano possibile dalla millanteria coincida già con l’essere vicinissimi alla virtù.
Traduzione
[I,I,1] Spesso mi sono chiesto con stupore, quali fossero le argomentazioni con le quali gli accusatori di Socrate riuscirono a convincere gli Ateniesi che egli, secondo le leggi dello Stato, meritava la condanna a morte. Infatti, l’atto di accusa contro di lui, suonava all’incirca così: “Socrate è colpevole di delegittimare gli dei che lo Stato ritiene legittimi, e di introdurre nuovi ed inauditi démoni. Inoltre egli è colpevole anche del reato di corruzione dei giovani”. [I,I,2] In primo luogo: di quali prove testimoniali si servirono gli accusatori, per dimostrare che Socrate riteneva illegittimi gli dei che lo Stato invece legittimava? Egli, infatti, offriva sacrifici sotto gli occhi di chiunque: molte volte in casa, ma spesso anche sui pubblici altari; né si nascondeva quando praticava la divinazione, giacché la sua affermazione che fosse un démone a segnalargli cosa fare, era cosa notoria. È soprattutto da questa affermazione, io credo, che sia nata l’accusa a Socrate di introdurre nuovi ed inauditi démoni. [I,I,3] Eppure, in realtà, egli non introdusse usanza alcuna più nuova ed inaudita di quelle introdotte da quanti, legittimando la divinazione, traggono auspici dal volo degli uccelli, da responsi oracolari, da segnali premonitori o da cerimonie sacrificali. Costoro non pensano che gli uccelli o i segni in cui si imbattono, conoscano cos’è utile per loro; ma che siano gli dei a segnalarlo loro per il tramite di quelli: e questo era ciò che anche Socrate riteneva. [I,I,4] Ma, mentre la maggioranza degli uomini afferma che sono il volo degli uccelli o i segni in cui ci si imbatte, che fanno allontanare oppure che spronano a certe azioni; Socrate riferiva il tutto a ciò che conosceva: ossia diceva che era un démone a segnalargli cosa fare. Sicché erano molti i sodali ai quali egli suggeriva di fare certe cose o di non farne delle altre, a seconda di quanto gli preannunciava il démone. Ed a quanti di loro ubbidivano al démone, ciò tornava utile; mentre quanti non gli ubbidivano, avevano poi di che pentirsene. [I,I,5] Chi non sarebbe d’accordo nel dire che Socrate non voleva certo mostrarsi sciocco o cialtrone agli occhi dei suoi sodali? Egli avrebbe invece dimostrato di essere entrambe le cose, predicendo falsamente qualcosa come si trattasse di una rivelazione divina. È quindi manifesto che egli nulla avrebbe predetto, se non con la certezza che la sua profezia si sarebbe avverata. E per le profezie, di chi altro si fiderebbe chiunque, se non di un dio? Ed avendo fiducia negli dei, come poteva Socrate ritenere che gli dei non esistono? [I,I,6] Con quanti aveva maggiore familiarità, egli era uso comportarsi in questo modo. Circa le cose assolutamente necessarie, egli consigliava loro di effettuarle comunque, e nel modo che essi ritenevano il migliore possibile. Circa le cose di incerta riuscita, egli li mandava a consultare l’oracolo, affinché ne tornassero sapendo se esse andavano effettuate. [I,I,7] A coloro che intendevano bene amministrare case o città intere, egli solitamente ripeteva che essi abbisognavano della divinazione. Infatti, del fare il falegname, o il fabbro, o l’agricoltore, o il comandante militare; e di siffatte attività diventare supervisore, controllore, economo, pianificatore: ebbene, egli riteneva che tali nozioni potessero essere apprese con l’aiuto del semplice intelletto umano. [I,I,8] Ma riteneva anche che le nozioni più segrete e profonde, gli dei le avevano riservate a loro stessi; sicché di esse, nessuna era agli uomini manifesta. Infatti, chi ha bene seminato il campo è del tutto ignaro di chi ne raccoglierà i frutti. Chi ha bene edificato una casa, non sa assolutamente chi l’abiterà. Lo stratega ignora del tutto se gli sia utile il comandare una certa spedizione militare. Il politico non sa affatto se gli sia utile prendere il governo dello Stato. Chi ha sposato una bella ragazza per godersela, ignora del tutto se andrà incontro ad un mare di guai per causa sua. Chi ha stabilito rapporti di parentela con uomini assai influenti nello Stato, non sa assolutamente se proprio da costoro sarà esiliato dallo Stato. [I,I,9] Socrate diceva anche che quanti credono che nessuna di siffatte nozioni più segrete e profonde sia comunicata a noi dai démoni, e che esse, anzi, siano tutte attingibili dall’intelletto umano, ritengono di essere dei démoni essi stessi. Sicché démoni si credono quanti interrogano l’oracolo su cose che gli dei hanno invece già posto in potere degli uomini, i quali sono capaci di distinguere da soli quale sia la risposta. Per esempio, credono di essere démoni coloro che interrogano l’oracolo chiedendo se sia meglio prendere per sé un conduttore di carri molto esperto nella guida, oppure uno che non lo è affatto; un pilota di nave che ha grande esperienza di viaggi per mare, oppure uno che non ne sa nulla; e così pure si credono démoni coloro che interrogano l’oracolo su cose che noi possiamo benissimo enumerare, misurare in lunghezza oppure pesare. Sicché egli riteneva che quanti pongono agli dei delle domande di questo genere, facciano richieste illegittime. Diceva, dunque, che noi dobbiamo imparare quali siano le cose che gli dei hanno messo in nostro potere; mentre quelle che rimangono a noi celate, dobbiamo tentare di conoscerle attraverso la divinazione; e che si tratta di rivelazioni che gli dei fanno soltanto a coloro con i quali intendono essere benevoli.
[I,I,10] Era abitudine di Socrate quella di stare sempre all’aria aperta. La mattina se ne andava a passeggio e per palestre; e quando la piazza del mercato s’era riempita, lo si trovava sempre in mezzo alla gente. Per il restante della giornata, egli s’intratteneva di solito nei luoghi più affollati; dove parlava il più possibile, e chiunque volesse poteva ascoltarlo. [I,I,11] Nessuno mai udì Socrate dire una sola parola empia, né mai lo vide effettuare un solo atto sacrilego. Né egli soleva discutere degli argomenti di cui discuteva la maggior parte delle altre persone, ossia della Natura dell’Universo, e di come fu generato quello che i sofisti chiamano ‘Cosmo’, ed a quali cogenti leggi ubbidisca l’orbita di ciascun corpo celeste; ma anzi mostrava che quanti si preoccupano di siffatti problemi chiacchierano a vanvera. [I,I,12] Innanzitutto, infatti, egli cercava di capire se costoro fossero giunti ad occuparsi di siffatte questioni, dopo essere certi di avere ormai sviscerato a sufficienza tutte le faccende umane; oppure se, una volta messe da canto le faccende umane e studiando quelle che riguardano i démoni, essi ritengano di stare facendo ciò che loro davvero conviene. [I,I,13] Lo stupiva assai il fatto che non fosse loro evidente come queste questioni siano per gli uomini impossibili da risolvere; giacché anche i più esperti di simili problemi dichiarano di non avere affatto tutti le stesse opinioni al riguardo; ed anzi di trovarsi, gli uni verso gli altri, alla stessa stregua dei pazzi. [I,I,14] Infatti, alcuni pazzi non hanno timore neppure delle cose più terribili; altri invece hanno paura anche di ciò che paura non fa. Ad alcuni non appare affatto vergognoso dire o fare qualunque cosa in mezzo alla folla; mentre ad altri sembra che neppur si debba uscir di casa e mescolarsi con gli uomini. Altri non onorano sacrari, né altari, né qualunque cosa divina; mentre altri venerano dei sassi, dei pezzi di legno in cui si imbattono casualmente, e pure le belve. Di coloro che si affannano circa la Natura dell’Universo, ad alcuni pare che tutto ciò che esiste sia una entità sola; ad altri invece che la moltitudine degli enti sia infinita. Ad alcuni pare che tutte le cose siano in perpetuo movimento; ad altri che esse non siano mai mosse. Ad alcuni sembra che tutte divengono e poi decadono; ad altri invece che esse sarebbero né mai divenute, né mai decadute. [I,I,15] Circa costoro, egli cercava inoltre di capire se, come quanti hanno imparato tutto delle faccende umane, ritengono di potere poi applicare a proprio vantaggio o a vantaggio di chiunque loro vogliano, qualunque cosa abbiano imparato; allo stesso modo, anche quanti hanno indagato le faccende divine, una volta conosciute le leggi per cui ciascuna di esse avviene, potranno poi farla accadere quando vogliano: dico, i venti, le piogge, le stagioni e qualunque altro simile fenomeno di cui abbiano bisogno; oppure se neanche sperano di riuscire a tanto, ed a loro basta la conoscenza delle cause per cui ciascuno di tali fenomeni avviene.
[I,I,16] Queste erano dunque le cose che Socrate diceva a proposito di coloro che si occupano di tali questioni. Quanto a lui, egli sempre discuteva delle faccende umane: cos’è pio, cos’è empio, cos’è bello, cos’è brutto, cos’è giusto, cos’è ingiusto, cos’è temperanza, cos’è intemperanza, cos’è virilità, cos’è viltà, cos’è Stato, cos’è politica, cos’è il governo di uomini, cos’è il governatore di uomini; e di altre faccende simili, ritenendo ‘uomini dabbene’ quanti conoscevano le risposte a queste domande, e che invece erano stati giustamente chiamati ‘schiavi’ quanti tali risposte ignoravano. [I,I,17] Ora, su questioni circa le quali non era noto cosa Socrate pensasse, non c’è da stupirsi che i giudici possano avere emesso un verdetto sbagliato; ma su fatti di cui tutti erano al corrente, non sorprende che i giudici non abbiano riflettuto a dovere? [I,I,18] Infatti, quando egli divenne membro del Consiglio dei Cinquecento, dopo avere prestato il rituale giuramento nel quale era previsto l’obbligo di rispettare strettamente le leggi vigenti, gli accadde di essere sorteggiato quale Presidente dell’Assemblea Generale. Ora, accadde che ad un certo punto la maggioranza dei presenti divenne smaniosa di approvare, seduta stante e con una sola votazione, la condanna a morte e l’uccisione di nove Ammiragli, tra i quali erano compresi Trasillo ed Erasinide. Questa unica votazione era del tutto contraria alla legge, e Socrate, quale Presidente dell’Assemblea, si rifiutò fermamente di metterla ai voti, benché avesse contro la maggioranza del popolo, e fosse sotto la minaccia di molti ed influenti personaggi presenti. Eppure egli dimostrò così di tenere in maggior conto il giuramento fatto, che l’andare contro la giustizia per riuscire gradito al popolo, e proteggersi così dalle accuse di quanti lo minacciavano. [I,I,19] Infatti, egli riteneva che gli dei si prendano cura degli uomini, ma non nel modo in cui lo crede la maggioranza della gente. Costoro credono che gli dei conoscano alcune cose, ma che altre non le conoscano. Socrate riteneva invece che gli dei sappiano tutto: tanto le parole che pronunciamo, quanto le azioni che facciamo e le deliberazioni che concepiamo; e che essi siano presenti dappertutto, e che inviino agli uomini segnali riguardanti tutte le cose umane. [I,I,20] Pertanto, grande è il mio stupore, se penso a come gli Ateniesi abbiano potuto essere persuasi che Socrate, circa gli dei, non la pensava da saggio. Proprio lui che, circa gli dei, mai aveva dato il minimo segno di empietà, né in parole, né in opere; ed anzi aveva detto e fatto cose che, in parole ed in opere, sarebbero davvero, e verrebbero giustamente ritenute, quelle del più pio di tutti gli uomini.
[I,II,1] A me pare anche stupefacente la persuasione di taluni che Socrate fosse colpevole di corruzione dei giovani. Proprio lui che, innanzitutto, in fatto di cosiddetti piaceri sessuali e di quelli della tavola, era il più morigerato di tutti gli uomini. In secondo luogo, proprio lui che davanti ai rigori invernali, alle calure estive e ad ogni sorta di fatica era resistentissimo; e inoltre talmente allenato ad avere bisogno di qualunque cosa con una moderazione tale, che quel pochissimo che possedeva gli era facilmente più che bastante. [I, II,2] Come avrebbe potuto un uomo simile, essendo chi era, far sì che altri giovani fossero empi, delinquenti, ghiottoni, ingolfati nei piaceri sessuali, mollaccioni dinanzi alla fatica? Anzi, egli a molti di costoro fece smettere questi vizi, li fece smaniare per la virtù, dando loro la speranza che, se avessero avuto cura di se stessi, sarebbero diventati uomini dabbene. [I,II,3] Eppure egli non promise mai, in nessuna circostanza, di essere loro maestro in ciò; ma con l’essere ed il rimanere egli manifestamente l’uomo che era, faceva sperare i suoi interlocutori che, imitando lui, tali sarebbero diventati.
[I,II,4] Socrate non trascurava la cura del corpo, e non lodava quanti invece la trascurano. Disapprovava l’eccesso di alimentazione accoppiata all’eccesso di fatica, ed approvava invece come sufficiente la quantità di fatica che l’animo è in grado di risentire come piacevole. Egli soleva dire che questa è la quantità di fatica sana e sufficiente per il corpo, e quella che non intralcia la sollecitudine che dobbiamo avere per l’animo. [I,II,5] Affettato o pretenzioso non era di certo, né nel modo di vestire né in quello di calzare, e neppure nel suo tenore di vita in generale. Non faceva dei suoi compagni degli appassionati del denaro. Anzi, mentre raffreddava le altrui smanie per esso, si guardava bene dal trasformare in denaro per se stesso la smania altrui di stare in sua compagnia. [I,II,6] Astenendosi infatti da questa pratica, egli giudicava di darsi cura della propria libertà; e soprannominava ‘schiavisti di se stessi’, quanti vendevano la loro conversazione contro un pagamento in denaro, giacché in tal modo diventava per essi obbligatorio dialogare con coloro dai quali venivano pagati. [I,II,7] Socrate era poi stupito dal fatto che qualcuno, professando di insegnare la virtù, guadagnasse del denaro e non ritenesse, invece, che il suo incomparabilmente maggior guadagno sarebbe stato l’acquisizione di un buon amico. Insomma, che costui avesse paura che chi è diventato davvero virtuoso, non abbia poi somma gratitudine verso colui che gli ha reso il più grande dei benefici. [I,II,8] Socrate non professò mai di insegnare la virtù, né promise mai alcunché di simile a nessuno; ma era invece fiducioso che quanti dei suoi seguaci avevano accolto i principi da lui valutati come positivi, per tutta la vita sarebbero stati buoni amici suoi e buoni amici tra di loro. Dunque, come potrebbe un uomo siffatto corrompere i giovani? A meno che il prendersi ogni cura della virtù sia ‘corrompere’.
[I,II,9] Ma per Zeus, diceva l’accusatore, Socrate faceva sì che i suoi seguaci disdegnassero le leggi vigenti, sostenendo che era da stupidi eleggere quali giudici gente estratta a sorte tra tutti i cittadini; quando invece nessuno vorrebbe utilizzare l’estrazione a sorte per la scelta del pilota di una nave, né di un falegname, né di un flautista, né per alcun altro mestiere che abbisogna di specialisti, i cui errori comunque causano danni molto più lievi di quelli commessi da chi è alla guida dello Stato. Discorsi simili, sosteneva l’accusa, aizzano i giovani a disprezzare il presente Governo e fanno di essi dei violenti. [I,II,10] Io credo invece che quanti praticano costantemente la saggezza e si ritengono capaci di istruire i propri cittadini su ciò che davvero è loro utile, non diventino affatto violenti. Essi sanno bene come alla violenza si congiungano inimicizie personali e pericolose; mentre con la persuasione si ottengano gli stessi risultati senza pericolo alcuno ed amichevolmente. Le vittime di una violenza, infatti, odiano quanti hanno loro sottratto qualcosa; mentre se sono stati persuasi con le buone maniere, si sentono gratificati e mostrano amicizia. Dunque l’uso della violenza non appartiene a quanti praticano la saggezza, ma a coloro il cui potere non è associato ad intelligenza alcuna. [I,II,11] Invero, chi ha l’audacia di usare la violenza abbisogna di non pochi complici, mentre chi è capace di persuadere non ha bisogno di alcun aiuto, dal momento che ritiene certo bastargli la sua capacità di persuasione. A uomini simili non accade mai di commettere omicidi. Chi, infatti, preferirebbe assassinare qualcuno piuttosto che contare su di un vivo e fidato seguace?
[I,II,12] Ma, sosteneva ancora l’accusatore, una volta diventati discepoli di Socrate, i due, ossia Crizia ed Alcibiade, furono entrambi causa di moltissimi mali per lo Stato. Di tutti i membri del Governo oligarchico, infatti, Crizia fu il più dedito al latrocinio, alle violenze e agli assassini; mentre Alcibiade, per parte sua, dell’insieme dei membri del Governo democratico fu di tutti il più impudente, il più oltraggioso e il più violento. [I,II,13] Se quei due hanno arrecato gravi danni allo Stato, io, per parte mia, non sono affatto qui per ergermi a loro difensore; ma intendo piuttosto raccontare come nacquero le loro abituali frequentazioni con Socrate. [I,II,14] Accadde dunque che questi due individui, ciascuno per sua natura, volessero diventare i più onorati e rispettati di tutti i cittadini Ateniesi; e che tutto il potere fosse nelle loro mani, così da diventare capi di Stato supremi ed indiscussi. Entrambi sapevano bene che Socrate, con le pochissime risorse di cui disponeva, menava una vita di totale indipendenza; che egli era morigeratissimo quanto a qualunque forma di piacere; e che, con il ragionamento, egli era in grado di condurre alle conclusioni che volesse tutti coloro che discutevano con lui. [I,II,15] Osservando che questi erano i fatti, ed essendo tali individui della predetta natura, qualcuno affermerebbe che ambedue smaniavano di condurre la vita di Socrate, imitando la temperanza che quello praticava; oppure che ambedue desideravano le conversazioni con lui perché entrambi sarebbero diventati così più efficaci parlatori ed esecutori dei loro progetti? [I,II,16] Quanto a me, io ritengo che se un dio avesse concesso loro di vivere tutta la vita come l’avevano vista vivere da Socrate, oppure di morire: ebbene, ambedue avrebbero scelto senza dubbio di morire. Ciò divenne evidente dalle azioni che i due effettuarono. Infatti, non appena essi ritennero di essere diventati superiori ai loro colleghi, subito abbandonarono Socrate e si buttarono nella politica, che era lo scopo per cui entrambi avevano desiderato l’amicizia di Socrate. [I,II,17] Forse a queste parole qualcuno obietterebbe che Socrate doveva insegnare ai discepoli per prima cosa la temperanza, e soltanto dopo parlare loro di politica. Io questo non lo nego, ma osservo che i maestri mostrano ai discepoli come essi stessi per primi mettano in opera ciò che professano, accostando poi ai fatti anche le parole. [I,II,18] Io so che anche Socrate dimostrava ai suoi discepoli di essere lui per primo un uomo virtuoso, e che dialogava splendidamente sulla virtù e su tutte le altre faccende umane. E so pure che quei due si comportavano con temperanza finché erano in presenza di Socrate, non per paura di essere puniti o malmenati da lui, ma credendo davvero che, in quelle circostanze, questa fosse per loro la cosa più opportuna da fare. [I,II,19] Forse molti di coloro che si dicono filosofi praticanti, sosterranno l’impossibilità che l’uomo giusto diventi ingiusto, che il temperante diventi oltraggioso; e che chi ha appreso qualcosa di cui c’è apprendimento, possa mai diventarne ignorante. A questo proposito io non la penso così. Osservo, infatti, che come quanti non esercitano costantemente il loro corpo sono poi incapaci di compiere le azioni ad esso richieste; così pure quanti non esercitano costantemente il proprio animo, sono poi incapaci di compiere le azioni ad esso richieste. E in questo modo costoro diventano incapaci sia di effettuare quanto va effettuato, sia di astenersi da quanto ci si deve astenere. [I,II,20] Perciò i padri tengono i figli, anche qualora siano ragazzi giudiziosi, lontani dalla frequentazione di uomini malvagi; giacché mentre la compagnia di uomini probi è già di per sé un esercizio di virtù, quella di uomini malvagi è già la completa dissoluzione di essa. Di ciò è testimone anche quello tra i poeti, che dice:
‘è dai prodi che imparerai le prodezze;
ma mescolato ai dissennati perderai anche il senno che hai’
e quell’altro che dice:
‘nondimeno, un uomo virtuoso a volte è vizioso;
altre volte è un prode’
[I,II,21] La mia testimonianza è in accordo con le loro parole. Osservo, infatti, che come quanti trascurano di ripetere costantemente le composizioni poetiche in versi, finiscono poi per dimenticarle; così pure quanti non curano la continua ripetizione dei discorsi didascalici, lasciano che essi vadano a finire nel dimenticatoio. E qualora uno abbia dimenticato i discorsi che mettono in guardia la mente, sono stati dimenticati anche i discorsi per i quali smaniava l’animo nostro quando si pasceva di temperanza. Dunque non sorprende che chi ha dimenticato tali discorsi si sia scordato anche della temperanza. [I,II,22] Osservo, inoltre, che quanti si sono lasciati attirare al bere, e che quanti sono inviluppati in tresche amorose, sono meno capaci di curarsi di ciò che merita cura e di tenersi lontani da ciò che non la merita. E molte persone che prima di innamorarsi erano capaci di gestire i propri risparmi, ne diventano incapaci da innamorati, sperperano il loro denaro, e non si astengono più da quei guadagni da cui si tenevano in precedenza lontani poiché li ritenevano vergognosi. [I,II,23] Com’è dunque fattibile che chi in precedenza era temperante tutt’a un tratto non lo sia più; e che da individuo capace di effettuare azioni giuste, egli ne divenga di botto incapace? A me sembra, pertanto, che tutte le azioni virtuose vadano continuamente messe in pratica: che si tratti dunque di una questione di costante esercizio, in particolar modo per la temperanza. È infatti nel nostro corpo stesso che sono stati connaturati all’animo quei piaceri che lo persuadono a non essere temperante, ed a gratificare invece, il più in fretta possibile, proprio quelli ed il corpo. [I,II,24] Finché furono sodali di Socrate, Crizia e Alcibiade riuscirono, avendo lui come alleato, a tenere a freno le loro smanie viziose. Quando però entrambi si allontanarono da Socrate, Crizia fuggì in esilio in Tessaglia, e lì fece comunella con uomini dediti all’illegalità piuttosto che alla giustizia. A sua volta Alcibiade, a causa del suo bell’aspetto essendo terreno di caccia di molte signore del gran mondo; subendo, grazie all’ascendente di cui godeva in città e presso gli alleati, le lusinghe di numerosi uomini di potere; e recitando facilmente il ruolo di primattore grazie al favore popolare di cui godeva: come accade agli atleti che primeggiano facilmente nelle gare e quindi trascurano di allenarsi, così anch’egli non si curò più di se stesso. [I,II,25] Dati questi fatti: due individui orgogliosi per la loro nascita, esaltati per le loro ricchezze, boriosi per il loro potere, lusingati da molti uomini; cosa c’è di sorprendente se entrambi, per tutti questi motivi e per essere stati a lungo lontani da Socrate, divennero oltracotanti? [I,II,26] E poi, se i due commisero delle malefatte, l’accusatore ne accagiona Socrate? E del fatto che Socrate li conobbe entrambi da giovani, quando verosimilmente si è più scriteriati e più sregolati, e ne fece due persone temperanti: ebbene l’accusatore non ritiene Socrate degno neppure della minima lode? In altri casi almeno, non è certo così che si giudica. [I,II,27] Quale flautista, quale citaredo, quale altro maestro che abbia fatto dei propri allievi dei musicisti capaci, è responsabile del fatto che poi essi, frequentando un altro maestro, suonino peggio? Qualora un figlio che passa molto tempo in compagnia di una persona temperante, diventi successivamente malvagio a causa della continua frequentazione di un’altra persona: ebbene, quale padre incolpa di ciò il primo amico del figlio e invece non lo loda, tanto più quanto più il figlio si mostra peggiore in seguito alla frequentazione del secondo amico? I padri stessi, qualora siano persone temperanti, pur convivendo con i figli sono non responsabili delle malefatte di questi ultimi. [I,II,28] Giustizia voleva che anche Socrate fosse giudicato allo stesso modo. Se dunque egli avesse commesso qualche azione spregevole, sarebbe apparsa del tutto verosimile la sua malvagità. Ma se invece egli aveva trascorso tutta la sua vita praticando costantemente la temperanza; come poteva egli, secondo giustizia, essere ritenuto responsabile di una viziosità che non risiedeva affatto in lui? [I,II,29] E tuttavia se, pur senza fare alcunché di malvagio, vedendo gli altri due effettuare azioni spregevoli, <Socrate> li lodava: allora egli giustamente sarebbe stato da rimproverare. A questo proposito, quando si accorse che Crizia voleva diventare l’amante di Eutidemo, e che cercava di abusare di lui come fanno quanti godono dei piaceri sessuali legati al corpo; Socrate lo trattenne dal farlo, dicendogli che il mendicare l’elemosina dall’amato, al quale l’amante vuole invece mostrarsi uomo di gran valore, come fanno i poveracci, supplici e incapaci di ricambiare, e per di più per nulla di nobile; non era un’azione da persona libera, e che si trattava di cosa per nulla confacente ad un uomo dabbene. [I,II,30] Ora, poiché Crizia non diede affatto retta a tali ammonimenti, né prese le distanze da Eutidemo, si racconta che Socrate, in presenza di molte altre persone e dello stesso Eutidemo, disse: “A me pare proprio che Crizia sia in preda ad una porcata, giacché smania in continuazione di strofinarsi contro Eutidemo, come fanno i maiali contro le pietre”. [I,II,31] Da quel momento Crizia prese ad odiare Socrate, al punto che quando egli, insieme con Caricle, divenne uno dei legiferatori dei Trenta, memore del suo rancore per Socrate, fece scrivere nelle leggi che ‘l’insegnamento dell’arte delle parole’ era da considerarsi a tutti gli effetti illegale. Questo fu il modo capzioso che Crizia scovò per ingiuriare Socrate, non avendo nei fatti alcun aggancio per metterlo con le spalle al muro, se non quello di imputargli una pratica costantemente attribuita a tutti i filosofi, e che lo calunniava davanti alla maggioranza dei cittadini. Io stesso, infatti, non ho mai sentito parlare così di Socrate; né mi sono mai accorto che qualcun altro abbia parlato di lui in questi termini. [I,II,32] Comunque , la cosa si riseppe. Infatti, mentre i Trenta continuavano a far uccidere molti dei cittadini, e non dei peggiori; ed istigavano molti altri a commettere delle ingiustizie, Socrate una volta disse: “A me sembra stupefacente che chi è diventato pastore di una mandria di buoi, e ne rende minore il numero dei capi e ne peggiora la qualità, non ammetta di essere un cattivo mandriano. Ma ancora più stupefacente a me sembra che chi è diventato capo di Stato e ne rende i cittadini minori di numero e peggiori di qualità, non si vergogni né creda di essere un cattivo capo di Stato”. [I,II,33] Quando ciò fu riferito a Crizia e a Caricle, i due convocarono Socrate, gli mostrarono il testo della legge e gli vietarono categoricamente di discutere con i giovani. Socrate chiese ad ambedue se gli fosse concesso di porre loro delle domande, nel caso non capisse qualcosa dei loro decreti. I due risposero affermativamente. [I,II,34] “Quanto a me”, disse allora Socrate, io sono prontissimo ad ubbidire alle leggi. Ed affinché io non faccia qualcosa di contrario alla legge, non per ignoranza bensì a mia insaputa, questo intendo sapere esplicitamente da voi: ‘l’arte delle parole’ dalla quale mi intimate di astenermi, voi ritenete che sia quella consistente di argomentazioni corrette, oppure quella consistente di argomentazioni scorrette? Se voi ritenete che si tratti di quella consistente di argomentazioni corrette, è evidente che io dovrei astenermi dall’argomentare correttamente. Se invece si tratta dell’arte consistente di argomentazioni scorrette, è evidente che io dovrei sforzarmi di argomentare correttamente”. [I,II,35] A questo punto Caricle, in un empito d’ira, gli disse: “Socrate, siccome tu sei un ignorantone, detto in un modo più comprensibile per te, il nostro decreto significa questo: tu non devi assolutamente più dialogare con i giovani”. Socrate gli rispose: “Affinché non ci siano ambiguità sulla mia stretta obbedienza a quanto è ordinato nel vostro decreto, definitemi esattamente fino a quale età la legge vuole che gli uomini siano dei giovani”. E Caricle chiarì: “Esattamente fino a quando non è concesso agli uomini far parte del Consiglio dei 500; giacché fino ad allora essi non sono capaci di intendere e di volere. Pertanto ti è vietato dialogare con persone che siano al di sotto dei trent’anni”. [I,II,36] “Neppure nel caso”, chiese Socrate, “che io stia comprando qualcosa? Oppure se uno più giovane di trent’anni mi sta vendendo qualcosa, non posso chiedergli a che prezzo me la vende?” “Per cose simili, sì che puoi”, rispose Caricle, “ma proprio tu, caro Socrate, sei solito fare la maggior parte delle tue domande sapendo già in anticipo quale sarà la risposta. Queste sono le domande che non devi fare”. “Dunque non devo rispondere”, chiese Socrate, “ad un giovane il quale mi chieda, ed io lo sappia, per esempio: ‘dove abita Caricle?’; oppure: ‘dov’è Crizia?’ ” “Per cose simili, sì che puoi”, rispose Caricle. [I,II,37] “Dunque, caro Socrate”, aggiunse Crizia, “ti toccherà astenerti dai tuoi calzolai, dai tuoi falegnami e dai tuoi fabbri ferrai, i quali secondo me ne hanno pure le scatole piene di essere diventati notori per opera tua”. “Astenermi quindi”, disse Socrate, “anche dal trattare gli argomenti ad essi legati: ossia alle questioni del giusto, del sacrosanto e così via?”. “Sì, per Zeus”, sottolineò Caricle, “e anche dai mandriani. Altrimenti, sta bene in guardia dal non fare tu pure diminuire il numero dei buoi”. [I,II,38] A questo punto divenne evidente che qualcuno aveva riferito ai due il discorsetto di Socrate sulla mandria di buoi, e che per questo motivo essi erano furibondi con lui. Della qualità dello stare insieme di Crizia con Socrate, e del modo in cui si trattavano l’un l’altro, s’è detto abbastanza.
[I,II,39] Io aggiungerei che nessuno riesce educato ad opera di un educatore che non gli sia gradito. A Crizia e ad Alcibiade, Socrate non era affatto gradito. Entrambi lo frequentarono tutto il tempo che lo frequentavano, ma fin dal principio il fine da cui i due erano mossi, era quello di diventare dei capi di Stato. E pertanto, quando erano insieme a Socrate, cercavano il modo di discutere con nessun altro, se non con coloro che maneggiavano faccende politiche. [I,II,40] Si racconta infatti che Alcibiade, ancor prima di avere raggiunto i vent’anni di età, quando Pericle era il suo tutore e il capo dello Stato, discutesse con lui delle leggi in questi termini. [I,II,41] “Dimmi, Pericle”, si narra che Alcibiade gli chiedesse, “avresti voglia di insegnarmi cosa sia una legge?” “Volentieri”, gli rispose Pericle. “Allora insegnamelo, in nome degli dei”, lo supplicò Alcibiade, “giacché quando io sento che alcuni uomini sono lodati per essere ligi alla legge, sarebbe giusto, io credo, che questa lode non toccasse a chi non sa cosa sia una legge”. [I,II,42] “Alcibiade”, gli rispose Pericle, “la spiegazione che cerchi sul cosa sia una legge, non è faccenda complicata da chiarire. Leggi sono tutte quelle deliberazioni scritte che la maggioranza dei cittadini, raccolta in assemblea, ha convalidato; specificando cosa bisogna fare e cosa bisogna non fare”. “E la decisione della maggioranza”, aggiunse Alcibiade, “è sempre quella di fare il bene oppure quella di fare il male?” “Per Zeus, giovanotto mio”, fu la risposta, “sempre il bene e mai il male”.
[I,II,43] “Ma se, come avviene negli Stati retti da una oligarchia, non è la maggioranza dei cittadini ma una minoranza riunita in assemblea, a scrivere cosa è d’uopo fare: queste deliberazioni cosa sono?” “Tutto ciò che”, fu la risposta di Pericle, “è stato deliberato e messo per iscritto su cosa sia d’uopo fare, da chi è a capo dello Stato: ebbene, si chiama ‘legge’”. “E dunque, se un tiranno, messosi a capo dello Stato, scrive quel che i cittadini debbono fare: anche queste deliberazioni sono delle leggi?” “Anche quanto scrive un tiranno che sia capo dello Stato”, rispose Pericle, “si chiama ‘legge’”. [I,II,44] “Cosa sono allora violenza e illegalità? Non sono forse”, sottolineò Alcibiade, “le azioni di chi, essendo più forte, costringe chi è più debole, non con la persuasione ma con la forza bruta, a fare qualunque cosa paia a lui?”. “Credo”, rispose Pericle, “che si tratti proprio di questo”. “E dunque illegale è tutto ciò che un tiranno fa mettere per iscritto e costringe i cittadini i fare, senza averli persuasi?” “A me sembra”, disse Pericle, “che sia proprio questo. Quindi rinnego quanto da me detto poco fa, cioè che sia legge ciò che un tiranno fa mettere per iscritto senza il consenso dei cittadini”. [I,II,45] “Quindi, tutto ciò che una minoranza, senza il consenso della maggioranza, fa mettere per iscritto con l’uso della forza bruta, lo chiameremo violenza oppure lo chiameremo non-violenza?” “A me sembra”, ribadì Pericle, “che tutto quanto, sia esso messo per iscritto o non per iscritto, uno costringe un altro a fare contro il suo consenso, non è una legge ma è piuttosto violenza”. “E ciò che la stragrande maggioranza dei cittadini, usando la forza bruta contro i possidenti facoltosi, fa mettere per iscritto contro il loro consenso, non sarebbe violenza piuttosto che legge?” [I,II,46] “Va bene così, Alcibiade”, disse Pericle, “alla tua età anche noi eravamo abilissimi in cose di questo genere. Infatti questi giochetti anche noi li facevamo per esercizio, e ci sofisticavamo sopra. Erano proprio tali e quali a quelli sui quali anche tu ora mi sembri esercitarti”. Ed Alcibiade gli rispose: “Pericle, oh! se io t’avessi incontrato a quel tempo, quand’eri al culmine della tua abilità in questi esercizi!” [I,II,47] Quindi, non appena concepirono di essere di un livello superiore a quello dei comuni governanti, Crizia e Alcibiade cessarono di frequentare Socrate. Peraltro, ad essi Socrate non riusciva affatto gradito; e, quando capitasse loro di trovarsi con lui, sempre si adontavano per le sue contestazioni dei loro errori. Si diedero perciò a praticare la politica, che è il motivo per cui si erano avvicinati a Socrate. [I,II,48] Invece Critone era un vero discepolo di Socrate, come lo erano Cherefonte, Cherecrate, Ermogene, Simmia, Cebete, Fedone ed altri ancora; i quali furono suoi sodali, non allo scopo di diventare capaci di discorsi parlamentari o forensi, ma affinché, una volta diventati uomini dabbene, diventassero capaci di trattare come si deve in casa, con i domestici, con i familiari, con gli amici, con lo Stato e con i cittadini. E nessuno di costoro, né da più giovane né da più vecchio, fece mai del male, né si attirò delle accuse.
[I,II,49] “Ma Socrate”, diceva l’accusatore, “insegnava a infangare la figura del padre. Intanto, persuadendo i suoi sodali che lui stava facendo di essi delle persone più sapienti dei loro padri; e poi affermando che era legale far incatenare chi era demente, fosse pure il proprio padre; prendendo a testimone di ciò la legalità del fatto che l’uomo più incolto fosse fatto incatenare da chi era più sapiente di lui”. [I,II,50] In realtà, l’opinione di Socrate era che chi fa incatenare qualcuno per incultura, secondo giustizia dovrebbe essere pure lui fatto mettere in catene da coloro che hanno le conoscenze che egli non ha. Su simili problemi, Socrate prendeva spesso in considerazione per cosa differisca la pazzia dall’incultura; e mentre riteneva che mettere in catene i pazzi fosse cosa utile sia per loro che per i loro amici; pensava invece che chi non aveva le dovute conoscenze, era giusto che le imparasse da chi quelle conoscenze le aveva. [I,II,51] “Ma Socrate”, insisteva l’accusatore, “rendeva disonorevoli agli occhi dei suoi sodali non soltanto i padri, ma anche gli altri congeneri; poiché sosteneva che i congeneri non sono di giovamento alcuno né ai sofferenti né a coloro che sono sotto processo, in quanto l’aiuto ai primi viene dai medici, ed ai secondi da coloro che sanno fare gli avvocati difensori. [I,II,52] A proposito degli amici”, aggiungeva poi l’accusatore, “Socrate sosteneva che la loro benevolenza non è di alcun pro, a meno che essi non siano capaci d’essere di qualche reale giovamento; e che i soli ad essere degni d’onore sono coloro che sanno cos’è che bisogna fare e sono capaci di spiegarlo a parole. Convincendo dunque i giovani di essere al vertice della sapienza e di essere il più capace di tutti a rendere sapienti gli altri, egli disponeva i suoi sodali in modo tale che, ai loro occhi, tutti gli altri nulla valevano a paragone di lui”. [I,II,53] Io, queste parole sui padri, sugli altri congeneri e sugli amici, ho visto Socrate pronunciarle. Ed oltre a queste parole, gli ho anche sentito dire che, una volta che l’animo sia uscito dal corpo, animo nel quale soltanto prende sede la saggezza, tutti costoro portano fuori casa e fanno sparire il più in fretta possibile il corpo del familiare, sia pur egli il più stretto. [I,II,54] Egli diceva anche, a proposito del corpo, che pur essendo esso, quando è in vita, ciò che più di tutto l’uomo ama, qualunque parte di esso che sia inutile o inservibile, è però l’uomo stesso a togliersela; oppure ad offrirla ad un altro perché gliela tolga. Sono gli uomini stessi a tagliarsi le unghie, i capelli e i calli; e ad offrire ai medici certe parti del corpo da mozzare e da cauterizzare pur tra dolori e sofferenze; ritenendo anzi che, per via di ciò, tocchi pagare ai medici anche un compenso. E sono ancora gli uomini stessi a sputare la loro saliva il più lontano possibile, giacché rimanendo essa nella bocca non è loro di alcun giovamento, ma anzi assai li danneggia. [I,II,55] Socrate, queste parole le pronunciava, non insegnando a sotterrare vivo un padre o a tagliare a pezzi se stessi; ma mettendo in tutta evidenza che ciò ch’è privo di mente è spregevole; e invitando quindi a dedicare ogni studio all’essere saggi e davvero giovevoli al massimo grado; affinché chi vuole essere tenuto in onore dal padre o dal fratello o da qualcun altro, ciò non trascuri, fidandosi del fatto di essere un familiare stretto, ma invece si sforzi di essere di reale giovamento a coloro dai quali vuole essere tenuto in onore.
[I,II,56] L’accusatore sosteneva poi che Socrate trasceglieva i peggiori versi dei più celebrati poeti, e che usando questi come testimonianze, insegnava ai suoi sodali come essere malfattori e tirannici. Il verso di Esiodo è questo:
‘Nessun lavoro è un’onta, l’inazione invece è un’onta’
e Socrate sosteneva che il poeta, con questo verso, intimava di non astenersi da qualunque genere di lavori, fossero essi ingiusti oppure indecenti, e di fare anche questi a motivo di guadagno. [I,II,57] In realtà, Socrate avrebbe giudicato del tutto ammissibile considerare cosa giovevole e buona per un uomo l’essere un lavoratore, ed invece l’essere ozioso una cosa dannosa e cattiva: dunque un bene il lavorare e un male l’oziare. Egli sosteneva quindi che quanti fanno qualcosa di buono, stanno lavorando e sono lavoratori; mentre coloro che giocano a dadi o fanno qualcos’altro di malvagio e di nocivo, egli li soprannominava ‘gli oziosi’. Tenuto conto di queste precisazioni, risulterebbe corretto il verso di prima:
‘Nessun lavoro è un’onta, l’inazione invece è un’onta’
[I,II,58] L’accusatore denunciava poi che spesso Socrate citava questo passaggio di Omero, nel quale si dice che Odisseo:
‘Ed ogni capo o scelto eroe che incontrava,
con parole serene lo tratteneva standogli accanto:
“Pazzo, non va che a te come a un vile io faccia paura.
Ma siedi, e fa’ che siedano gli altri soldati”.
Chiunque poi del volgo vedeva e trovava a urlare,
con lo scettro lo batteva, con parole sgridava:
“Pazzo, stattene fermo a sedere, ascolta il parere degli altri,
che sono più forti di te; tu sei vigliacco e impotente,
non conti nulla in guerra e nemmeno in Consiglio”
e che lo spiegava asserendo che così il poeta loderebbe le solenni bastonature di popolani e di poveracci. [I,II,59] Invece Socrate non intendeva affatto dire questo, altrimenti avrebbe creduto di dover essere lui stesso preso a bastonate. Egli intendeva piuttosto far notare che quanti non sono di alcun giovamento né a parole né a fatti, che sono incapaci di essere d’aiuto all’esercito, allo Stato ed al popolo stesso, qualora ve ne sia il bisogno; e che fanno i gradassi soprattutto contro il popolo: ebbene le azioni di costoro devono essere impedite in ogni modo, quand’anche si trattasse, caso mai, di persone ricchissime.
[I,II,60] Quanto a Socrate, egli era manifestamente tutto il contrario di simile gente, essendo egli uno favorevole al popolo e un filantropo. Egli, infatti, accettava di buon grado la compagnia di persone tanto della città quanto straniere, che fossero desiderose di frequentarlo; e non fece mai loro la richiesta di alcun pagamento per essere ammessi tra i suoi sodali, ma alle domande di tutti sovveniva in abbondanza con i suoi ripensamenti. Alcuni di questi sodali, si appropriavano poi gratuitamente di piccole parti di questi suoi ripensamenti, e li vendevano a gran prezzo ad altre persone, mostrando così di essere niente affatto dalla parte del popolo, visto che non volevano mai intavolare un discorso con chi non fosse fornito di denaro contante. [I,II,61] A confronto di altri uomini, Socrate dette anche un grandissimo lustro alla propria città; molto più di quanto fece il Lacedemone Lica, il quale si fece un gran nome per questo: ossia perché riceveva a cena gli ospiti stranieri che venivano a Sparta nel tempo in cui si celebravano le Gimnopedie. Socrate, invece, lungo il corso della sua intera vita, mettendo a disposizione di ognuno le grandissime doti che aveva, giovò a tutti quanti vollero servirsi di lui, giacché coloro con i quali si trovò insieme, sempre li congedava dopo averli resi migliori di prima. [I,II,62] Essendo dunque chi era, a me Socrate sembrava una persona degna di essere trattata della città con ogni onore, e non condannata a morte. E chi considerasse la sua vicenda da un punto di vista legale, troverebbe questo stesso risultato. Infatti, la pena di morte è la condanna che spetta a chi si sia manifestamente dimostrato un ladro, un rubavestiti, un tagliaborse, uno scassinatore, uno che riduce qualcuno in schiavitù, uno che si è macchiato di furti sacrileghi: tutti delitti dai quali Socrate si tenne lontano quant’altri uomini mai. [I,II,63] Invero, per la sua città egli non fu mai causa del sopravvenire di una guerra finita male, di una sedizione civile, né di episodi di tradimento, né di qualunque altra sorta di malefatta. In privato, non spogliò mai uomo alcuno dei suoi beni, né lo inviluppò in male alcuno; né fu mai denunciato per alcun episodio del genere. [I,II,64] Come poteva egli essere colpevole di quanto era scritto nell’atto di accusa? Egli, invece di non legittimare l’esistenza degli dei, come era stato scritto nella denuncia, era, al contrario, un manifesto cultore degli dei, più di quanto lo fossero tutti gli altri uomini. E invece di rovinare i giovani, visto che l’accusatore pure di ciò lo incolpava, egli si dava cura di far cessare le smanie malvage di quanti tra i suoi sodali di queste fossero preda, e li esortava invece a smaniare per quella nobilissima e grandiosissima virtù, grazie alla quale gli Stati e le famiglie prosperano. Così facendo, come poteva Socrate non essere meritevole di grandi onori da parte della sua città?
[I,III,1] Ora, siccome a me pare che Socrate giovasse ai suoi sodali, dimostrando, sia nei fatti che a parole, di cosa era capace; scriverò ora, su queste vicende, ciò di cui conservo memoria. Quanto al culto degli dei, era manifesto che egli operava e parlava al modo in cui la Pizia rispondeva a coloro che la interrogavano sul come comportarsi circa i riti sacrificali, sul culto degli antenati o su qualcos’altro del genere. E siccome il responso oracolare della Pizia è che quanti sono ligi alle leggi dello Stato sono al tempo stesso pii verso gli dei, Socrate così faceva lui stesso, e questo ammoniva gli altri a fare; mentre quanti facevano diversamente, egli la riteneva gente ossessionata dagli scrupoli. [I,III,2] L’auspicio che rivolgeva agli dei era semplicemente che essi gli concedessero dei beni, dato che gli dei sanno benissimo quali siano i beni. Coloro che invece auspicano per se stessi dell’oro o dell’argento o il potere assoluto o qualcos’altro del genere, egli riteneva che auspicassero per sé nulla di diverso dal buon esito di una posta al gioco dei dadi, o di una rissa o di qualcun’altra di quelle cose delle quali è manifestamente impossibile conoscere in anticipo come riescano. [I,III,3] Offrendo egli piccoli sacrifici che traeva dalle sue piccole sostanze, credeva però di non essere affatto da meno di coloro che offrivano molti e grandi sacrifici, traendoli dalle loro molte e grandi sostanze. Soleva anche dire che non si confaceva affatto agli dei il rallegrarsi più delle grandi offerte sacrificali che delle piccole, giacché così facendo sarebbero risultate loro gradite più le offerte dei malvagi che quelle degli uomini probi. Egli, quindi, riteneva che gli dei si rallegrino di più degli onori loro resi da quanti sono loro più devoti., e lodava questo verso:
‘Agli dei immortali offri sacrifici secondo le tue possibilità’
aggiungendo che nel trattamento degli amici, degli stranieri, e qualunque sia lo stile di vita, quel detto ‘offri secondo le tue possibilità’ era un bell’ammonimento. [I,III,4] Se qualcosa gli sembrava essere una segnalazione divina, piuttosto cha a disobbedire ai segnali degli dei, sarebbe stato più facile convincerlo a prendere quale guida un cieco che non conosce la strada, invece di qualcuno che ha un’ottima vista e che conosce la strada. Quanto agli altri, egli denunciava la stupidità di coloro che, per custodirsi immuni dal discredito presso gli uomini, fanno qualcosa che è contrario ai segnali degli dei. Quanto a lui, disdegnava tutte le opinioni umane, se paragonate al consiglio degli dei. [I,III,5] Il suo stile di vita comportava l’educazione sia dell’animo che del corpo; e seguendo tale stile di vita, a meno che non accada qualcosa di sovrumano, un uomo se la passerebbe sempre con fiducia, e nella piena sicurezza di non mancare mai della necessaria quantità di denaro da spendere. Era così frugale, poi, che io non so davvero se uno possa lavorare tanto poco da non ricevere per mercede almeno la somma che a Socrate bastava per vivere. Consumava la quantità di cibo strettamente necessaria a mangiare di gusto, ed era preparato a considerare già l’appetito quale il suo condimento. Qualunque bevanda gli era gradita, visto che egli non beveva se non aveva sete. [I,III,6] Se qualche volta gli veniva voglia di andare ad un pranzo al quale era stato invitato, gli riusciva facile il tenersi ben lontano da ciò che è invece gravosissimo da evitare per la maggioranza della gente, ossia il rimpinzarsi di cibo assai al di là della sazietà. A quanti erano incapaci di fare come lui, egli consigliava di tenersi ben lontani almeno dagli aperitivi, ossia da quei cibi che invogliano coloro che non hanno fame, a mangiare; e coloro che non hanno sete, a bere; poiché soleva dire che si tratta di bocconi che guastano lo stomaco, la testa e l’animo. [I,III,7] A scherno dei più, egli era solito dire di credere che Circe trasformi gli uomini in maiali, facendoli pranzare a base di una gran quantità di siffatti aperitivi; e che Odisseo non diventi un maiale sia per ciò che Ermes gli somministra, sia per la padronanza che egli ha di se stesso, astenendosi così dall’accostarsi a quegli aperitivi, ed a rimpinzarsene oltre la sazietà.
[I,III,8] Su tali argomenti, questo era ciò che egli soleva dire, un po’ scherzando e un po’ facendo sul serio. Quanto ai piaceri sessuali, egli esortava fortemente ad astenersi dai bei giovanotti, giacché non è facile che rimanga temperante chi si accosta a siffatti piaceri. Una volta, avendo saputo che Critobulo, il figlio di Critone, aveva baciato il figlio di Alcibiade, che era un bel giovanotto, Socrate chiese a Senofonte: [I,III,9] “Dimmi un po’, Senofonte, non ritenevi tu che Critobulo fosse una persona temperante piuttosto che sfrontata, e preveggente piuttosto che temeraria?” “Sì, cero che lo credevo” gli rispose Senofonte. “Da questo momento in poi, ritienilo una testa calda pronta a tutto; uno che farebbe i salti mortali dentro e fuori di un cerchio di spade o che salterebbe dentro il fuoco”. [I,III,10] “Ed è vedendolo fare cosa”, chiese Senofonte, “che lo hai riconosciuto capace di simili prodezze?” “Cosa ha fatto? Costui ha avuto l’ardire di baciare il figlio di Alcibiade, che è bellissimo di viso e nel fior degli anni”. “Ma se questa è temerarietà”, sorrise Senofonte, “mi ritengo anch’io pronto a correre un rischio simile!”. [I,III,11] “Oh te infelice!”, continuò Socrate, “Cosa credi di sperimentare, dopo avere baciato un bel ragazzo? Non è forse vero che all’istante sei diventato uno schiavo, mentre prima eri un uomo libero; uno che spende molto denaro per dei piaceri dannosi; uno che ha pochissimo tempo libero da dedicare al vivere da galantuomo, e che si dedica invece interamente a farsi costringere ad azioni alle quali non si dedicherebbe neppure se fosse pazzo?” [I,III,12] “Per Eracle”, disse Senofonte, “quanto è terribile la forza che tu attribuisci al bacio!” “E te ne stupisci?”, continuò Socrate, “Non sai che i falanghi, pur non arrivando neppure alla grandezza di un mezzo obolo, quando s’attacchino alla bocca, tribolano gli uomini con doglie strazianti che li mandano fuori di senno?” “Sì, per Zeus”, rispose Senofonte, “lo so; perché i falanghi iniettano qualcosa con il loro morso”. [I,III,13] “Ma stupidotto”, gli disse Socrate, “credi tu che baciando i bei ragazzi, costoro, soltanto perché tu non lo vedi, non iniettino in te qualcosa? Non sai che questa belva, chiamata un ‘bel ragazzo nel fior degli anni’, è di molto più terribile dei falanghi; in quanto questi iniettano qualcosa soltanto dopo essersi attaccati alla loro vittima; mentre il bel ragazzo non ha alcun bisogno di toccare la vittima, ma basta che uno lo veda perché egli da lontano inietti nella sua vittima qualcosa che la farà impazzire? [E forse è questo il motivo per cui gli ‘amorini’ sono chiamati arcieri, giacché è da lontano che i bei ragazzi feriscono] Perciò io ti consiglio, mio caro Senofonte, qualora tu veda un bel ragazzo, di fuggire a gambe levate; e a te, Critobulo, consiglio di passare un anno intero lontano da qui: e così, forse a stento, nel frattempo risanerai”. [I,III,14] Per quanto concerne i piaceri sessuali, Socrate pensava, dunque, che così dovessero comportarsi tutti coloro che non hanno di essi il sicuro dominio: ossia che l’animo non accetti i piaceri sessuali dei quali il corpo non ha assoluto bisogno, e che non creino impacci all’animo quelli dei quali il corpo ha invece assoluto bisogno. Quanto a se stesso, poi, egli era, a questo riguardo, chiaramente così preparato, che dai bei ragazzi nel fior degli anni si asteneva più facilmente di quanto gli altri si astenessero dai ragazzi laidissimi e stagionatissimi. [I,III,15] Quanto al cibo, al bere e ai piaceri sessuali, così egli disponeva per sé; e giudicava di sentirsi appagato a sufficienza, certamente non meno di quanti si davano un gran da fare per essi, ed anzi di andare incontro ad angustie molte meno volte di loro.
[I,IV,1] Se vi sono persone le quali ritengono che Socrate era diventato, sì, abilissimo nell’esortare gli uomini alla virtù, e però incapace di prenderli e condurli fino ad essa, come taluni scrivono e raccontano quando il discorso cade su di lui: ebbene, che costoro analizzino non soltanto le affermazioni che egli, a mortificazione di coloro che credono di sapere tutto, confutava ponendo loro delle domande; ma anche ciò che egli diceva quando passava l’intera giornata in compagnia; e soltanto dopo, queste persone valutino la capacità di Socrate di rendere migliori i suoi sodali. [I,IV,2] Parlerò in primo luogo delle cose che una volta ho sentito dire da lui a proposito del suo démone, mentre dialogava con Aristodemo, quello soprannominato ‘il piccolo’. Avendo appreso che costui non offriva sacrifici agli dei, non rivolgeva loro preghiere, non usava la mantica, e che derideva pure quanti praticavano simili attività, Socrate gli chiese: “Dimmi un po’, Aristodemo, esistono degli uomini che tu hai ammirato per la loro sapienza?” “Certamente esistono” rispose Aristodemo. [I,IV,3] E Socrate aggiunse: “Dimmi i loro nomi”. “Dunque, quanto alla poesia epica, colui che io ho ammirato di più è Omero; quanto alla ditirambica è Melanippide, quanto alla tragedia è Sofocle, quanto alla scultura è Policleto e quanto alla pittura è Zeusi”. [I,IV,4] “E a te sembrano più degni di meraviglia i facitori di simulacri privi di mente e di moto, oppure i facitori di esseri viventi dotati di mente e capaci di varie attività?” “Per Zeus, di sicuro i facitori di esseri viventi, se codesti nascono non per qualche caso fortuito, ma ad opera di un facitore intelligente”. “Ora, delle cose di cui è impossibile congetturare lo scopo, e di quelle che sono manifestamenti fatte in vista di un qualche giovamento: quali delle due giudichi originate dalla sorte, e quali originate dall’intelligenza?” “Si confà che opera dell’intelligenza siano quelle nate per giovare”. [I,IV,5] “Non ti pare, dunque, che il facitore degli uomini li abbia fin da principio dotati di sensi, grazie ai quali percepire ciascuna delle cose che li circondano: gli occhi per vedere le cose visibili e le orecchie per sentire i suoni? E gli odori sarebbero per noi di qualche pro, se noi non fossimo stati dotati, in aggiunta, delle narici? E quale sensazione avremmo noi del dolce, dell’aspro, del piacevole, se non fosse stata fatta la lingua, che attraverso la bocca le discerne una dall’altra? [I,IV,6] Oltre a queste, non pare anche a te che somiglino ad opere della prònoia anche altre cose che dirò adesso? Poiché quello della vista è un organo debole, l’occhio è stato dotato di porte, quelle che usiamo chiamare palpebre; sicché quando c’è bisogno di utilizzare la vista, le palpebre si spalancano, e invece quando dormiamo esse collabiscono e spengono la vista. Affinché poi i venti non li danneggino, la natura ha dato agli occhi, a mo’ di filtro, le ciglia; e al di sopra degli occhi, a mo’ di gronda, sporgono le sopracciglia, affinché neppure il sudore che scende dal capo sia loro di nocumento. L’organo dell’udito accoglie tutti i suoni, senza però esserne mai troppo ripieno. I denti incisivi di tutti gli animali sono adatti a tagliare il cibo, mentre quelli molari sono fatti per ricevere il cibo da quelli e per macinarlo. La bocca, grazie alla quale gli animali ingeriscono i cibi che appetiscono, è posta vicino agli occhi e alle narici. Poiché gli escrementi sono di odore sgradevole, lo sbocco del loro canale è volto verso la parte posteriore del corpo, ed è posto il più lontano possibile dagli organi di senso. Pertanto, di tutte questa cose così pronoeticamente effettuate, tu dubiti se esse siano opere del caso oppure dell’intelligenza?” [I,IV,7] “No, per Zeus”, rispose Aristodemo, “a chi analizza a fondo la faccenda, queste opere appaiono come il capolavoro di un demiurgo sapiente ed amante degli animali”. “E l’ingenerare negli animali la pulsione alla generazione dei figli, nelle madri la pulsione ad allevarli, e nei figli allevati la grandissima bramosia di vivere, e la grandissima paura della morte?” “Senza dubbio, anche queste cose appaiono opere di qualcuno che ha deliberato che esistessero gli animali”. [I,IV,8] “Secondo te, ritieni di avere in te qualcosa che è dotato di raziocinio?” “Interrogami, e io ti risponderò”. “Credi tu che al di fuori di te, da nessun’altra parte esista qualcosa dotato di raziocinio? Tu sai di avere nel tuo corpo una piccola quantità di terra, terra che di suo è tantissima; una esigua quantità di acqua, che è molta anch’essa; e una certa quantità degli altri elementi, che sono in quantità enorme; e che ad opera di chi ha preso di ciascuno una piccola parte, è stato messo insieme armoniosamente il tuo corpo? Dunque la mente, che da sola non sta da nessuna parte, donde credi tu di averla fortunosamente ghermita? E queste cose che sono in quantità stragrande e di una moltitudine illimitata, credi tu che si dispongano ordinatamente grazie ad una qualche forma di assenza di raziocinio?” [I,IV,9] “Sì, per Zeus; giacché non ne vedo gli artefici, come invece vedo gli artigiani artefici delle opere d’arte che qui da noi si producono”. “Infatti, neppure vedi l’animo tuo, che è il signore del corpo. Eppure è grazie all’animo che hai la potestà di dire che tutto ciò che fai, lo fai non per intelligenza ma per caso”. [I,IV,10] “Socrate, io non disdegno il démone”, esclamò Aristodemo, “ma lo ritengo qualcosa di troppo grandioso perché esso abbia bisogno del mio culto”. “Dunque, quanto più grandioso è il démone che si degna di prendersi cura di te”, gli rispose Socrate, “tanto maggiore è il dovere che hai di rendergli onore”. [I,IV,11] “Socrate, tu lo sai bene. Se io ritenessi”, continuò Aristodemo, “che gli dei si preoccupano di qualche faccenda che riguarda gli uomini, ebbene io non ne trascurerei il culto”. “E perché ritieni che gli dei non si preoccupino degli uomini? Gli dei, infatti, in primo luogo hanno fatto dell’uomo, unico tra gli animali, un essere capace di stare in posizione eretta; e questa posizione eretta fa sì che egli possa vedere più lontano, guardare meglio le cose che gli stanno al di sopra, e in tal modo subire da loro meno danni. In secondo luogo, mentre agli altri animali, che prima strisciavano soltanto, gli dei diedero i piedi, piedi che concedono loro soltanto la possibilità di camminare; all’uomo diedero invece anche le mani; mani con le quali noi operiamo la maggior parte delle azioni, e grazie alle quali siamo molto più felici di quelli. [I,IV,12] Quanto alla lingua, benché tutti gli animali ne abbiano una, gli dei fecero sì che soltanto la lingua dell’uomo fosse capace di entrare in contatto, ora qui e ora là, con parti diverse della bocca; di articolare così la voce, e quindi di segnalare qualunque cosa tra di noi si voglia. Inoltre, quanto ai piaceri sessuali, gli dei li hanno concessi agli altri animali limitandoli unicamente ad un certo periodo dell’anno; mentre a noi li hanno concessi in godimento continuo, fino alla vecchiaia”. [I,IV,13] Eppure non bastò alla divinità il prendersi cura del corpo dell’uomo; ma, cosa ancor più grandiosa, essa ingenerò in lui un animo di somma eccellenza. Infatti, in primo luogo, l’animo di quale altro animale si accorge dell’esistenza di divinità che hanno disposto in ordine perfetto i grandissimi e splendidi corpi celesti? Quale altra schiatta, se non quella degli uomini, rende culto agli dei? Quale specie di animo è più capace di quello umano di premunirsi in anticipo contro la fame, la sete, il freddo, il caldo; di curare le malattie, di tenere allenata la forza fisica, di faticare per apprendere; e più capace di tenere a mente quanto ha sentito o visto o imparato? [I,IV,14] Non ti è evidente a sufficienza che, a differenza degli altri animali, gli uomini passano la vita come degli dei, essendo per natura superiori agli animali sia di corpo che d’animo? Neppure se avesse il corpo di un bue e l’intelligenza di un uomo, egli potrebbe fare ciò che vuole. Né gli animali che hanno le mani ma sono privi di raziocinio, hanno alcun vantaggio sugli altri. Tu che invece hai ottenuto in sorte entrambe queste due pregevolissime cose, credi che gli dei non si prendano cura di te? Cosa dovranno essi fare, così che tu li creda preoccuparsi di te?” [I,IV,15] “Quando invieranno, come tu affermi che essi inviano, dei consiglieri circa le cose che bisogna fare e non fare”. “Ma quando gli dei”, disse allora Socrate, “rispondono attraverso la mantica agli Ateniesi che cercano di sapere qualcosa da loro, non ti pare che gli dei stiano rispondendo anche a te? E quando gli dei mandano ai Greci, o anche a tutti gli uomini, dei portenti a segnalazione di qualcosa, li dispongono forse con trascuratezza, escludendone unicamente te solo? [I,IV,16] Credi tu che essi abbiano ingenerato negli uomini l’opinione che gli dei possono fare del bene e del male, se di ciò non fossero davvero capaci; e che su questo gli uomini si siano ingannati tutto il tempo, non essendosene mai accorti? Non vedi tu che le più durature e sapienti istituzioni umane, ossia gli Stati e le Nazioni, sono anche le più timorate degli dei, e che le età più ricche di saggezza sono anche le più diligenti nel culto degli dei? [I,IV,17] Mio caro Aristodemo, sappi anche che la mente, finché è in te, manipola il tuo corpo come vuole. Bisogna pertanto credere che il raziocinio inerente all’universo dispone tutte le cose nel modo che più gli aggrada; che se la tua vista non può andare oltre un certo numero di stadi, l’occhio della divinità può invece cogliere la totalità con un solo sguardo; e che se il tuo animo può darsi pensiero delle cose di qui, di quelle in Egitto e di quelle in Sicilia, il raziocinio della divinità è capace di prendersi cura di tutte quante esse. [I,IV,18] Se dunque, è essendo premuroso con gli uomini, che tu riconoscerai quali di essi intendano contraccambiarti con altrettante premure; che è facendo dei favori che riconoscerai chi intende contraccambiati con altrettanti favori; e che è consigliandoti con gli uomini che imparerai quali di essi sono saggi; allo stesso modo metterai alla prova gli dei rendendo loro il culto dovuto, e se essi vorranno darti consigli circa faccende il cui esito è del tutto dubbio agli uomini, riconoscerai finalmente che la divinità è così grande e così fatta che tutto vede, tutto ode, dappertutto è presente, e di tutte le cose si prende cura”. [I,IV,19] Dicendo queste parole, a me sembra che Socrate facesse in modo che i suoi sodali si astenessero da ogni empietà, da ogni ingiustizia e da ogni viltà, non soltanto quando erano visti dagli uomini ma anche quand’erano soli, proprio perché, qualunque cosa facessero, erano convinti di non poter sfuggire alla vista degli dei.
[I,V,1] Se poi la temperanza è per l’uomo un possesso virtuoso, analizziamo se è dicendo parole come le seguenti, che Socrate soleva far avanzare i suoi sodali verso tale virtù: “Signori, nel caso ci sopravvenisse una guerra e decidessimo di eleggere un uomo grazie al cui comando uscire noi salvi e sottomettere i nemici; sceglieremmo forse qualcuno che ci accorgiamo essere schiavo del ventre, o del vino, o dei piaceri sessuali, o del sonno? Come ritenere che un individuo di tal fatta, farà noi salvi e ridurrà alla nostra mercé i nemici? [I,V,2] Se noi, ormai in fin di vita, decidessimo di affidare a qualcuno l’educazione dei figli maschi, o la custodia delle figlie femmine non sposate, o la salvaguardia del nostro denaro, riterremmo a questo scopo degno di fiducia, chi non è padrone di sé? Affideremmo noi il nostro bestiame, i magazzini, la soprintendenza dei lavori necessari, ad uno schiavo che non ha padronanza di sé? Vorremmo noi prendere gratis quale servo incaricato degli acquisti, uno schiavo di tal fatta? [I,V,3] Ordunque, se noi non accoglieremmo in casa nessuno, neppure uno schiavo, che mancasse di temperanza; come può non essere cosa di gran pregio che il padrone di casa stia bene in guardia dal diventare egli stesso un intemperante? All’intemperante, inoltre, non accade quel che accade all’avaro. Infatti, come l’avaro, sottraendo i denari ad altrui pensa di arricchire se stesso; così pure l’intemperante, mentre è dannoso agli altri, crede di giovare a se stesso. Invece chi non è padrone di sé, mentre fa del male agli altri, fa molto più male a se stesso; e fare malissimo non è soltanto il rovinare la propria casa, ma anche il rovinare il proprio corpo e il proprio animo. [I,V,4] Chi godrebbe della compagnia di un intemperante, che tutti vedrebbero indulgere alle pietanze e al vino più che intrattenersi piacevolmente con gli amici, ed aver care le puttane più dei compagni di banchetto? Non è forse d’uopo che l’uomo il quale ritiene che la padronanza di sé sia il fondamento della virtù, in ogni occasione e in primo luogo la strutturi saldamente come tale nell’animo suo? [I,V,5] Chi è privo di temperanza, come potrebbe imparare qualcosa di buono, o metterlo in pratica in un modo degno di considerazione? Chi non sarebbe maldisposto sia di corpo che d’animo, se è schiavo dei piaceri? Sì, per Era; a me sembra del tutto auspicabile che un uomo libero non si imbatta mai in uno schiavo di tal fatta; e che chi è schiavo di siffatti piaceri supplichi gli dei di farlo imbattere in buoni padroni, giacché soltanto così egli potrebbe condursi a salvamento. [I,V,6] Questo era ciò che Socrate diceva. Ma egli si dimostrò padrone di sé ancor più nelle opere che a parole. Egli, infatti, aveva piena padronanza di sé non soltanto riguardo ai piaceri corporali, ma anche riguardo al denaro; poiché riteneva che chi prende denaro a prestito in quantità abnorme, istituisce per se stesso un padrone e si fa schiavo di una schiavitù tale che non ne esiste una più vergognosa.
[I,VI,1] Vale la pena di non lasciare da parte anche il discorso che Socrate ebbe con Antifonte il sofista. Infatti Antifonte, volendo far suoi i discepoli di Socrate, direttosi verso di lui ed in presenza di quelli, parlò così: [I,VI,2] “Socrate, io usavo credere che i filosofi praticanti dovessero diventare persone felicissime. A me pare che tu, invece di vantaggi, abbia ritratto dalla filosofia tutto il contrario. Infatti, tu stai vivendo in un modo tale, che neppure uno solo degli schiavi che campano sotto un padrone, potrebbe reggere. Mangi cibi e bevi bevande vilissime; ti cingi d’una mantellina non solo vile ma che è sempre la stessa d’estate e d’inverno; e passi la vita scalzo e senza una tunica. [I,VI,3] Non accetti denaro, il quale invece è cosa che mette di buonumore chi lo riceve, e permette a chi lo possiede di vivere in modo più libero da affanni e più piacevole. Se pertanto, come accade nel caso delle altre opere, gli insegnanti sono la dimostrazione vivente del fatto che gli allievi diventano loro imitatori, e che quindi tali anche tu finirai per rendere i tuoi sodali; credi pure di essere l’insegnante dell’infelicità”. [I,VI,4] Al che Socrate replicò: “Antifonte, mi sembra che tu ti sia fatta l’idea che io vivo una vita sommamente miserevole, onde mi sono convinto che tu sceglieresti di morire piuttosto di vivere come vivo io. Ordunque, analizziamo in dettaglio cos’è della mia vita che tu hai avvertito come insopportabile. [I,VI,5] È forse il fatto che quanti accettano del denaro, necessariamente devono poi applicarsi al lavoro per il quale vengono pagati; mentre io, non facendomi pagare, non ho alcun obbligo di discutere con chi non voglio discutere? È perché ritieni vilissimo il mio vitto, e che io mangi, per un verso, cose assai meno salubri delle tue o, per un altro verso, cose che forniscono assai meno vigoria? I componenti della mia dieta sono forse molto più difficili a procurarsi di quelli della tua, e sono forse assai più rari e assai più costosi? È forse perché i pasti che tu ti prepari, hanno un sapore più piacevole di quelli che mi preparo io? Non sai che più piacevole uno trova il cibo che mangia, di meno pietanze ha bisogno? E che più piacevole uno trova quel che beve, minore è smania che ha per le bevande che non sono sulla tavola? [I,VI,6] Quanto alle mantelline, tu sai che quanti se le cambiano, lo fanno a motivo del freddo e del caldo; e che quanti calzano le scarpe lo fanno per non essere impediti nel camminare da ciò che può arrecare danno ai piedi. Ordunque, hai tu mai sentito dire che io sia rimasto chiuso in casa a motivo del freddo; oppure che a motivo del caldo io abbia litigato per dell’ombra; oppure che a motivo di qualche dolore ai piedi io non abbia camminato fin dove volevo? [I,VI,7] Non sai che quanti sono di corpo debolissimo, a forza di esercizi nelle attività nelle quali si esercitano, diventano più gagliardi di coloro che, pur robusti per natura, trascurano di esercitarsi; e che sopportano la fatica più facilmente di loro? Tu non credi che io, esercitando continuamente il mio corpo, sia in grado di reggere le fatiche che capitano, e di sopportarle più facilmente di te che non ti ci eserciti? [I,VI,8] Quanto al non essere schiavo del ventre, del sonno e della lascivia, credi tu che esista altra causa maggiore del semplice fatto di avere io a disposizione cose ben più piacevoli di quelle; e cose le quali, in caso di necessità, non solo mi rallegrano, ma mi danno anche la speranza di essermi sempre di giovamento? Invero, tu sai sicuramente che quanti credono di non stare riuscendo bene in ciò che fanno, non sono affatto lieti; mentre quanti ritengono che gli affari procedono per loro benissimo, si tratti di agricoltura o di commercio marittimo o di qualunque altra attività alla quale si applichino, sono lieti, poiché tutto sta loro andando per il verso giusto. [I,VI,9] E credi tu che in tutte queste attività sia contenuto tanto piacere quanto quello che è contenuto nel ritenere di diventare giorno dopo giorno un uomo migliore, e di procurarsi amici sempre più eccellenti? Invero, io continuo a credere che sia così. E quando si debba sovvenire agli amici o alla patria, chi dei due avrà più agio di prendersi cura di ciò: chi conduce una vita come la mia attuale, o chi ha il regime di vita che tu definisci beato? Chi dei due parteciperà più facilmente ad una campagna militare: chi è incapace di vivere se non ha a disposizione dei cibi costosi, oppure colui a cui basta quel che c’è? E chi dei due si arrenderebbe più rapidamente nel caso di un assedio: chi abbisogna di cose difficilissime a trovarsi, oppure colui cui basta servirsi di cose in cui è facilissimo imbattersi? [I,VI,10] Antifonte, tu somigli a chi crede che la felicità sia lusso e sperpero. Io invece ritengo che il non mancare di alcunché sia cosa divina, e che il mancare del minor numero possibile di cose sia lo stato più vicino che esiste al divino. Ora, la divinità è suprema potenza: dunque, ciò che è vicinissimo al divino, è anche ciò che è vicinissimo alla suprema potenza”.
[I,VI,11] In un’altra occasione, discutendo con Socrate, Antifonte disse: “Socrate, io ti ritengo senz’altro una persona giusta, ma in nessun modo una persona sapiente. A me sembra che tu stesso lo riconosca: infatti tu non ti fai pagare in denaro per la tua conversazione; e tuttavia la tua mantellina o la tua casa o qualcos’altro di ciò che possiedi e che ritieni avere un valore in denaro, a nessuno lo cederesti gratis, né ad un prezzo minore del suo valore di mercato. [I,VI,12] È dunque evidente che se tu credessi la tua conversazione avere un qualche valore in denaro, anche questa venderesti ad un prezzo non di certo inferiore al suo valore. Pertanto, se pur tu fossi un uomo giusto, giacché non inganni alcuno per avidità di guadagno, sapiente però non lo saresti, poiché la tua sapienza non ha alcun valore di mercato”. [I,VI,13] A questo, Socrate rispose: “Antifonte, dalle nostre parti esiste un modo nobile ed un modo vergognoso di disporre della giovanile bellezza e della sapienza. Qui da noi soprannominano ‘prostituto’ colui che vende per denaro il fior degli anni suoi a chi lo vuole; mentre noi riteniamo invece pienamente padrone di sé, chi si fa quale amante una persona che egli sappia essere un galantuomo. Accade la stessa cosa nel caso della sapienza; e pertanto, come soprannominano quegli altri ‘prostituti’, qui da noi soprannominano ‘sofisti’ coloro che vendono per denaro la sapienza a chi la vuole. Invece chiunque si faccia quale buon amico, chi egli sa essere di ottima natura e che gli insegna tutte le cose buone che può, noi pensiamo che assolva ai doveri di cittadino e di galantuomo. [I,VI,14] E io stesso, caro Antifonte, come altri godono chi per il possesso di un buon cavallo, chi di un cane e chi di un uccello; così io pure ancor di più godo della familiarità che ho con i miei buoni amici. E se so qualcosa di buono, ne metto anche loro al corrente; e li raccomando ad altri, qualora io ritenga che essi possano da loro trarre qualche giovamento nel cammino verso la virtù. E i tesori che i saggi del passato ci hanno lasciato nei libri scritti da loro, noi li apriamo insieme e tra amici insieme li scorriamo; e se vediamo in essi qualcosa di buono, lo mettiamo da parte, ritenendo un gran guadagno il diventare giovevoli gli uni agli altri”. Udendo queste parole, a me sembrava che Socrate fosse un uomo beato e che guidasse i suoi ascoltatori a diventare dei veri galantuomini.
[I,VI,15] In una occasione diversa, Antifonte gli chiese come mai ritenesse di fare degli altri dei periti di politica, senza mai prendere lui stesso parte diretta alla politica. Al che Socrate rispose: “Antifonte, qual è il modo migliore in cui potrei occuparmi di politica? Forse quello di prendervi parte io singolarmente, oppure quello di darmi ogni cura affinché quante più persone possibile siano all’altezza di prendervi parte?”
[I,VII,1] Analizziamo ora attentamente se sia vero che allontanando i suoi sodali dalla millanteria, egli con ciò stesso li spronava a curarsi attivamente della virtù. Socrate soleva infatti dire che verso la buona fama non esiste strada migliore di quella che fa davvero di un individuo il galantuomo che egli vuole sembrare. [I,VII,2] Che stesse dicendo la verità, Socrate lo insegnava in questo modo. “Consideriamo il caso”, diceva, “di qualcuno che non è un buon flautista e che però vuole sembrarlo. Cosa dovrebbe egli fare? Quanto alle apparenze esteriori dell’arte, non gli tocca forse imitare i buoni flautisti? Pertanto, visto che costoro sono dotati di ottimi strumenti e che vanno in giro accompagnati da molti seguaci, egli deve in primo luogo fare le cose che fa il buon flautista. In secondo luogo, poiché sono molte le persone che li applaudono, anch’egli deve dotarsi di una vasta platea di gente che lo applaude. E tuttavia non dovrà mai e in nessun caso accettare la richiesta di suonare il flauto, giacché andrebbe incontro ad una immediata contestazione, in quanto individuo ridicolo che non è soltanto un pessimo flautista ma che è anche un millantatore. E così, dopo avere speso molto denaro senza ricavarne vantaggio alcuno e, per di più, essendosi guadagnato una pessima fama; come potrà egli vivere se non penosamente, in modo controproducente e sommerso dal ridicolo? [I,VII,3] Non altrimenti avviene, qualora uno voglia mostrarsi, pur non essendolo, un buon generale o un buon pilota di nave. Consideriamo dunque quel che gli accadrebbe. Se egli, smanioso com’è di sembrare all’altezza di simili compiti, non riuscisse a persuadere gli altri, ciò non diventerebbe per lui un motivo di afflizione? E se, nel caso vi riuscisse, qualcosa di ancor più meschino? È infatti manifesto che, una volta posto al comando di una nave, o a capo di una spedizione militare, chi non sa comandarli come si deve, manderebbe in completa rovina coloro che meno vorrebbe rovinare, e lui stesso se la caverebbe malissimo e si troverebbe sommerso dalla vergogna”. [I,VII,4] Ragionando allo stesso modo, Socrate rendeva evidente che era del tutto controproducente voler apparire ricco, virile e potente, senza esserlo. Soleva, infatti, dire a costoro, che a quanti si impegnano in imprese che sono al di là dei loro limiti, e che credono di poter effettuare azioni delle quali non sono capaci, non è concesso alcun perdono. [I,VII,5] E soleva anche chiamare truffatore non chi sottraesse un po’ di denaro o qualche suppellettile per via di persuasione, ma infinitamente più truffatore chiunque, essendo uomo di nessun valore, avesse ingannato i suoi concittadini, inducendoli a ritenerlo capace di governare lo Stato. A me pare pertanto che Socrate, discutendo di questi argomenti, allontanasse i suoi sodali da ogni forma di millanteria.
Libro II
Introduzione
Quelli che la tradizione ha raccolto sotto il generico nome di ‘Memorabilia’, ovvero di ‘Detti e fatti memorabili’, sono appunti disparati che Senofonte scrisse in tempi diversi e senza un ordine preciso. L’unico elemento che appare tenerli uniti è la presenza costante del personaggio ‘Socrate’, come visto ed interpretato da Senofonte.
Per comodità, io ho raccolto ciascun appunto in altrettanti paragrafi. Gli appunti che formano il Libro II sono in totale 11, e l’argomento di ciascuno di essi è il seguente.
Appunto 1 – [II,IA,1-20] Socrate ed Aristippo discutono sull’educazione da impartire ai destinati a comandare e ai destinati ad ubbidire; e se vivrebbero più piacevolmente i primi o i secondi.
Appunto 2 – [II,IB,21-34] La scelta di Eracle tra la virtù e il vizio, ossia la celebre ‘Favola di Prodico’.
Appunto 3 – [II,II,1-14] Socrate rimprovera suo figlio Lamprocle, per l’ingratitudine che mostra verso la propria madre.
Appunto 4 – [II,III,1-19] Cherecrate, fratello minore di Cherefonte, e gravemente in lite con lui, viene istruito da Socrate su quale sia il modo migliore per rappacificarsi col fratello maggiore.
Appunto 5 – [II,IV,1-7] Socrate discorre sul tema dell’amicizia e sulla ben maggiore utilità di un amico sincero e dabbene, rispetto a quella di uno schiavo domestico.
Appunto 6 – [II,V,1-5] Gli uomini liberi e gli schiavi si vendono a prezzi differenti. Accade lo stesso per gli amici? Hanno anche questi valori diversi? Ne discutono Socrate e Antistene.
Appunto 7 – [II,VI,1-39] Socrate e Critobulo discutono su che uomo sia colui del quale vale la pena di ricercare l’amicizia.
Appunto 8 – [II,VII,1-14] Socrate suggerisce ad Aristarco quale sia il modo in cui lui e la sua numerosissima famiglia, possano uscire dall’indigenza nella quale sono stati lasciati della guerra appena conclusa.
Appunto 9 – [II,VIII,1-6] Finita la guerra, Eutero è costretto a lavorare manualmente per sopravvivere; e Socrate, suo antico compagno, gli spiega quale tipo di lavoro ritenga essere per lui più adatto.
Appunto 10 – [II,IX,1-8] Su suggerimento di Socrate, l’amico Critone trova in Archedemo un ottimo avvocato, che sa come difenderlo dalla massa di ingiustificate querele che gli piovono addosso.
Appunto 11 – [II,X,1-6] Socrate suggerisce a Diodoro di assumere quale amministratore Ermogene: un uomo di provata probità, che versa nell’indigenza a causa della guerra in corso.
Traduzione
[II,IA,1] Facendo discorsi del genere, a me pareva che Socrate spronasse i suoi sodali ad esercitare la piena padronanza di sé in fatto di cibi, di bevande, di lascivia, di sonno, di freddo, di caldo, di fatica. Ed essendo egli al corrente che uno dei suoi sodali praticava una sfrenata intemperanza verso tali cose, Socrate gli disse: “Senti un po’, Aristippo. Se tu prendessi con te due giovanetti e dovessi educarli: uno affinché diventi un capace comandante, e invece l’altro affinché non pretenda mai di comandare; in quale modo educheresti sia l’uno che l’altro? Sei d’accordo a cominciare con me questa indagine, partendo dalla questione elementare del vitto?” A ciò Aristippo rispose: “Mi sembra che quella del vitto sia la questione fondamentale, giacché chi non si alimenta neppure potrebbe vivere”. [II,I,2] “Ebbene, quando giungerà l’ora appropriata, è ben verosimile che la voglia di prendere del cibo si presenti ad entrambi, non ti pare?” “Sì, è senz’altro verosimile che sia così”. “Dunque, quale dei due giovanetti abitueremo a scegliere di sbrigare innanzitutto le faccende della massima urgenza, prima di gratificare il ventre?” “Sì, per Zeus”, rispose Aristippo, “educheremo prima il giovanetto destinato a comandare, affinché sotto il suo comando non rimangano inevase le pratiche riguardanti lo Stato”. “Dunque”, disse Socrate, “anche quando entrambi vorranno bere, nell’educazione del medesimo giovanetto dovremo aggiungere anche la capacità di sopportare la sete?” “Assolutamente sì”, confermò Aristippo, “è così”. [II,I,3] “E la piena padronanza di sé circa il sonno; così da essere capace di coricarsi tardi, alzarsi di buon mattino, e di stare sveglio quando ce ne sia il bisogno: all’educazione di quale dei due giovanetti la aggiungeremmo?” “Anche questo all’educazione del medesimo giovanetto”. “E circa l’essere temperante in fatto di piaceri sessuali”, chiese Socrate, “affinché egli non si trovi impedito ad effettuare qualcosa quando ce ne sia urgente bisogno?” “Pure questo all’educazione del medesimo giovanetto”. “E circa il non rifuggire le fatiche, ma anzi il sopportarle di buon grado: all’educazione di quale dei due giovanetti la aggiungeremmo?” “Anche questo”, disse Aristippo, “all’educazione del giovanetto destinato a comandare”. “E l’apprendere se vi siano delle nozioni idonee a sconfiggere e dominare gli avversari, all’educazione di quale dei due giovanetti converrebbe di più aggiungerlo?” “Sì, per Zeus”, esclamò Aristippo, “senza dubbio all’educazione di quello destinato a comandare; giacché tutto il resto non è di alcun pro, se manca l’apprendimento di siffatte nozioni”. [II,I,4] “Dunque”, disse Socrate, “chi è stato educato in questo modo, pare anche a te che verrebbe catturato dagli avversari molte meno volte di quanto lo sarebbero i restanti animali? Invero alcuni animali, pur in certi casi timidissimi, una volta adescati con del cibo e condotti alle esche dalla loro brama di mangiare, qui sono catturati; mentre altri animali soccombono ad agguati per la loro brama di abbeverarsi”. “Sì, è assolutamente così”, rispose Aristippo. “Ebbene anche altri animali: per esempio, le quaglie e le pernici; quando siano portati dalla lascivia verso il grido di richiamo della femmina per la smania e la speranza di piaceri sessuali, una volta buttata per aria ogni valutazione dei terribili pericoli che corrono, non cadono forse nelle reti dei cacciatori?” [II,I,5] “Sì, è così”, assenti Aristippo. “Dunque, non ti pare che sia vergognoso per un uomo il provare le stesse passioni che sperimentano delle bestie del tutto prive di raziocinio? Così gli adulteri entrano nelle stanze che nella casa sono riservate alle donne, pur sapendo che un adultero corre il pericolo di incappare nelle pene che la legge minaccia, di cadere in un tranello, di essere colto in flagrante e di subire ogni sorta di oltraggi; pur sapendo che sulla testa dell’adultero incombono ogni sorta di mali ignominiosi; pur sapendo dell’esistenza di molti rimedi capaci di scioglierlo in tutta sicurezza dalla smania che ha in corpo di godere il piacere sessuale. E purtuttavia egli si lascia trascinare in situazioni pericolose. Ebbene, tutto ciò non è forse proprio di chi è infelice dalla testa ai piedi?” “A me sembra che sia proprio così”. [II,I,6] “Il fatto poi che la maggior parte delle attività umane più necessarie si svolgano all’aria aperta: per esempio, le campagne militari, l’agricoltura, ed altre di non minore importanza; mentre invece la maggior parte degli uomini non è affatto esercitato a sopportare i rigori invernali e le calure estive: ebbene, non ti pare questa una grande trascuratezza?” “Sì, è così”, assenti Aristippo. “Dunque, non pare anche a te che chi sarà un comandante debba esercitarsi anche a sopportare di buon grado questi disagi?” “Sì, è assolutamente così”, rispose Aristippo. [II,I,7] “Se dunque noi poniamo gli individui tolleranti di tutti questi disagi nel novero dei comandanti, non disporremo forse tutti coloro che sono incapaci di temperanza nel novero di quanti neppure pretenderanno di comandare?” “Sì, è così”, assenti Aristippo. “E dunque?”, chiese Socrate, “poiché hai riconosciuto l’esistenza di queste due classi di persone, hai già esaminato in quale di queste due classi tu potresti porre giustamente te stesso?” [II,I,8] “Quanto a me”, rispose Aristippo, “io non annovero affatto me stesso tra coloro che vogliono comandare. A me queste sembrano cose completamente da pazzi: il non accontentarsi di procurare a noi stessi lo stretto necessario, il che richiede già un gran lavoro; l’incaricarsi di provvedere a ciò di cui hanno bisogno anche gli altri cittadini, lasciando così da parte molte delle cose che uno vuole per sé; una volta diventato Capo dello Stato, qualora non si effettui tutto ciò che lo Stato vuole, il trovarsi pure soggetto a delle pene: ebbene, come può questo non essere il colmo della stoltezza? [II,I,9] Gli Stati ritengono, in effetti, che sia il caso di valersi dei loro Capi al modo in cui io mi valgo dei miei servi di casa. E come io pretendo dai miei domestici che essi mi forniscano in abbondanza tutte le provviste necessarie, e che però non le tocchino; così le città reputano che vadano trattati i loro Capi, provvedendole cioè della maggior quantità possibile di beni, dai quali però essi devono astenersi completamente. Educati in questo modo, io porrei dunque nel novero dei comandanti tutti coloro che vogliono crearsi molti fastidi, e molti fastidi procurare ad altri; e metto invece me stesso nel novero di quanti vogliono passare la vita quanto più si può con agio e piacevolezza”. [II,I,10] “Vuoi che analizziamo”, disse allora Socrate, “anche questo aspetto della faccenda, cioè quale delle due classi di persone sia quella che vive una vita più piacevole: coloro che comandano, oppure coloro che sono comandati?” “Senz’altro”, rispose Aristippo”. “Innanzitutto, prendiamo in considerazione le nazioni delle quali conosciamo l’esistenza. In Asia”, indicò Socrate, “a comandare sono i Persiani; mentre i comandati sono i Siriani, i Frigi e i Lidi. In Europa, a comandare sono gli Sciti, e i comandati sono i Meoti. In Libia comandano i Cartaginesi, mentre i comandati sono i Libici. Di tutti costoro, quali di questi popoli credi tu che vivano più piacevolmente? E dei Greci, tra i quali ci sei anche tu, quali ti paiono vivere più piacevolmente: i dominatori o i dominati?” [II,I,11] “Quanto a me”, rispose Aristippo, “io non pongo di certo me stesso tra gli schiavi, giacché mi sembra che esista una strada intermedia tra questi due estremi. Si tratta della strada sulla quale io mi sforzo di camminare, che è né la via battuta dal Signore, né quella battuta dal Servo, ma è la strada della libertà, la strada maestra che conduce alla felicità”. [II,I,12] “Ma se”, rispose Socrate, “questa strada è battuta né da chi è Signore né da chi è Servo, cioè non è battuta da alcun uomo, forse tu staresti dicendo qualcosa. Se tuttavia, vivendo tra gli uomini, riterrai giusto né comandare né essere comandato, e non rispetterai volontariamente coloro che comandano, credo che tu veda bene come i superiori sappiano trattare gli inferiori, sia in pubblico che in privato, come schiavi e farli accasciare urlanti di dolore. [II,I,13] Non sei al corrente del fatto che sono altri a tagliare il grano di coloro che lo hanno seminato, e a sradicare gli alberi di coloro che li hanno piantati; altri coloro che vessano in ogni modo i più deboli che non vogliono sottomettersi loro, fino a costringerli a scegliere la schiavitù pur di non continuare la guerra contro chi è più forte? E non sai che anche nel privato, gli uomini maschi e potenti soggiogano quelli codardi e deboli, e li sfruttano?” “Ma io”, disse Aristippo, “appunto per non subire simili maltrattamenti, non mi rinchiudo in una cittadinanza sola, e sono un forestiero che se ne va dappertutto”. [II,I,14] “Quel che hai appena detto”, commentò Socrate, “è una presa da esperto lottatore, giacché da quando sono morti Sini, Scirone e Procuste, nessuno più osa macchiarsi di un’ingiustizia contro i forestieri. Eppure al giorno d’oggi i politicanti che nelle loro patrie amministrano lo Stato e fanno le leggi, al fine di non subire ingiustizie, oltre a coloro che sono necessariamente loro alleati, cercano di acquisirne pure altri che corrano in loro soccorso; circondano le città di presidi fortificati; acquistano armi con le quali proteggersi dai malfattori; ed oltre a queste precauzioni, cercano di procurarsi alleati anche in Stati stranieri. Eppure, nonostante ciò, alcuni di loro, pur avendo a disposizione tutte queste difese, nondimeno subiscono delle ingiustizie. [II,I,15] E tu, senza avere a disposizione neppure una di queste protezioni; tu che passi gran parte del tuo tempo nelle strade, ossia dove la maggior parte della gente è oggetto di soprusi; tu, che in qualunque Stato sia giunto, sei l’ultimo di tutti i cittadini, e uno di coloro contro i quali specialmente attentano i facitori di ingiustizie: ebbene, tu egualmente, per il semplice fatto essere un forestiero, credi che non subiresti ingiustizia alcuna? È forse perché gli Stati strombazzano di garantirti sicurezza sia quando arrivi che quando ne riparti? È per questo che ti fai coraggio? È forse perché ritieni di poter essere uno schiavo che a nessun padrone rechi vantaggio? È forse perché pensi: chi vorrebbe tenersi in casa un uomo che non ha alcuna voglia di faticare, e che però apprezza molto un tenore di vita dispendiosissimo? [II,I,16] Analizziamo, allora, il modo in cui i padroni trattano simili schiavi domestici. Non è forse vero che ne temperano la lascivia affamandoli? Che impediscono loro di rubare, mettendo sotto chiave qualunque dispensa dalla quale sarebbe possibile sottrarre qualcosa? Che precludono loro la fuga, incatenandoli? Che ne scacciano la pigrizia a forza di percosse? E come ti comporti tu, quando ti accorgi che uno dei tuoi domestici è uno schiavo di questo genere?” [II,I,17] “Lo castigo”, rispose Aristippo, “sottoponendolo ad ogni sorta di maltrattamenti, fino a che l’abbia costretto a fare lo schiavo che è. E tuttavia, caro Socrate, coloro che sono stati educati all’arte regale del comando, arte che a me sembra tu reputi coincidere con la felicità, in cosa differiscono da coloro che sono sottoposti per necessità a sofferenze: si tratti della fame, della sete, dei brividi di freddo, delle veglie forzate, o di ogni altro incomodo; che essi volontariamente sopportano? Io non vedo che differenza ci sia tra il ricevere volontariamente sulla propria pelle delle frustate, e il riceverle involontariamente; oppure trovare il proprio corpo volontariamente o involontariamente assediato da tutti quei tormenti insieme. Sopportare volontariamente tali tormenti non è forse una caratteristica peculiare dello stolto?” [II,I,18] “Aristippo”, gli chiese allora Socrate, “perché parli così? Non ti pare che vi sia una gran differenza tra siffatti tormenti scelti volontariamente e quelli subiti involontariamente? Una differenza per la quale chi aspetta volontariamente di avere fame, può mangiare quando vuole, e altrettanto può fare chi ha sete; mentre invece chi è costretto a subire fame e sete non ha la potestà di farle cessare quando lo voglia? Inoltre, chi si trova volontariamente in situazioni difficili, pur soffrendo s’allieta per la buona speranza di successo che ha: per esempio, i cacciatori di animali selvatici faticano con piacere, per la speranza che hanno di catturarli. [II,I,19] Siffatti premi delle fatiche hanno però ben poco valore. Invece, quanti faticano per acquistarsi dei buoni amici o al fine di mettere le mani sui propri nemici personali; oppure affinché dopo essere diventati potenti sia di corpo che d’animo, possano governare bene casa loro, fare del bene agli amici e beneficare la patria: ebbene, come si può non credere che costoro fatichino con piacere per il raggiungimento di questi scopi, e che vivano lietamente, compiacendosi di se stessi e lodati ed emulati dagli altri? [II,I,20] La poltronaggine e i. piaceri facili ed immediati non sono atti, come dicono i maestri di ginnastica, a conferire al corpo una buona complessione, e neppure infondono nell’animo alcuna conoscenza degna di nota; mentre invece la dedizione costante alle opere virtuose, come affermano i galantuomini, ci permette di pervenire a simili risultati. Da qualche parte Esiodo dice:
‘Facile a scegliersi è la malvagità, e quanta ne vuoi;
piana è la via e molto vicina essa dimora;
ma gli dei immortali posero il sudore davanti alla virtù;
lunga e ripida è infatti la strada, e, al principio, aspra,
ma quando si giunge alla vetta,
diventa agevole poi, per quanto difficile sia’
e lo testimonia anche Epicarmo in questo verso:
‘è a costo di fatiche che gli dei ci vendono tutti i beni’
e in un altro verso dice:
‘Oh uomo dappoco, non cercare morbidezze,
onde tu n’abbia a provare le durezze’
[II,IB,21] Anche Prodico racconta che quando Eracle imprendeva il passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, età nella quale i giovani, mentre stanno diventando padroni di se stessi, mostrano se nella vita prenderanno la strada della virtù o quella del vizio, uscitosene un giorno e trovato un posto tranquillo, se ne stava seduto incerto su quale delle due strade prendere. [II,I,22] Parve allora ad Eracle che gli si avvicinassero due donne adulte. Una era d’aspetto bello e nobile ed appariva adornata al naturale: pulito il corpo, il rispetto di sé e degli altri negli occhi, la compostezza nel portamento, la veste bianca. L’altra era ben pasciuta e di morbide carni, imbellettata in modo da apparire di colorito più bianco e più roseo del vero, con un portamento che la faceva sembrare più dritta e alta del naturale. Teneva gli occhi spalancati e portava un vestito dal quale potesse trasparire tutta la sua avvenenza. Si guardava intorno di frequente, sorvegliava se qualcun altro la osservasse e spesso volgeva lo sguardo anche alla propria ombra. [II,I,23] Quando gli si furono fatte più vicino, la prima continuò a camminare con lo stesso passo mentre la seconda, volendo precederla, corse verso Eracle e gli disse: “Ti vedo, Eracle, incerto su quale strada prendere nella vita. Se mi farai amica tua, io ti guiderò per la strada più piacevole e più facile di tutte, non rimarrai inesperto di alcuna delle delizie della vita e vivrai immune da ogni molestia. [II,I,24] In primo luogo, infatti, non dovrai preoccuparti né di guerre né di affari ma soltanto di considerare quale gradito cibo o bevanda potresti trovare; quale spettacolo o quale musica potrebbe deliziarti; il profumo o il tatto di che cosa darti godimento; la conversazione con quali amanti allietarti di più; e come potresti dormire il più mollemente possibile e il modo per centrare tutto ciò con la minore fatica. [II,I,25] E se mai sorgesse il sospetto di una scarsità dei mezzi grazie ai quali queste cose si ottengono, non temere che io ti conduca a provvederli con fatiche e travagli di corpo e d’animo; ma tu farai uso dei frutti del lavoro altrui perché non ti asterrai da nulla da cui sia possibile trarre un qualche lucro. Io, infatti, procuro ai miei sodali la potestà di ricavare guadagno da qualunque attività. [II,I,26] Udite queste parole, Eracle le disse: “Donna, come ti chiami?” E lei rispose: “I miei amici mi chiamano Felicità, ma coloro che mi odiano mi denominano spregiativamente Vizio”. [II,I,27] Nel frattempo era sopraggiunta l’altra donna, la quale disse: “Io sono giunta da te, Eracle, sapendo anche chi sono i tuoi genitori e dopo avere decifrato a fondo, durante il periodo della tua educazione, la tua indole. Per questo, se prendessi la strada che porta da me, spero proprio che tu possa diventare un eccellente operatore di tutto ciò che è bello e solenne, e che io possa apparire ancor più onorevole ed illustre per i benefici che reco. Non ti ingannerò con preamboli che lusingano, ma esporrò con verità il modo in cui gli immortali hanno disposto la realtà delle cose. [II,I,28] Nulla di ciò che è bello e nobile gli immortali danno agli uomini senza fatica e studio. Se tu disponi che gli dei ti siano benigni, devi accudire gli dei; se vuoi essere amato dagli amici, devi beneficare gli amici; se smani di essere onorato da una qualche città, devi giovare a quella città; se solleciti di essere ammirato per valore da tutta la Grecia, devi provare a far bene per la Grecia; se disponi che la terra ti porti frutti abbondanti, devi accudire la terra; se credi di doverti arricchire con il bestiame, devi avere sollecitudine per il bestiame; se impelli a farti grande con la guerra e disponi di poter liberare gli amici e soggiogare i nemici, devi imparare la tecnica militare da coloro che ne hanno scienza ed esercitarti nel come debba essere usata; se disponi di essere forte fisicamente, devi abituare il corpo ad essere servitore dell’intelligenza ed allenarlo con fatiche e sudore”. [II,I,29] Allora, come racconta Prodico, il Vizio prese la parola e disse: “Eracle, hai il concetto di come sia esasperante e lunga la strada verso la Letizia che questa donna ti espone? Io invece ti condurrò alla Felicità per una strada facile e corta”. [II,I,30] E la Virtù disse: “Sciagurata, che bene hai tu? Che piacere conosci tu, se per ottenerli non vuoi fare nulla? Proprio tu, che neppure aspetti di desiderare le cose piacevoli ma prima ancora di averne desiderio ti riempi di tutte: mangi prima di avere fame; bevi prima di avere sete; e per il piacere di mangiare, escogiti stuzzichini; per il piacere di bere procuri vini costosi e d’estate corri qual e là a cercare la neve; per il piacere di dormire profondamente, ti procuri non soltanto molli coperte ma anche sostegni per i letti, giacché desideri il sonno non perché sei affaticata ma perché non hai niente da fare. Ti costringi al piacere sessuale prima del bisogno, escogitandone d’ogni sorta e usando i maschi da femmine. Così, infatti, tu educhi i tuoi amici: perpetrando azioni oltraggiose di notte e passando la parte più proficua del giorno a dormire. [II,I,31] Pur essendo tu immortale, sei stata cacciata via dal consorzio degli dei e sei spregiata dagli uomini buoni. La lode di te stessa, il suono più dolce di tutti, tu non l’hai mai sentito e non hai visto lo spettacolo più dolce di tutti, giacché non hai mai visto una tua opera bella. Chi si fiderebbe di qualcosa che tu dici? Chi ti soccorrerebbe se avessi bisogno di qualcosa? Chi, sano di mente, ardirebbe far parte della tua brigata? I membri della quale sono, da giovani, invalidi di corpo e, da anziani, dissennati d’animo. Infatti, grassi e panciuti come sono, passano la gioventù da sfaticati e trapasseranno penosamente la vecchiaia nello squallore, vergognandosi di quello che hanno fatto ed oppressi da quello che fanno. Giacché hanno trascorso la gioventù fra le dolcezze e messo da parte tutto l’amaro per la vecchiaia. [II,I,32] Io invece sto con gli dei e con gli uomini virtuosi; e nessuna bella opera, né divina né umana, si realizza senza di me. Sono poi onorata sia presso gli dei che presso gli uomini, con i nomi che più di tutti convengono: ‘amata collaboratrice’ presso gli artigiani; ‘leale custode’ presso i padroni di casa; ‘paziente assistente’ presso i domestici; ‘valente alleviatrice delle fatiche’ nella pace; ‘salda alleata’ delle operazioni nella guerra; ‘eccelsa compagna’ d’amicizia. [II,I,33] I miei amici gustano cibi e bevande con piacere e spensieratezza, poiché aspettano di averne desiderio. Il sonno è per loro più dolce che per gli scioperati, ed essi non si adontano nel lasciarlo né trascurano di fare il loro dovere per causa sua. I giovani si rallegrano delle lodi dei più anziani; i più vecchi gongolano per l’onore in cui sono tenuti dai giovani, e ricordano con piacere le loro faccende d’antica data mentre godono di bene operare le presenti, essendo grazie a me cari agli dei, amati dagli amici e onorati nelle loro patrie. E quando venga la fatale fine, non giacciono in oblio senza onori, ma la loro memoria verdeggia e sono inneggiati per l’eternità. Eracle, figlio di eccelsi genitori, dandoti da fare a questo modo tu hai la potestà di possedere la più beata delle felicità. [II,I,34] All’incirca a questo modo Prodico racconta l’educazione di Eracle da parte della Virtù, e ne abbellisce gli avvisi con parole ancor più grandiose di quelle che ho usato io adesso. In ogni caso, caro Aristippo, vale la pena che tu rimugini simili avvisi, e che ti sforzi di tenerli a mente per il resto della vita.
[II,II,1] Accortosi una volta che Lamprocle, il suo figliolo maggiore, era infuriato con sua madre, Socrate gli chiese: “Figliolo mio, dimmi: sai tu che esistono uomini che sono chiamati ‘ingrati’?” “Certo che lo so”, rispose il giovanotto. “Hai investigato che cosa fanno costoro per essere soprannominati così?” “L’ho fatto:”, rispose Lamprocle, “si chiamano ‘ingrati’ quanti hanno ricevuto un beneficio e sono in grado di ricambiarlo, e però essi non lo ricambiano”. “Non ti pare dunque che gli ingrati possano a buon diritto essere catalogati tra gli ingiusti?” “Io penso di sì”, [II,II,2] “Ora, se il ridurre in schiavitù gli amici è considerato un atto ingiusto, ed invece giusto il farlo con i nemici; hai già analizzato se sia ingiusto essere ingrati con gli amici, ed invece giusto il farlo con i nemici?” “L’ho già fatto, eccome! E la mia conclusione è che chi riceve un beneficio, sia da un amico che da un nemico, è una persona ingiusta se non cerca il modo di contraccambiarlo”. [II,II,3] “Dunque, se la faccenda sta in questi termini, l’ingratitudine sarebbe la pretta ingiustizia”. Lamprocle fu d’accordo. “Pertanto, più sono grandi i benefici che uno riceve e che non contraccambia, tanto più ingiusto egli sarebbe?” Lamprocle fu d’accordo anche su ciò. “Chi dunque troveremmo noi”, chiese Socrate, “avere ricevuto benefici più grandi di quelli che i figli ricevono dai genitori? Figli che i genitori hanno fatto passare dall’inesistenza alla esistenza; creature a cui essi hanno dato la possibilità di vedere tutto quanto il bello che esiste e di partecipare a tutto quanto il buono che gli dei procurano agli uomini? Bellezze e beni che ci appaiono di così eccelso valore, che dalla loro perdita noi tutti rifuggiamo più che da qualunque altra. E infatti gli Stati hanno istituito la pena di morte per i delitti più gravi, al fine di far cessare i crimini grazie a quella che è la paura del male più grande di tutti. [II,II,4] Tu sicuramente, hai chiaro il concetto che gli uomini non fanno dei figli allo scopo di soddisfare i loro bisogni sessuali, giacché di mezzi che sciolgano da questo bisogno sono piene le strade, colmi i bordelli. Noi abbiamo invece ben chiaro e ben esaminato da quale sorta di donne potrebbe nascerci la prole migliore, ed è accoppiandoci con queste che ne generiamo dei figli. [II,II,5] Di poi, è il marito che provvede al sostentamento di colei che con lui concorrerà alla generazione dei figli, e che per i figli che nasceranno procaccia in anticipo e nella maggior quantità che gli è possibile, tutto ciò che egli ritiene sarà utile per la loro vita. A sua volta è la donna che, dopo avere concepito il bambino, ne sostiene il fardello e, pur appesantita e correndo pericoli per la propria vita, gli fornisce il nutrimento che alimenta anche lei. Dopo avere portato con gran fatica a termine la gravidanza ed avere partorito il bambino, ella lo nutre e se ne prende cura; senza avere prima ricevuto da lui alcun beneficio, senza che il neonato sappia da chi gli vien fatto del bene, e neppure sia in grado di indicare ciò di cui abbisogna. E tuttavia ella congettura cosa può essergli utile e grato, e si sforza di soddisfarlo: nutrendolo per molto tempo e sopportando fatiche sia diurne che notturne, pur senza sapere quale ricompensa ne otterrà. [II,II,6] Ai genitori, inoltre, non basta allevare i figli. Infatti, qualora conoscano nozioni utili per vivere bene, e sembri loro che i figli sono ormai capaci di imparare qualcosa, essi le insegnano ai figli. E se credono che qualcuno sia un insegnante più capace di loro, mandano il figlio da costui, spendendo del denaro, e curano di fare ogni sforzo affinché i figli diventino quanto più è possibile migliori”. [II,II,7] A queste considerazioni di suo padre, il giovanotto rispose: “Ma pur se ella avesse fatto tutto ciò, ed anche molto di più, nessuno riuscirebbe a sopportarne l’intrattabilità”. “E quale delle due selvatichezze”, gli chiese Socrate, “ritieni più difficilmente tollerabile: quella di una belva o quella di una madre?” “Io credo”, rispose Lamprocle, “che sia quella di una madre fatta come la mia”. “Dunque qualche volta ti ha ella mai fatto del male mordendoti o tirandoti dei calci, tutti trattamenti che sono in molti ad avere subito dalle belve?” [II,II,8] “Ma per Zeus, quella lì dice cose che uno vorrebbe non ascoltare mai, neppure nel corso di una vita intera!” “A tua volta”, ribatté Socrate, “quanti sono i fastidi, tanto a parole quanto a fatti, che sei stato tu a procurare a lei da quand’eri bambino, sia di notte che di giorno; e quante le afflizioni quand’eri malato?” “Ma io”, precisò Lamprocle, “né mai le dissi, né mai le feci alcun gesto infamante”. [II,II,9] “E dunque”, gli chiese il padre, “pensi che sia più sgradevole per te ascoltare le parole che dice una madre, di quel che lo sia per degli attori, quando nelle tragedie essi si dicono le cose più terribili? “Io penso”, rispose Lamprocle, “che gli attori lo sopportino più facilmente, poiché essi non credono alle parole che dicono. Infatti, chi confuta non confuta per punire davvero, e chi minaccia non minaccia per fare seriamente del male”. “Eppure tu ti esasperi, pur sapendo bene che quanto ti dice tua madre, ella te lo dice non soltanto senza malanimo, bensì volendoti bene quanto a nessun altro?” “Io però”, rispose Lamprocle, “questo non lo credo proprio”. [II,II,10] “Dunque”, gli rispose Socrate, “una madre che ti vuol bene, che si prende cura di te quanto più può quando sei malato, che al fine di farti guarire non ti fa mancare nulla di ciò che è necessario, che prega gli dei affinché ti colmino di benedizioni e che fa voti per te: tu di costei affermi che è una madre esasperante? A parer mio, se tu non puoi sopportare una madre siffatta, tu non puoi sopportare le cose buone. [II,II,11] E dimmi un po’: c’è qualcun altro che tu ritieni si debba trattare con riguardo? O sei già pronto a sforzarti di non riuscire gradito ad alcun uomo, e a non ubbidirgli, sia egli un generale o qualche altro comandante?” “Per Zeus”, rispose Lamprocle, “sì, qualcuno c’è!” [II,II,12] “Pertanto tu vuoi riuscire gradito ad un vicino, affinché ti favorisca un po’ del suo fuoco, quando ce ne sia bisogno, e tu possa così accendere il tuo; che per qualche buona impresa ti assista; e che in caso tu inciampassi egli ti sia dappresso e di benevole aiuto. “Sono pienamente d’accordo”. “E dunque? Quanto ad un compagno di viaggio per terra o per mare, o in chiunque altro tu ti imbatta, non fa per te differenza alcuna che egli ti diventi amico o nemico; oppure credi che valga la pena di procurarti la benevolenza di costoro?” “Io credo che ne valga assolutamente la pena”. [II,II,13] “E dopo esserti procurato la benevolenza di costoro, ritieni di non dover trattare con lo stesso riguardo tua madre, ossia la persona che più di chiunque altro ti vuole bene? Non sai che lo Stato trascura del tutto e non considera come ingiustizia qualunque forma di ingratitudine, e pertanto non bada a coloro che non contraccambiano i favori ricevuti; e che invece, ove qualcuno tratti i propri genitori senza il dovuto riguardo, infligge a costui una pena, e gli rifiuta il ricoprimento di qualunque carica pubblica, in quanto i sacrifici officiati da costui a nome dello Stato non sarebbero offerti con la dovuta pietà, ed in quanto nulla di ciò che costui facesse avrebbe il carattere di essere onorevole e giusto? E per Zeus, qualora uno non tenga in perfetto ordine i sepolcri dei propri genitori defunti: ebbene, lo Stato tiene conto anche di questo al momento della valutazione dei candidati alla carica di Arconte. [II,II,14] Pertanto, figlio mio, se sei savio, ove tu abbia trascurato qualcuno dei doveri verso tua madre, tu supplicherai gli dei che ti perdonino; così che essi, ritenendoti un ingrato, non cessino di beneficarti. E sta bene in guardia, affinché gli uomini, una volta accortisi che tu trascuri i tuoi genitori, non ti disonorino tutti quanti; ed affinché, a seguito di ciò, tu non rimanga solo e privo di qualunque amico. Infatti, se essi ti prederanno per un individuo ingrato verso i genitori, nessuno di loro crederà, se ti facesse un beneficio, di poterne ottenere da te il contraccambio.
[II,III,1] Cherefonte e Cherecrate erano due fratelli a Socrate ben noti. Essendo venuto a sapere che essi erano in lite, vedendo una volta Cherecrate, Socrate lo chiamò e gli chiese: “Dimmi un po’, Cherecrate: sei forse davvero anche tu uno di quegli individui che ritengono gli averi essere cosa più proficua dei fratelli? Eppure gli averi sono cose prive di intelligenza, mentre il fratello è cosa dotata di intelligenza; gli averi vanno continuamente accuditi, mentre il fratello le cure è in grado di porgerle; gli averi sono di tantissime persone, mentre il fratello è un’unica persona. [II,III,2] Una cosa stupefacente è poi questa: ossia che uno ritenga i fratelli essergli causa di una perdita, perché non possiede anche i loro averi; mentre invece non ritiene per lui essere causa di perdita i cittadini, dei quali pure non possiede gli averi. In questo caso gli uomini possono tenere conto del fatto che è meglio vivere in sicurezza in mezzo a tante persone e avendo quanto basta, piuttosto che passare la vita in solitudine, ma a costo di grandi pericoli, possedendo gli averi di tutti i cittadini. E tuttavia gli uomini ignorano che lo stesso discorso vale anche nel caso dei fratelli. [II,III,3] Infatti, coloro che possono comprano dei domestici per avere così dei collaboratori, e si fanno degli amici quando hanno bisogno di aiuto; e però trascurano i fratelli, come se di tra i cittadini possono trarsi degli amici, ma non di tra i fratelli. [II,III,4] E invero, a fini di amicizia ha un gran valore l’essere nati dagli stessi genitori, e gran cosa è pure l’essere stati allevati insieme; giacché anche tra le belve cresciute assieme si ingenera una intensa brama di vicinanza. Inoltre, gli uomini trattano quanti hanno dei fratelli, con rispetto maggiore di quello che riservano a quanti non ne hanno, e sono loro meno ostili”. [II,III,5] Al che Cherecrate rispose: “Socrate, se la lite fosse su questioni di piccolo conto, forse si dovrebbe sopportare un fratello; e non tenersene lontani per delle sciocchezze. In effetti, come tu dici, un fratello come si deve è un bene. E però quando egli viene completamente meno alla fratellanza, ed è tutto l’opposto di un fratello: perché uno dovrebbe mettere mano ad imprese impossibili?” [II,III,6] Socrate allora gli rispose: “Cherecrate, ma Cherefonte riesce sgradito assolutamente a tutti, come lo è a te; oppure esistono persone alle quali egli riesce del tutto gradito?” “Socrate, ma è proprio per questo motivo”, gli rispose Cherecrate, “che egli merita tutto il mio odio. Egli è infatti capace di rendersi gradito agli altri; ma qualunque sia il momento e qualunque sia il luogo in cui mi sta accanto, egli è per me, sia a fatti che a parole, più una punizione che un giovamento”. [II,III,7] “Dunque, come il cavallo”, aggiunse Socrate, “è una punizione per chi mette mano a cavalcarlo nella completa ignoranza dell’equitazione; così pure un fratello è una punizione per chi, senza affatto conoscerlo, mette mano ad interloquire con lui?” [II,III,8] “E come potrei io”, gli rispose Cherecrate, “non conoscere il modo di interloquire con mio fratello, dal momento che so benissimo come parlar bene di qualcuno che parla bene di me, e fare del bene a chi mi fa del bene? Invero, di chi, sia a parole che a fatti, fa ogni sforzo per infastidirmi, io non potrei né parlar bene né fargli del bene, e quindi neppure ci proverò”. [II,III,9] “Ma, Cherecrate, tu mi stai dicendo”, gli rispose Socrate, “qualcosa di stupefacente. Tu mi stai dicendo di avere un cane da gregge, adattissimo a far la guardia alle pecore e che accoglie pure festosamente qualunque pastore, il quale però si mette a ringhiarti minacciosamente contro non appena ti avvicini a lui; e che tu, messo da parte ogni scatto di ira, fai ogni sforzo per ammansirlo con le buone maniere. Tu affermi anche che un fratello è un gran bene, se si comporta verso di te come deve, ed ammetti di sapere perfettamente come parlar bene e fare del bene, e che tuttavia non intendi dedicarti a escogitare il modo per far sì che egli sia per te il migliore fratello possibile”. [II,III,10] Al che Cherecrate rispose: “Socrate, io temo di non avere la sapienza necessaria per far sì che Cherefonte sia nei miei riguardi il fratello che deve essere”. “Invero, per quanto riguarda tuo fratello, a mio parere”, disse Socrate, “non c’è bisogno di escogitare modi complicati o nuovi, e del resto io credo che tu stesso li conosca già, per guadagnarti la sua altissima stima”. [II,III,11] “Se ti sei accorto che io conosco un filtro magico che io stesso ignoro di sapere, ti prego di dirmelo subito”. “Dunque”, gli chiese Socrate, “se tu volessi che uno dei tuoi conoscenti ti coinvolgesse in una cerimonia sacrificale e che ti invitasse a pranzo: cosa faresti?” “È manifesto che comincerei io per primo, quando offrissi un sacrificio, ad invitarlo da me”. [II,III,12] “E se tu volessi incentivare uno dei tuoi amici a prendersi cura dei tuoi averi, ogni volta che tu ti allontanassi dalla patria: cosa faresti?” “È manifesto che io per primo metterei mano a prendermi cura dei suoi averi, ogni volta che egli si allontanasse dalla patria sua”. [II,III,13] “E se tu volessi far sì che uno straniero ti ospitasse in casa sua, ogni volta che tu ti recassi nella sua patria: cosa faresti?” “È manifesto che io per primo lo ospiterei in casa mia, ogni volta che egli venisse ad Atene. E se io volessi che quello sbrigasse premurosamente per me delle faccende per le quali io sono giunto da lui, è altrettanto manifesto che io per primo dovrei fare la stessa cosa per lui”. [II,III,14] “Dunque è da gran tempo, disse Socrate, che celavi in te la conoscenza di tutte le pozioni magiche che gli uomini usano? Oppure, è per non parer dare un segno di impudenza, che ti periti di essere tu a fare per primo una buona azione verso tuo fratello? Eppure, in verità, uomo degno di grandissima lode appare essere colui che precede tutti gli altri nel fare del male ai nemici e nel beneficare gli amici. E se prima mi sembrava che Cherefonte fosse più disponibile di te a questa amicizia, io avrei cercato ogni modo per persuadere lui a metter mano per primo a ristabilire il legame con te; ora però sei tu che mi appari più disponibile di lui a lavorare per questa ricomposizione. [II,III,15] E Cherecrate gli rispose: “Socrate, tu stai dicendo cose assurde e indegne di te, dal momento che intimi a me, che sono il più giovane, di prendere l’iniziativa; mentre per certo presso tutti gli uomini si ritiene l’esatto opposto: cioè che sia il più anziano a prendere qualunque iniziativa, sia a fatti che a parole”. [II,III,16] “Ma come”, rispose Socrate, “non si ritiene ovunque, che il più giovane debba cedere il passo alla persona più anziana in cui si imbatte, alzarsi se è seduto, fargli l’onore di un giaciglio comodo, lasciargli la parola? Caro mio, non indugiare, e metti mano ad ammansire quell’uomo; e vedrai che egli prestissimo ti ubbidirà. Non vedi quanto egli sia ambizioso e libero? Per catturare gli esseri umani malvagi bastano e avanzano dei regali. Ma i galantuomini li persuaderesti unicamente trattandoli con amichevole cortesia”. [II,III,17] “Ma se io faccio quello che tu mi suggerisci ora”, disse Cherecrate, “e però lui non migliora affatto il suo atteggiamento nei miei confronti?” “Cos’altro vuoi che succeda”, gli rispose Socrate, “se non che tu correrai il rischio di dimostrare di essere una persona proba ed amichevole, mentre lui è un individuo stolto ed indegno d’essere trattato bene? Ma io credo che non accadrà nulla di tutto ciò. Ritengo, infatti, che egli, dal momento in cui si accorgerà che tu lo sfidi a gareggiare, combatterà con tutte le sue forze per avere il sopravvento su di te, facendo del bene sia a parole che a fatti. [II,III,18] Voi due adesso siete disposti come lo sono le due mani, che il cielo fece affinché si soccorressero a vicenda; e invece, tralasciato ciò, esse si volgessero ad impedirsi l’un l’altra. Oppure come i due piedi, i quali, per destino divino fatti per aiutarsi a vicenda, trascurando di fare così, si intralciassero l’un l’altro. [II,III,19] Il danneggiarsi a vicenda, per coloro che sono stati invece fatti per essere di reciproco giovamento, non sarebbe forse una grave mancanza di cultura ed una somma infelicità? In verità, a me pare che due fratelli, il cielo li abbia fatti affinché fossero di un giovamento reciproco ben maggiore di quello di due mani, di due piedi, di due occhi, e di tutti quanti gli altri organi doppi che la natura generò negli uomini. Le mani, infatti, quando ce ne fosse bisogno, non potrebbero fare contemporaneamente loro due oggetti che fossero lontani più di una tesa; e i piedi non possono poggiare contemporaneamente su oggetti che distano uno dall’altro una tesa. Gli occhi, i quali appaiono capaci di gettare lo sguardo lontanissimo, non potrebbero però vedere oggetti anche vicinissimi che abbiano sia, proprio dinanzi a loro, oppure dietro di loro. Invece due fratelli che sono amici tra di loro, pur essendo lontanissimi uno dall’altro, possono al contempo essere di giovamento reciproco.
[II,IV,1] Una volta io ascoltai Socrate discorrere sul tema dell’amicizia, e gli udii pronunciare parole dalle quali a me pare che si possa trarre gran vantaggio, sia quanto al modo acquisire amici, sia quanto al modo di servirsene. Egli affermava, in proposito, di avere sentito dire da moltissima gente che un amico sincero e dabbene è il più eccellente di tutti i possessi. Aggiungeva però, di vedere che la maggior parte degli uomini, di tutto si prendeva cura piuttosto che di farsi degli amici. [II,IV,2] Infatti diceva di notare che gli uomini pongono ogni attenzione possibile nell’acquisizione di case, di terreni agricoli, di schiavi, di bestiame e di suppellettili, e che fanno ogni sforzo per salvaguardarsene il possesso; mentre di un amico, che pure affermano essere il massimo bene, diceva di osservare che i più né si preoccupano di acquisirlo, né di salvaguardare l’amicizia con quelli che hanno già. [II,IV,3] Anzi, quando tanto degli amici che degli schiavi domestici erano sofferenti, Socrate diceva di vedere che, per gli schiavi domestici, alcuni facevano venire in casa dei medici ed apprestavano con cura tutti i vari rimedi risanatori, mentre della salute degli amici non si davano affatto pensiero. Quando poi capitava che morissero sia uno dei primi che uno dei secondi, i padroni si sentivano oppressi dal dolore per la scomparsa di schiavi domestici e la reputavano una perdita; mentre la scomparsa di amici non li prostrava affatto. Quanto agli altri averi, nulla lasciavano gli uomini negletto o incontrollato, mentre degli amici che avevano bisogno di attenzioni non si prendevano affatto cura. [II,IV,4] Oltre a ciò, Socrate diceva di vedere che la maggior parte degli uomini conosce la quantità dei vari averi che possiede, pur quando queste proprietà sono assai numerose; e che invece degli amici che ha, i quali pur sono pochissimi, non soltanto non conosce il numero, ma numerandoli sulle dita di una mano, muta di avviso quando li riconta: tant’è grande la premura che essi dedicano agli amici. [II,IV,5] Eppure, se paragonato a qualunque altro avere, un amico dabbene non apparirebbe forse il possesso di gran lunga migliore? Quale cavallo o quale tiro a due sarebbe tanto proficuo quanto un amico probo? Quale schiavo avrebbe così tanta buona volontà e sarebbe così fedele? Quale altro possesso è di così universale utilità? [II,IV,6] Infatti, l’amico dabbene si mette a disposizione dell’amico per tutto ciò di cui questi è mancante, per mettere ordine sia nei suoi affari privati che in quelli pubblici. Quando egli debba fare del bene a qualcuno, l’amico dabbene unisce a lui le sue forze. Se qualche paura lo sconcerta, egli corre in suo aiuto: a volte partecipa alle sue spese, a volte coopera col suo lavoro, a volte con la persuasione, a volte facendogli forza, il più delle volte allietandosi con quanti hanno buoni successi, e il più delle volte rimettendo in piedi coloro che hanno fatto dei passi falsi. [II,IV,7] I servigi che a ciascuno di noi rendono le mani, gli occhi che vedono, le orecchie che sentono, i piedi che ci permettono di incedere: ebbene, a nessuno di questi servigi un amico benevolo è inferiore. Anzi, molte volte ciò che uno non ha ancora messo in opera per sé, o non ha visto, o non ha udito, o i passi che non ha fatto: ebbene, l’amico li ha già principiati per l’amico. Nonostante ciò, taluni dedicano ogni cura alla coltivazione degli alberi in vista della raccolta dei frutti, mentre a quel possesso capace di dare ogni sorta di frutti, che si chiama ‘amico’, la maggior parte degli uomini dedica un’attenzione pigra e svogliata.
[II,V,1] Una volta udii anche un altro discorso di Socrate, nel quale a me pareva che egli spronasse uno degli ascoltatori ad esaminarsi sul proprio valore per gli amici che aveva. Infatti, visto che uno dei suoi sodali trascurava del tutto un amico che si trovava in estrema povertà, in presenza di costui e di molte altre persone, [II,V,2] interrogò Antistene e gli chiese: “Antistene, esistono forse diversi valori in denaro degli amici, così come ne esistono diversi per gli schiavi domestici? Degli schiavi domestici, infatti, uno può costare due mine, un altro neppure mezza mina, un altro costare cinque mine, e un altro ancora finanche dieci mine. Per esempio si racconta che Nicia, il figlio di Nicerato, abbia comprato, quale soprintendente delle miniere d’argento, uno schiavo che costava un talento. Analizziamo dunque a fondo questa faccenda”, insistette Socrate, “ossia se, com’è il caso degli schiavi domestici, anche gli amici abbiano un valore in denaro”. [II,V,3] “Sì, per Zeus”, gli rispose Antistene, “piuttosto che due mine, io vorrei l’amicizia di una certa persona; un’altra la valuterei nemmeno mezza mina; invece un’altra la sceglierei come amica, preferendola a dieci mine; l’amicizia di un’altra ancora, la vorrei a costo di qualsiasi somma di denaro e di qualunque fatica”. [II,V,4] “Dunque”, disse Socrate, “se le cose stanno in questi termini, sarebbe bene che ognuno di noi indagasse a fondo se stesso, su quale sia il suo valore per gli amici che ha; e che faccia di tutto per valere il più possibile, affinché questi non lo vendano a tradimento sottoprezzo. Infatti, molte volte io sento qualcuno dire che un amico lo ha venduto a tradimento; un altro dire che un uomo che egli credeva amico suo, ha scelto di venderlo a tradimento al prezzo di una mina. [II,V,5] In tutti i casi di questo genere io considero che, se qualcuno vende un pessimo schiavo e lo vende a qualunque prezzo, forse uno si sente invogliato a vendere un pessimo amico qualora possa ricavarne assai più del giusto prezzo. Invece, di schiavi domestici probi io non ne vedo messi in vendita neppur uno, né vedo amici di specchiata probità esser venduti a tradimento.
[II,VI,1] Anche circa il valutare coloro che vale la pena di farsi amici, a me sembrava che Socrate facesse rinsavire il suo interlocutore, quando parlava come segue: “Dimmi un po’, Critobulo, se avessimo bisogno di un buon amico, cosa prenderemmo in considerazione? In primo luogo non dobbiamo forse scovare chi abbia il completo dominio sugli impulsi del ventre, sugli eccessi nel bere, sulla lascivia, sul sonno e sulla pigrizia? Infatti chi è dominato da questi impulsi non potrebbe fare ciò che è doveroso, né per lui stesso né a favore di un amico”. “Per Zeus, certo che ne sarebbe incapace”, gli rispose Critobulo. “Dunque, a te sembra che una persona dominata da questi impulsi vada scartata come amico?” “Assolutamente sì”. [II,VI,2] “E poi? Chi è uno spendaccione incapace di bastare a se stesso ed ha continuamente bisogno dei vicini? Colui che quando ottiene del denaro in prestito, non lo restituisce; e quando non lo ottiene odia chi non glielo ha prestato? Non ti sembra che anche l’amicizia di costui sarebbe una vera disgrazia?” “Assolutamente sì, lo è.” “Dunque, anche costui è da scartare quale possibile amico?” “Sì, è davvero da scartare”. [II,VI,3] “E poi? Colui che è capace di accumulare roba e smania di accumularne sempre di più? E che per questo motivo è tutt’altro che socievole? E che, inoltre, quando accumula roba gioisce, e non vuole mai rendere alcunché?”. “A me sembra”, disse Critobulo, “che costui sia una persona ancor più malvagia della precedente”. [II,VI,4] “E poi? Chi, a causa della sua sfrenata passione per l’accumulazione di denaro, non si dà tregua finché non abbia trovato donde cavar guadagno?” “A me sembra che anche costui sia del tutto da scartare; giacché di nessun giovamento sarebbe a chi di lui si servisse”. “E poi? Chi è sedizioso e vuole procurare numerosi nemici ai suoi amici?” “Per Zeus, da una persona simile bisogna fuggire a gambe levate!” “E se uno non avesse alcuno di questi vizi, e mentre accetta volentieri di essere trattato bene, non si preoccupa però affatto di rendere il contraccambio?” “Pure costui sarebbe di nessun giovamento. Ma allora, caro il mio Socrate, quale sorta d’uomo metteremo mano a farci amico?” [II,VI,5] “Chiunque, io credo, sia l’opposto di tutti questi viziosi. Dunque: chi ha la piena padronanza dei piaceri del corpo, chi è ospitale, leale negli accordi che capita di fare, ambizioso di non rimanere indietro nel far del bene a coloro che lo hanno già beneficato, per essere così di vantaggio a coloro che di lui si valgono”. [II,VI,6] “E in che modo potremmo noi valutare tutte queste qualità, prima di valercene come amico?” “Gli scultori”, rispose Socrate, “noi li valutiamo basandoci non sulle loro parole, ma sul fatto di vedere che abbiano scolpito con arte perfetta delle statue già in precedenza. Così facendo, siamo fiduciosi che costui scolpirà altrettanto bene le statue future”. [II,VI,7] “E tu dici”, chiese Critobulo, “che un uomo il quale mostri di avere fatto del bene agli amici già tempo prima, manifestamente beneficerà anche gli amici che avrà in seguito?” “Sì”, rispose Socrate, “giacché colui che io so avere già in precedenza utilizzato a regola d’arte dei cavalli, credo che in seguito farà buon uso anche di altri cavalli”. [II,VI,8] “Sia pur così”, disse Critobulo, “ma qual è il modo più opportuno per farsi amico colui che ci appare degno della nostra amicizia?” “In primo luogo bisogna esaminare quali siano le disposizioni degli dei, e se il loro consiglio è quello di farcelo amico”. “E dunque? Se a noi sembra il caso di farcelo amico, e se gli dei a ciò non si oppongono, sai dirmi come si debba andarne a caccia?” [II,VI,9] “Per Zeus, non certo seguendone a piedi le orme , come si fa con la lepre; né con le trappole, come si fa con gli uccelli; né con la violenza, come si fa con i nemici. È opera ben gravosa il farsi un amico contro la sua volontà; ed è ben arduo il conservarlo mettendolo ai lacci come uno schiavo; giacché coloro che subiscono questi trattamenti diventano nemici piuttosto che amici”. [II,VI,10] “Dunque come farseli amici?” “Alcuni affermano”, rispose Socrate, “che esistono degli incantamenti, cantando i quali, coloro che li conoscono riescono a farsi amico chi vogliono. Si parla anche dell’esistenza di filtri magici, grazie ai quali, chi li conosce e li somministra, riesce a farsi amico chiunque voglia”. [II,VI,11] “E da chi potremmo”, chiese Critobulo, imparare queste arti?” “Gli incantamenti che le Sirene cantavano ad Odisseo, li hai certamente sentiti pronunciare da Omero, e cominciano all’incirca con queste parole”:
‘Qui, presto vieni, o glorioso Odisseo, grande vanto degli Achei’
“Socrate, questo è dunque l’incantamento”, chiese Critobulo, “che le Sirene cantavano anche agli altri uomini per trattenerli, così che quelli ch’erano presi per incantamento non si allontanassero più da loro?” [II,VI,12] “L’incantamento non era diretto a tutti, ma a chi, per la propria eccellenza, ambiva la gloria”. “Pressappoco stai dicendo”, chiese Critobulo, “che è d’uopo cantare incantamenti tali che chi li ascolta non ritenga di essere in realtà ridicolizzato da chi lo sta lodando?” “Sì, giacché così facendo”, rispose Socrate, “chi fa l’incantamento gli si mostrerebbe ancor più nemico, ed allontanerebbe gli uomini da sé, se lodasse chi sa di essere piccolo, laido e debole, dicendo invece che è bello, grande e potente”. “E conosci tu degli altri incantamenti?” [II,VI,13] “No, ma ho sentito dire che Pericle ne conosceva molti, cantando i quali alla città egli faceva sì che essa lo amasse”. “E come riuscì Temistocle a far sì che la città lo amasse?” “Ma per Zeus, di certo non cantando, ma circondandola di certi eccellenti amuleti”. [II,VI,14] “Socrate, tu mi stia dicendo, così mi sembra, che se intendiamo acquistarci un buon amico, dobbiamo diventare noi stessi uomini virtuosi, sia a parole che a fatti”. “Tu credevi”, disse Socrate, “di essere capace, da uomo malvagio, di acquistarti l’amicizia di uomini probi?” [II,VI,15] “L’ho creduto, giacché ho visto oratori di nessun valore in rapporti amichevoli con parlatori più che egregi, e gente militarmente inetta in compagnia di comandanti militari peritissimi”. [II,VI,16] “Dunque, a proposito di ciò che stiamo discutendo”, chiese Socrate, “conosci tu delle persone del tutto inette ma capaci di farsi amici degli uomini in grado di giovare loro?” “Per Zeus, questo no”, gli rispose Critobulo; “ma se è impossibile che una persona malvagia possa farsi amici degli uomini dabbene; quel che mi interessa sapere è se si dà il caso che un uomo diventato dabbene, sia di per sé preparato e pronto ad essere amico di uomini dabbene”. [II,VI,17] “Ciò che ti sconcerta, mio caro Critobulo”, gli rispose Socrate, “è che spesso tu vedi persone che agiscono bene e che si astengono da azioni vergognose; le quali persone, invece di essere amiche, sono in continuo disaccordo tra di loro e si trattano peggio delle persone da nulla”. [II,VI,18] “Ed a trattarsi così”, disse Critobulo, “non sono soltanto gli individui singoli, ma anche gli Stati. Questi infatti, che sono massimamente solleciti della giustizia e che non approvano affatto le ingiustizie, spesso si trattano però l’un l’altro da nemici. [II,VI,19] Tenuto conto di questi fatti, io mi sento del tutto scoraggiato a farmi degli amici, visto che i malvagi non possono esserlo tra di loro. Infatti, come potrebbero diventare amici individui ingrati, trascurati, prevaricatori, infidi, non padroni di sé? Dunque i malvagi mi sembrano assolutamente e per natura, nemici uno dell’altro, ben più che amici. [II,VI,20] E invero, come dici tu, i malvagi non potrebbero mai conciliarsi in amicizia con gli uomini probi. Gli individui che fanno azioni malvagie, come potrebbero mai diventare amici di uomini che odiano siffatte azioni? E inoltre, se gli uomini esercitati alla virtù sono in continuo disaccordo tra di loro sul primeggiare negli Stati e, invidiosi come sono uno dell’altro, si odiano a vicenda; chi mai sarà più un amico, e tra quali uomini esisteranno ancora la benevolenza e la fiducia reciproca?” [II,VI,21] “Caro Critobulo”, rispose Socrate, “si tratta di una faccenda che ha aspetti assai variegati. Infatti, gli uomini hanno per natura degli impulsi alla pace, giacché hanno bisogno gli uni degli altri, provano compassione reciproca, collaborano tra di loro e si giovano a vicenda; ed avendo coscienza di ciò mostrano gratitudine gli uni verso gli altri. Ma gli uomini hanno anche impulsi naturali alla guerra, e legittimando entrambi gli impulsi come buoni e accettabili, e così dissentendo tra loro sulla pace e sulla guerra, si oppongono e arrivano a combattersi. Discordia e ira portano alla guerra, la voglia sfrenata di prevalere sugli altri diventa ostilità, e l’invidia diventa odio. [II,VI,22] Eppure, nonostante tutto ciò, l’amicizia si insinua tra gli uomini e congiunge insieme quelli dabbene. Grazie alla loro virtù, gli uomini dabbene scelgono, senza fatica, di possedere i beni con moderazione, piuttosto che di signoreggiare su tutto attraverso la guerra. Quando hanno fame e sete, essi sono capaci, senza affliggersene, di mettere in comune il cibo e le bevande; e pur sapendo godere dei piaceri sessuali con chi è nel fior degli anni, sanno padroneggiarsi così da non generare afflizione in chi non deve subirne. [II,VI,23] Gli uomini dabbene sono anche capaci, non soltanto di astenersi dalla eccessiva ricchezza e di mettere in comune quella legittima, ma anche di sovvenirsi l’un l’altro in caso di bisogno. Sanno comporre le discordie, non solo senza affliggersi, ma traendone utilità reciproca; ed impedire all’ira di procedere fino al rimorso. Essi, inoltre, bandiscono del tutto l’invidia, ed offrono i loro beni agli amici, ritenendo a loro volta propri, i beni degli amici. [II,VI,24] Come può essere verosimile che degli uomini dabbene, i quali non solo non si danneggiano ma anzi si giovano reciprocamente, non siano chiamati a compartecipare ad incarichi politici? Infatti, coloro che smaniano di ottenere onorificenze e di comandare nei vari Stati, per avere così la potestà di rubare il denaro pubblico, di usare la violenza contro i cittadini, e di spassarsela, sarebbero in ogni caso tutti ingiusti, malvagi, ed incapaci di andare d’accordo con chiunque. [II,VI,25] Se invece qualcuno vuole ottenere delle onorificenze da parte dello Stato, così da non essere più oggetto di ingiustizie, così da poter aiutare gli amici per una giusta causa; e se da funzionario cerca di fare qualcosa di buono per la patria: ebbene, perché un uomo del genere non potrebbe andare d’accordo con un altro individuo dello stesso genere? Forse che costui, insieme con gli uomini dabbene, potrà esser di minore giovamento agli amici, o avrà forse minori possibilità di beneficare lo Stato, avendo quali collaboratori degli uomini dabbene? [II,VI,26] Anche nel caso delle gare di atletica, è evidente che se fosse consentito al gruppo di atleti più forte, di gareggiare insieme contro il gruppo dei più deboli, i primi vincerebbero tutte le gare ed otterrebbero tutti i premi spettanti ai vincitori. Poiché, dunque, nel caso delle gare di atletica, questa pratica è proibita; e invece nel caso dell’attività politica, campo nel quale gli uomini dabbene detengono di gran lunga la supremazia, nessuno impedisce di fare del bene allo Stato associandosi con chiunque si voglia: ebbene, come può essere svantaggioso l’amministrare la cosa pubblica, se si hanno con sé gli amici più eccellenti, e se in tali faccende tutti si trattano come soci e collaboratori piuttosto che come antagonisti? [II,VI,27] Invero, è manifesto che se uno fa la guerra ad un altro, avrà bisogno di alleati, e di alleati in gran numero, ove si tratti di contrapporsi ad una armata di soldati valorosi. Inoltre i volontari che ha come alleati, egli dovrà coprirli di benefici, affinché questi accettino così di dimostrarsi coraggiosi. Cosa molto migliore è però il beneficare i pochi che sono più valorosi, piuttosto dei molti che sono codardi, giacché i codardi pretendono una quantità di prebende assai maggiore di quella richiesta dai prodi. [II,VI,28] Fatti dunque coraggio, mio caro Critobulo, e cerca di diventare un uomo virtuoso. E una volta diventatolo, metti mano alla caccia degli uomini dabbene. Forse potrei anch’io soccorrerti in questa caccia ai virtuosi, giacché io sono un adepto di eros. Circa gli uomini per i quali io eventualmente smanierò, mi sento già ora tutto intero preso da un impeto a farmeli amici e ad essere ricambiato dalla loro amicizia, a bramare la conversazione con loro e ad essere ricambiato con la stessa brama, a smaniare di stare insieme a loro ed a notare in loro la stessa smania. [II,VI,29] Io vedo che tu pure di queste cose senti il bisogno, quando smani di farti delle amicizie. Dunque, non nascondermi chi siano gli uomini che vorresti farti amici; e grazie al mio darmi cura di riuscire gradito a chi mi è gradito, credo di non essere inesperto nella caccia agli uomini. [II,VI,30] “Invero, caro Socrate, è da gran tempo”, rispose Critobulo, “che io smanio di apprendere queste nozioni; soprattutto se una medesima scienza mi sarà sufficiente per catturare le persone nobili d’animo e belle di corpo”. [II,VI,31] “Ma mio caro Critobulo”, gli rispose Socrate, “la mia scienza non comprende il mettere le mani addosso ai belli, per farli fermare. Io sono persuaso che gli uomini rifuggivano da Scilla per questo motivo, ossia perché ella metteva loro le mani addosso. Invece si dice che le Sirene, poiché non mettevano le mani addosso ad alcuno e cantavano a tutti da lontano i loro incantamenti, facessero fermare tutti gli uomini che rimanevano ammaliati dal loro canto”. [II,VI,32] “Io non metterò le mani addosso a nessuno”, promise Critobulo, “e tu insegnami quanto di buono conosci che sia utile per farsi degli amici”. “Dunque”, chiese Socrate, “neppure avvicinerai le labbra alle labbra di qualcuno?” “Abbi fiducia in me: io non avvicinerò le mie labbra”, rispose Critobulo, “a quelle di chiunque non sia bello”. “Ed ecco che tu, mio caro Critobulo, hai già subito fatto una affermazione del tutto sconveniente. Infatti siffatti baci, le persone belle d’animo non li sopportano; mentre sono quelle malvagie che volentieri di essi si compiacciono, credendo di essere chiamate così perché d’animo nobile. [II,VI,33] Al che Critobulo rispose: “Visto che bacerò una volta le persone belle di corpo, e che ribacerò più volte quelle di animo nobile: orsù, insegnami l’arte di andare a caccia di amici”. “Qualora dunque, caro Critobulo, tu voglia”, gli rispose Socrate, “diventare amico di qualcuno; mi permetterai di parlargli e di dirgli che tu lo ammiri e che smani di diventare suo amico?” “Dichiaraglielo pure”, disse Critobulo, “giacché so che nessuno odia coloro che lo lodano”. [II,VI,34] “E se inoltre aggiungerò”, disse Socrate, “che a causa dell’ammirazione che hai per lui, tu provi benevolenza nei suoi confronti; penserai forse che per parte mia io ti stia calunniando?” “Anzi, è il contrario”, disse Critobulo, “giacché in me si ingenera spontaneamente una particolare benevolenza verso coloro che io concepisco provare benevolenza nei miei confronti”. [II,VI,35] “Bene”, continuò Socrate, “dunque mi è concessa la piena potestà, a tuo riguardo, di parlare in questi termini con coloro che tu vorrai farti amici. Se, inoltre, mi concederai la potestà di dire, a tuo riguardo, che ti prendi ogni cura degli amici; che della compagnia di nessuno gioisci quanto di quella di amici dabbene; che ti compiaci delle opere virtuose degli amici, non meno che delle tue; che gioisci delle buone fortune degli amici non meno che delle tue, e che non ti stanchi un istante di trovare il modo per far sì che queste accadano loro; che da tempo hai riconosciuto che proprio di un uomo virtuoso è il superare gli amici nel far loro del bene e nel fare del male ai nemici: ebbene, io credo fermamente che sarei per te un più che idoneo compagno nella caccia agli amici dabbene”. [II,VI,36] “E perché mai”, gli chiese Critobulo, “mi dici queste cose; come se non dipendesse soltanto da te quel che vorrai eventualmente dire a mio riguardo?” “No, per Zeus! Quel che sto dicendo è ciò che io ho sentito una volta affermare da Aspasia. Ella soleva infatti dire che le buone mediatrici di matrimoni, riferendo secondo verità la dote posseduta dalle donne, sono portentose nel combinare per loro le nozze con degli uomini; e ripeteva però anche di non volere assolutamente lodare le mediatrici mendaci. Infatti, coloro che sono stati da esse ingannati, si odiano l’un l’altra, ed insieme odiano quella che ha fatto da mediatrice. Io pertanto, persuaso come sono della correttezza si simili affermazioni, quando ti lodo ritengo di non avere la potestà di dire alcunché che non sia pienamente veritiero”. [II,VI,37] “Dunque, mio caro Socrate, tu sei per me quel genere di amico”, disse Critobulo, “tale che tu mi vieni in soccorso se io già di mio sono idoneo a farmi degli amici; e che però, se io idoneo non sono, non inventerebbe mai qualche favoletta a mio giovamento”. “Mio caro Critobulo”, gli rispose Socrate, “io sembro a te giovarti di più se ti lodo dicendo delle menzogne, oppure persuadendoti a sforzarti di diventare un uomo dabbene? [II,VI,38] Se la risposta non ti appare abbastanza evidente, analizza la faccenda in questo modo. Se io, volendo farti diventare amico del comandante di una nave, tessessi le tue lodi mentendo, e quindi asserissi che tu sei un ottino nocchiero; e se egli, a questo punto, convinto dalle mie parole, cedesse a te, che non conosci affatto l’arte di governarla, il comando della nave: ebbene, hai qualche speranza di non mandare in malora sia te stesso che la nave? Oppure se io, ingannando pubblicamente l’intera città, la inducessi ad affidare a te, come generale espertissimo, giurista di prim’ordine ed abilissimo politico, la guida dello Stato: ebbene, cosa credi che sperimenteresti tu e che soffrirebbe lo Stato per opera tua? Oppure se io, ingannando in privato un certo numero di cittadini, li inducessi ad affidare a te, come esperto economista e diligente amministratore, le loro proprietà: ebbene, non daresti forse prova di essere per loro una vera sciagura e non faresti forse una figura ridicola? [II,VI,39] Invece, mio caro Critobulo, la via più spiccia, la via più sicura e quella migliore in assoluto, per realizzare qualunque impresa nella quale tu voglia mostrati uomo di valore, è questa: sforzarti di diventare un uomo dabbene. Quelle che tra gli uomini sono chiamate virtù, se le analizzi a fondo, troverai che tutte diventano rigogliose per via dell’apprendimento e del costante esercizio. Io dunque, Critobulo, credo che questo sia il modo in cui noi dobbiamo cacciare. Se tu poi conosci qualche altro modo, spiegamelo”. “Caro Socrate”, gli rispose Critobulo, “io mi vergognerei se contestassi queste tue parole; giacché non saprei pronunciarne altre altrettanto nobili e vere”.
[II,VII,1] Quanto poi alle angustie degli amici, Socrate cercava di porre rimedio col ragionamento a quelle che dipendevano dall’ignoranza; mentre a quelle causate dall’indigenza, insegnando loro come aiutarsi vicendevolmente nel miglior modo possibile. Anche su queste vicende riferirò ciò che appresi da lui. Infatti una volta, vedendo Aristarco tutto accigliato, Socrate gli disse: “Aristarco, mi sembra che tu ti stia portando dentro un gran peso. È opportuno che questo peso tu lo spartisca con gli amici, e forse noi potremmo alleggerirtelo un poco”. [II,VII,2] “In tutta verità, caro Socrate”, gli rispose Aristarco, “io mi trovo davvero in grandi angustie. Infatti, dopo che in città c’è stata la guerra civile e moltissimi cittadini sono sfollati al Pireo, hanno trovato rifugio da me tutte quante le sorelle, le nipoti e le cugine che mi erano rimaste: sicché io ora mi ritrovo in casa ben quattordici persone di condizione libera. Non ricaviamo nulla dalla nostra terra, perché di essa si sono impossessati quelli della fazione avversa; né ricaviamo qualcosa dalle abitazioni che possediamo, giacché vi è scarsezza di popolazione. Mobili e suppellettili nessuno li compra, e da nessuna parte è possibile trovare del denaro in prestito. Anzi, a me pare che si raccatterebbe prima del denaro cercandolo per terra sulla strada, che trovarlo cercando di ottenere un prestito. Pertanto è davvero esasperante il vedersi circondato da familiari in totale rovina, e nella impossibilità, in simili circostanze, di dar da mangiare a un così gran numero di persone”. [II,VII,3] Udite queste parole, Socrate allora gli chiese: “Cos’è a far sì che Ceramone, il quale dà da mangiare a molti, abbia la capacità di procurare tutte le provviste necessarie non soltanto a se stesso ma anche a costoro, riuscendo inoltre a mettere da parte tanto denaro da essere ricco; mentre tu invece, che pure dai da mangiare a molti, hai il timore che andiate in rovina tutti quanti per mancanza delle necessarie provviste?” “Ma per Zeus”, gli rispose Aristarco, “è perché lui dà da mangiare a degli schiavi, mentre io do da mangiare a delle persone di condizione libera”. [II,VII,4] “E secondo te”, gli chiese Socrate, “quali dei due gruppi ritieni tu che sia il migliore: quello delle persone di condizione libera o quello delle persone schiave?” “Io credo”, rispose Aristarco, “che sia quello delle persone di condizione libera che stanno da me” “E allora”, continuò Socrate, “non è vergognoso che Ceramone derivi la sua prosperità dal lavoro dei più malvagi, e che tu invece sia in angustie avendo con te delle persone molto migliori?” “Sì, per Zeus, ma quello”, fece notare Aristarco, “dà da mangiare a degli artigiani; io invece do da mangiare a delle persone che hanno avuto una educazione liberale!” [II,VII,5] “E gli artigiani sono persone”, chiese Socrate, “che hanno appreso l’arte di produrre qualcosa di proficuo?” “Senz’altro!” “E sono proficue le farine?” “Lo sono moltissimo” “E i pani?” “Non certo di meno” “E allora? I vestiti da uomo e da donna”, insistette Socrate, “le toghe, le tuniche, le mantelline, le canotte?” “Anche queste sono tutte proficue al massimo grado!” “E quindi quelli che stanno in casa tua non sanno fare neppure una di queste cose?” “A mio parere, essi le sanno fare tutte” [II,VII,6] “Dunque non sai che coi proventi di una sola di queste attività, cioè dalla macinatura delle farine, Nausicide non soltanto mantiene se stesso e dà da mangiare ai suoi familiari, ma oltre a ciò, alleva un gran numero di maiali e di buoi, sicché accumula tanto denaro che spesso si accolla la spesa per delle cerimonie riguardanti la città intera? Che Cirebo, dall’attività di panettiere, trae il sostentamento per tutta la sua numerosa famiglia e riesce a vivere nell’abbondanza? Che Demea di Collito, dalla confezione di mantelline, Menone da quella di sopravvesti, e la gran parte dei Megaresi da quella delle canotte ricavano di che mangiare?” “Sì, per Zeus, lo so”, rispose Aristarco, “ma costoro hanno al loro servizio uomini barbari che hanno comprato come schiavi, sicché possono costringerli a lavorare a loro piacimento. Io ho invece in casa persone di condizione libera e congeneri non barbari”. [II,VII,7] “E così”, gli rispose Socrate, “poiché si tratta di persone di condizione libera e di tuoi congeneri, credi tu che costoro debbano non fare altro che mangiare e dormire? Delle altre persone di condizione libera, vedi tu forse coloro che vivono a questo modo passarsela meglio, e le ritieni tu più felici, di quelle che si danno da fare in attività che esse conoscono bene essere proficue per vivere? Hai tu forse mai sentito dire che l’inerzia e l’incuria siano di gran giovamento agli uomini per imparare ciò che conviene loro conoscere bene; per ricordare ciò che abbiano imparato; per mantenere il corpo in buona salute e per renderlo più forte; per possedere e per salvaguardare tutto ciò che è proficuo per vivere: mentre il lavoro e la diligenza non sono a questo scopo di alcun giovamento? [II,VII,8] I lavori che tu dici essere ben conosciuti dalle tue congiunte, li hanno esse imparati come attività del tutto improficue per la vita, e che non avrebbero mai messo in opera; oppure, al contrario, come attività delle quali esse avrebbero continuato ad occuparsi anche nel futuro e dal cui impiego esse avrebbero tratto giovamento? In quale di questi due modi gli uomini diverrebbero più assennati? Rimanendo inerti, oppure dedicandosi a lavori proficui? E in che modo sarebbero più giusti? Lavorando per approvvigionarsi del necessario, oppure discutendone senza mettervi mano alcuna? [II,VII,9] Ma al giorno d’oggi, a parer mio, tu non vuoi affatto bene a quelle donne, ed esse non ne vogliono a te; dal momento che tu le ritieni dannose per te, e quelle ti vedono adontato con loro. Da questo stato di cose, c’è pericolo che la loro avversione per te diventi man mano più grande, e che la loro precedente gratitudine diminuisca. Se tu, invece, patrocinerai con decisione il progetto di far loro intraprendere un’attività, tu vorrai loro davvero bene, vedendo che ti sono di giovamento; ed esse ti avranno davvero caro, accorgendosi che tu ti compiaci di loro. Così, ricordandovi con maggior piacere delle precedenti buone azioni, incrementerete la gratitudine legata a tali attività, e più amichevolmente e più familiarmente sarete disposti gli uni verso gli altri. [II,VII,10] Certo, se esse intraprendessero un lavoro vergognoso, la morte sarebbe per loro la scelta migliore. Invece, esse conoscono bene lavori che sono onorevolissimi e adattissimi, come sembra, per delle donne. E quei lavori che tutte le donne conoscono bene, esse li effettuano con la più grande facilità, rapidità, esattezza e piacere. Non peritarti, quindi, a far loro intraprendere dei lavori”, concluse Socrate, “che avvantaggeranno sia te che loro; ed esse verosimilmente ti daranno retta con piacere”. [II,VII,11] “Sì, per gli dei”, rispose Aristarco, “mi sembra proprio che tu, caro Socrate, stia dicendo delle cose davvero giuste. Il fatto è che io, in precedenza, non procedevo a chiedere del denaro in prestito, perché sapevo bene che una volta speso quello ottenuto, non avrei avuto modo di restituirlo. Adesso invece mi sembra di potermi permettere di farlo, così da procurare la materia prima necessaria per tali lavori”. [II,VII,12] In seguito a questa decisione fu fatta la provvista di denaro e fu comprata la lana necessaria. Dopo di che, le congiunte di Aristarco, fatta colazione si mettevano all’opera e cenavano al termine della giornata di lavoro. Erano diventate ilari invece che immusonite; invece di tenere gli occhi bassi, si guardavano l’un l’altra con piacere; volevano bene a lui in quanto loro tutore, e lui le aveva care perché gli giovavano. Per farla breve, Aristarco, venuto una volta a trovare Socrate, mentre gli narrava tutto ciò, pieno di allegria aggiunse pure che le sue congiunte che aveva in casa, ora lo accusavano di essere il solo che mangiasse a sbafo. [II,VII,13] Al che, Socrate gli chiese: “E perché non racconti loro la favola del cane? Si narra, infatti, che quando gli animali avevano la parola, la pecora disse al padrone: ‘Tu fai qualcosa di stupefacente, giacché a noi che ti procuriamo la lana, gli agnelli e il formaggio, non dai altro da mangiare che quanto prendiamo dalla terra; e invece col cane, il quale non ti procura nulla del genere, tu spartisci addirittura il tuo stesso cibo’. [II,VII,14] Udite queste parole, il cane disse: ‘Sì, per Zeus, sono io quello che salvaguarda in vita pure voi pecore, così che non siate rubate dagli uomini né rapite dai lupi. Giacché se io non vi facessi la guardia, voi neppure pascolare potreste, per paura di perire tutte quante in malo modo’. E si racconta che fu questo il motivo per cui le pecore accettarono che il cane fosse anteposto loro quanto ad importanza. Dunque”, continuò Socrate, “dì alle tue donne che al posto del cane, ci sei tu a fare la guardia ed a prendersi cura di loro; e che grazie a te esse possono vivere senza patire ingiustizie e lavorare in sicurezza e con piacere”.
[II,VIII,1] Una volta, vedendo dopo molto tempo un altro suo antico compagno, Socrate gli chiese: “E tu, Eutero, da dove spunti fuori?” “Socrate”, gli rispose Eutero, “è appena finita la guerra, ed io giungo qui proprio ora dal paese straniero in cui mi trovavo. E poiché mi sono stati confiscati tutti i possedimenti che avevo fuori dell’Attica, ed in Attica mio padre non mi ha lasciato padrone di alcunché; una volta tornato in patria mi trovo costretto a lavorare manualmente per procurarmi il necessario per vivere. A me pare che questa scelta sia migliore di quella di mendicare un aiuto dalla gente; e per un altro verso, non avendo io proprietà alcuna, mi è impossibile chiedere del denaro in prestito”. [II,VIII,2] “E per quanto tempo pensi”, gli domandò Socrate, “che ti basterà il lavoro manuale per ottenere una paga che ti fornisca il necessario per vivere?” “Per Zeus”, rispose Eutero, “non a lungo”. “Eppure, quando diventerai anziano, è manifesto che avrai bisogno di fare delle spese, e che però più nessuno vorrà pagarti per dei lavori di manovalanza”. [II,VIII,3] “Quel che dici, è vero”. “Dunque la cosa migliore è quella di impiegarsi immediatamente in quel genere di lavori che basteranno per vivere anche a chi è diventato anziano. Quindi si tratta di impiegarsi presso qualcuno di coloro che possiedono moltissime ricchezze, uno che ha bisogno di un collaboratore di fiducia che si prenda cura di esse, che soprintenda i lavori, raccolga gli interessi, faccia il custode del patrimonio: insomma, una persona che prestando il suo servizio ne riceva in cambio una paga”. [II,VIII,4] “Ma ben difficilmente, caro Socrate, io sopporterei una tale servitù”. “Eppure, coloro che governano gli Stati e si prendono cura degli affari pubblici, in seguito a questi incarichi non sono ritenuti persone servili ma persone più libere”. [II,VIII,5] “Socrate,”, ribadì Eutero, “io non mi adatto assolutamente ad essere oggetto della riprensione di qualcuno”. “Eppure, caro Eutero”, disse Socrate, “non è affatto facile trovare un lavoro facendo il quale uno non abbia qualche colpa. È infatti difficile effettuare qualcosa in modo da non errare; ed è anche difficile che chi fa qualcosa in modo irreprensibile, non si imbatta però in qualche giudice sconsiderato. Ed anche nel caso di coloro per i quali tu dici ora di lavorare, io mi meraviglierei che fosse facile passarsela senza rimproveri. [II,VIII,6] È pertanto d’uopo sforzarsi di rifuggire i colpevolisti, e seguire le tracce delle persone costumate. Quanto alle faccende che intraprendi, attieniti a quelle che puoi effettuare e guardati dall’effettuare quelle che non sei all’altezza di compiere. Qualunque cosa tu effettui, studiati poi sempre di effettuarla il meglio possibile, e impegnandoti in essa con piena convinzione. Operando in questo modo, io credo che tu non sarai oggetto di accuse, e soprattutto credo che tu troverai aiuto in momenti difficili, che la tua vita sarà più agevole e meno ricca di pericoli, e che sarà tale da non farti mancare alcunché fino alla tarda vecchiaia.
[II,IX,1] So che una volta Socrate sentì Critone sottolineare come il vivere ad Atene fosse esasperante per un uomo volenteroso di farsi i fatti suoi. “Infatti adesso”, diceva Critone, “taluni mi portano in tribunale, non perché io sia colpevole di qualche ingiustizia nei loro confronti, ma perché valutano che per me sia preferibile sborsare del denaro piuttosto che avere delle grane”. [II,IX,2] Pertanto, rivolgendosi a lui, Socrate gli chiese: “Dimmi un po’, Critone, mantieni tu dei cani, affinché essi ti tengano i lupi lontani dalle pecore?” “Senz’altro faccio così”, gli rispose Critone, “giacché mi è di maggior vantaggio il mantenerli che il non mantenerli”. “E dunque, non ti sarebbe di gran vantaggio anche il mantenere un uomo che voglia, e che sia capace di tenere lontani da te quanti armeggiano per commettere ingiustizie a tuo danno?” “A me farebbe molto piacere il farlo”, rispose Critone, “se fossi però sicuro che costui non mi si rivolta contro”. [II,IX,3] “E perché rivoltarsi contro di te? Non noti anche tu che è molto più piacevole giovarsi di un uomo come te, ingraziandoselo piuttosto che rendendoglisi odioso? E sappi che qui in città esistono uomini tali che riterrebbero un onore averti come amico”. [II,IX,4] Socrate e Critone rinvennero dunque uno di costoro in Archedemo. Archedemo era un oratore eccellente, capace negli affari, ma povero. Essendo una persona proba, egli infatti non era disposto a cavar denaro da chiunque, e sosteneva però che per lui era cosa facilissima mungere i sicofanti. Dunque, ogni volta che Critone ammassava del grano, oppure dell’olio, o del vino, o della lana, o qualcun’altro dei prodotti agricoli utili per la vita, ne dava una parte ad Archedemo; ed ogni volta che offriva un sacrificio agli dei, vi invitava anche Archedemo; e insomma si prendeva cura di lui in tutte le occasioni del genere. Ritenendo per se stesso un rifugio la casa di Critone, Archedemo prese così a dire un gran bene di lui. [II,IX,5] Quasi subito Archedemo rinvenne molte violazioni delle legge da parte dei sicofanti che accusavano Critone, e rinvenne anche molti loro nemici personali. Uno di questi sicofanti, egli lo faceva allora processare pubblicamente; e si trattava in genere di un processo nel quale si doveva giudicare se gli toccasse una pena corporale oppure il pagamento di una ammenda. [II,IX,6] Il sicofante, conscio com’era di avere sulle spalle molti e malvagi delitti, faceva allora di tutto per sbarazzarsi di Archedemo; ma Archedemo non mollava la presa su di lui fino a quando il sicofante non aveva ritirato l’accusa contro Critone, e non lo aveva risarcito con del denaro. [II,IX,7] Dopo avere mandato ad effetto questo e molti altri processi del genere; a quel punto ormai, come accade quando un pastore ha a disposizione un ottimo cane da guardia, anche gli altri pastori vogliono che le loro greggi stiano nei paraggi di quel pastore, per poter così usufruire della presenza di quel cane; molti degli amici di Critone solevano pregarlo di fornir loro Archedemo come guardiano. [II,IX,8] Ad Archedemo faceva molto piacere il far così cosa gradita a Critone, e che non soltanto Critone ma anche i suoi amici potessero vivere in pace. Se poi qualcuno di coloro ai quali Archedemo era odioso, gli rinfacciava di adulare Critone per l’utile che ne traeva, Archedemo rispondeva: “Ma è forse vergognoso l’essere beneficato da uomini probi e, ricambiandone i benefici, farsi amici uomini siffatti, distinguendosi così dai malvagi? O, piuttosto, vergognoso è il cercare di commettere ingiustizie contro gli uomini dabbene e farsene così dei nemici, e collaborando con i malvagi il farseli amici, servendosi dunque di costoro invece che di quelli?” Dopo di ciò, Archedemo fu il numero uno degli amici di Critone, ed era tenuto in grande onore anche dagli amici di Critone.
[II,X,1] Sono anche al corrente del fatto che Socrate ebbe con il suo intimo amico Diodoro una discussione su argomenti come i seguenti. “Dimmi un po’, Diodoro”, gli chiese Socrate, “se uno dei tuoi schiavi domestici fuggisse di nascosto, ti prendi tu cura di andarne alla ricerca per riaverlo sano e salvo?” [II,X,2] “Sì, per Zeus, e invito anche altri a farlo, spargendo la voce che offro una ricompensa, nel caso che egli ritorni da me sano e salvo”. “E nel caso”, continuò Socrate, “che uno dei tuoi schiavi domestici cada malato, ti prendi cura di lui e chiedi l’intervento dei medici, affinché egli non muoia?” “Assolutamente sì!” rispose Diodoro. “E se uno dei tuoi conoscenti, il quale ti è di certo molto più utile degli schiavi domestici, corre il pericolo di andare in malora a causa della sua mancanza di mezzi, non ritieni che abbia gran valore la tua sollecitudine di salvarlo? [II,X,3] Ebbene, tu sai che Ermogene non è un ingrato, ma un uomo che, quando ricevesse un favore da te, si vergognerebbe di non ricambiartelo. Ordunque, l’avere un inserviente volenteroso, benevolo e fedele; capace di effettuare ciò che gli viene comandato; e non soltanto ciò che gli viene comandato, ma capace di utili iniziative autonome, di prevedere, di decisioni ben ponderate in anticipo: ebbene, io credo che valga quanto molti schiavi domestici. [II,X,4] I buoni amministratori, qualora abbiano la possibilità di acquistare a poco prezzo qualcosa che è di gran valore, affermano che quello è il momento di comprare. E di questi tempi, a causa delle vicende militari e politiche, c’è la possibilità di acquistare ottimi amici a buon mercato”. [II,X,5] “Stai dicendo una cosa molto giusta, caro Socrate”, disse Diodoro, “ed avverti quindi Ermogene di venire da me”. “Per Zeus”, gli rispose Socrate, “non sarò certo io a fare una cosa del genere. Ritengo infatti che in questa faccenda, la cosa più corretta da farsi non sia il chiedere a lui, attraverso di me, di venire da te; ma che sia tu ad andare spontaneamente da lui; e che per lui non vi sia maggior bene del vedere la cosa definita da te personalmente”. [II,X,6] Pertanto Diodoro si recò da Ermogene; e senza una gran spesa si fece un amico, il cui lavoro era quello di esaminare con attenzione, sia in teoria che in pratica, tutto ciò che risultasse utile e gradito a Diodoro.
Libro III
Introduzione
Quelli che la tradizione ha raccolto sotto il generico nome di ‘Memorabilia’, ovvero di ‘Detti e fatti memorabili’, sono appunti disparati che Senofonte scrisse in tempi diversi e senza un ordine preciso. L’unico elemento che appare tenerli uniti è la presenza costante del personaggio ‘Socrate’, come visto ed interpretato da Senofonte.
Per comodità, io ho raccolto ciascun appunto in altrettanti paragrafi. Gli appunti che formano il Libro III sono in totale 24, e l’argomento di ciascuno di essi è il seguente.
Appunto 1 – [III,I,1-11] Socrate discute, con un suo giovane amico, della promessa del sofista Dionisodoro, appena giunto ad Atene, di insegnare l’arte di diventare Capo dell’Esercito.
Appunto 2 – [III,II,1-4] Socrate discute con una persona che è appena stata eletta alla carica di Generale dell’Esercito.
Appunto 3 – [III,III,1-15] Socrate discute con una persona che è appena stata eletta alla carica di Comandante della Cavalleria.
Appunto 4 – [III,IV,1-12] Socrate discute con Nicomachide sui diritti e sui doveri di un Comandante generale dell’Esercito.
Appunto 5 – [III,V,1-28] Socrate discute con Pericle, figlio del grande Pericle, il quale è appena stato eletto Comandante Generale dell’Esercito.
Appunto 6 – [III,VI,1-18] Socrate discute con Glaucone, fratello di Platone, il quale ha il chiodo fisso di diventare Capo del Governo dello Stato.
Appunto 7 – [III,VII,1-9] Socrate discute con Carmide, zio di Platone; ed avendo grande stima delle sue doti, lo sollecita ad interessarsi degli affari dello Stato.
Appunto 8 – [III,VIII,1-10] Socrate viene interrogato da Aristippo, su cosa siano il bene e il male.
Appunto 9 – [III,IX,1-15] Socrate discute, e risponde a numerose domande, sulle virtù e sui vizi.
Appunto 10 – [III,X,1-5] Socrate visita la bottega del pittore Parrasio.
Appunto 11 – [III,X,6-8] Socrate visita la bottega dello scultore Clitone.
Appunto 12 – [III,X,9-14] Socrate visita la bottega del produttore di corazze Pistia.
Appunto 13 – [III,XI,1-18] Socrate rende una celebre visita alla bellissima Teodota.
Appunto 14 – [III,XII,1-8] Socrate discute con l’amico Epigene, sull’utilità della ginnastica.
Appunto 15 – [III,XIII,1] Su chi si adira contro chi non gli ricambia il saluto.
Appunto 16 – [III,XIII,2] Su chi non prova piacere nel mangiare.
Appunto 17 – [III,XIII,3] Su chi si lamenta che l’acqua che beve è calda.
Appunto 18 – [III,XIII,4] Si chi punisce troppo severamente i servi.
Appunto 19 – [III,XIII,5] Su chi ha paura di non riuscire a camminare a piedi fino ad Olimpia.
Appunto 20 – [III,XIII,6] Su chi si sente sfinito dopo una lunga camminata.
Appunto 21 – [III,XIV,1] Sul comportamento dei partecipanti ad un banchetto
Appunto 22 – [III,XIV,2-4] Su chi mangia tante pietanze e poco pane
Appunto 23 – [III,XIV,5-6] Su chi mescola le pietanze che mangia
Appunto 24 – [III,XIV,7] Sul ‘trattarsi bene’ come sinonimo di ‘mangiare’.
Traduzione
[III,I,1] Ora narrerò come egli sapeva giovare a quanti aspiravano ad essere autori di opere gloriose, facendo sì che avessero esatta comprensione delle opere cui aspiravano.
Una volta, avendo sentito dire che Dionisodoro era giunto ad Atene, e che professava di insegnare l’arte di Capo dell’Esercito, Socrate parlò in questi termini ad uno dei suoi sodali, che in città era risaputo aspirare ad una simile carica. [III,I,2] “Giovanotto, sarebbe davvero una vergogna che chi vuole diventare Capo dell’Esercito di questa città, quando ha la potestà di imparare proprio quest’arte, invece se ne disinteressasse dal tutto. E senz’altro una persona simile meriterebbe di essere punito dalla città, ben più severamente di chi intraprendesse a fare statue senza avere mai imparato nulla dell’arte statuaria. [III,I,3] Infatti, nei tempi perigliosi della guerra, la sorte dell’intero Stato è nella mani del Capo dell’Esercito; ed è verosimile che ne conseguano beni grandiosi nel caso che agli ottenga dei successi, e invece mali terribili nel caso di suoi insuccessi. Dunque, colui che non si cura affatto di imparare l’arte e si preoccupa soltanto di farsi eleggere a questa carica, come potrebbe evitare una giusta e severa punizione?” [III,I,4] Dicendo queste parole, Socrate convinse il giovanotto a recarsi ad apprendere l’arte di Capo dell’Esercito. Quando questi tornò ammaestrato, Socrate prese a canzonarlo, dicendo: “Come Omero soleva dire di Agamennone che era maestoso d’aspetto; non pare anche a voi, signori, che costui, avendo ormai appresa l’arte di comandare l’Esercito, abbia già un aspetto molto più maestoso? Infatti, come chi ha imparato a suonare la cetra, è un citaredo anche quando non la suona; e chi ha appreso l’arte medica, continua ad essere un medico anche mentre non la sta esercitando, così pure costui, da questo momento in poi è un Capo di eserciti, pur se nessuno l’ha ancora eletto a quella carica. Chi invece manca del tutto di conoscenza dell’arte medica e di quella di comandare eserciti, è né un medico né un comandante; neppure qualora fosse designato tale dalla maggioranza assoluta degli uomini. [III,I,5] E tuttavia”, aggiunse Socrate, “se qualcuno di noi servisse sotto il tuo comando come capo-reggimento o capo-plotone, affinché noi si abbia una più esatta conoscenza delle tattiche di guerra, spiegaci trattando quali argomenti < Dionisodoro> abbia iniziato ad insegnarvi l’arte del comando”.
Al che il giovanotto rispose: “Dal principio alla fine egli ha trattato sempre la stessa cosa, spiegandomi null’altro che le manovre tattiche”.
[III,I,6] “Ma questa”, rispose Socrate, “non è che una piccolissima parte delle doti del Capo dell’esercito. Infatti, egli deve essere in grado di procurare le armi e gli equipaggiamenti indispensabili per la guerra, e di fornire le provviste necessarie al vettovagliamento dei soldati. Deve poi essere un uomo ingegnoso, industrioso, solerte, resistente, perspicace, amichevole ed insieme crudo, schietto ed insieme insidioso, guardingo e ladro, prodigo e rapace, incline ai doni e alla prevaricazione, sicuro quand’è sulla difensiva e audace nell’offensiva. Insomma, chi è Capo dell’esercito deve possedere molte diverse doti sia naturali che acquisite. [III,I,7] Anche la conoscenza delle manovre tattiche è comunque opportuna ed utile, giacché fa molta differenza che un esercito sia schierato in modo ordinato oppure in modo disordinato. Pietre, mattoni, travi di legno e tegole buttate lì alla rinfusa non sono, infatti, di utilità alcuna. Qualora, invece, questi materiali siano ben disposti: nella parte più bassa e in quella più alta i materiali che non marciscono e non vanno in disfacimento, ossia le pietre e le tegole; e frammezzo ad essi, invece, i mattoni e le travi di legno come nelle opere di costruzione; ecco che il tutto diventa un possesso di gran valore: come si trattasse di una casa”.
[III,I,8] “Socrate, la similitudine che hai appena usato”, disse il giovanotto, “è davvero perfetta. In guerra, infatti, le truppe migliori devono formare sia l’avanguardia che la retroguardia, mentre le truppe peggiori devono occupare il centro, così da essere trascinate dall’avanguardia e sospinte dalla retroguardia”.
[III,I,9] “A patto però”, aggiunse Socrate, “che egli ti abbia insegnato come si fa a vagliare quali siano i soldati migliori e quelli peggiori. Altrimenti di che pro ti sarebbe quanto hai imparato? Infatti, se < Dionisodoro> ti avesse ordinato di disporre il pagamento dell’avanguardia e della retroguardia con moneta buona e delle truppe al centro con moneta falsa, senza averti però insegnato come si distingue il denaro vero da quello falso, tutto ciò non ti sarebbe di alcun pro”.
“Ma per Zeus”, rispose il giovanotto, “questo non l’ha insegnato affatto. E per conseguenza dovremmo essere noi a saper distinguere i buoni dai cattivi soldati”.
[III,I,10] “E perché”, propose Socrate, “non prendere noi in considerazione il modo per non sbagliarci nel distinguere gli uni dagli altri?”
“Voglio proprio provarci”, rispose il giovanotto.
“Dunque”, cominciò Socrate, “se uno dovesse rapinare del denaro, noi non disporremmo correttamente nell’avanguardia i soldati più avidi di denaro?”
“A me pare proprio di sì”
“E cosa dire dei soldati che possono andare incontro a seri pericoli? Da disporre nell’avanguardia non sono quelli più ambiziosi di gloria e di notorietà?”
“Sì”, rispose il giovanotto, “questi sono i soldati pronti ad affrontare i pericoli, in cambio di promozioni e medaglie al valore. Costoro non se ne stanno nascosti, ma essendo ben visibili dappertutto sarebbero facili da scovare”.
[III,I,11] “Nondimeno”, chiese Socrate, “< Dionisodoro> ti ha insegnato soltanto la disposizione di una colonna, oppure anche dove e come impiegare ciascuna delle varie formazioni militari?”
“Di questo non ha proprio parlato”.
“Eppure sono molte le situazioni nelle quali è d’uopo né schierare né far muovere le formazioni militari allo stesso modo”.
“Ma per Zeus”, rispose il giovanotto, “queste cose non le ha chiarite affatto”.
“Per Zeus”, disse Socrate, “allora torna di nuovo da lui e interrogalo! Qualora, infatti, egli sia una persona coscienziosa e non uno spudorato, si vergognerà d’aver preso da te del denaro e di averti rimandato a casa a mani vuote”.
[III,II,1] In una certa occasione, imbattutosi in una persona che era stata eletta alla carica di Generale Comandante, Socrate gli chiese: “Per quale motivo ritieni che Omero si rivolga ad Agamennone chiamandolo ‘pastore di eserciti’? Secondo me perché, come un pastore deve prendersi ogni cura che le pecore siano al sicuro, che abbiano le provviste idonee, e che si ottenga da esse ciò per cui sono nutrite; così pure il Comandante Generale deve prendersi ogni cura che i soldati siano al sicuro, abbiano le provviste necessarie e che ottengano il risultato per il quale stanno conducendo la campagna militare. Ed essi combattono al fine di sconfiggere i nemici e di ottenerne così più prosperità e benessere. [III,II,2] Di poi, perché Omero loda Agamennone, dicendo che era
‘sovrano nobile e insieme poderoso guerriero’?
Secondo me, Agamennone è chiamato ‘poderoso guerriero’ non perché da sé solo combatta contro i nemici, ma perché è in ciò impegnato assieme all’esercito tutto. Di poi Omero lo chiama ‘nobile sovrano’, non perché egli ben provveda da sé solo alla propria vita; ma perché ben provvede alla vita di coloro di cui è re, e così è causa per essi di prosperità e benessere. [III,II,3] Un re, infatti, non si sceglie al fine che egli si prenda ogni cura di sé; bensì affinché, grazie a lui, i suoi sudditi possano vivere nel modo migliore possibile. E tutti i sudditi prendono parte alle campagne militari, affinché la loro vita sia la migliore possibile, e i capi militari a questo scopo sono scelti e diventano loro comandanti. [III,II,4] Bisogna dunque che chi ha la carica di Comandante Generale, a questo provveda per coloro che lo hanno eletto a questo incarico. Qualcos’altro più bello ed onorevole di questa pratica è difficile da trovare, né vi è qualcosa peggiore e più vergognoso del suo contrario”. Esaminando in questo modo quale sia la virtù propria del Capo Supremo, Socrate metteva da parte tutto il resto, e lasciava al primo posto il far sì che quanti costui governava fossero felici di godere prosperità e benessere.
[III,III,1] So per certo che una volta <Socrate> dialogava in questi termini con una persona che era stata eletta Capo della cavalleria.
“Giovanotto”, gli chiese Socrate, “potresti spiegarci per quale ragione smaniavi di diventare Capo della cavalleria? Non era di sicuro per guidare in prima fila la carica della cavalleria; giacché questo compito spetta agli arcieri a cavallo, i quali precedono nell’assalto anche i comandanti di cavalleria”.
“Stai dicendo la verità”, gli rispose il giovane.
“E neppure l’hai fatto per diventare famoso; giacché anche i pazzi sono conosciuti da tutti”.
“È vero anche questo”, assentì il giovane.
[III,III,2] “È forse perché ritieni di poter restituire allo Stato la cavalleria in condizioni migliori di quelle in cui l’hai ricevuta; e che se ci fosse necessità dell’impiego di cavalieri, essendo il loro Comandante, tu potresti diventare autore di un qualche bene per lo Stato?”
“Certamente, è questo lo scopo che mi muove”, rispose lui.
“Sì, per Zeus”, annuì Socrate, “è certo una cosa meravigliosa che ti riesca di fare qualcosa del genere! E il Comando per il quale sei stato scelto concerne di certo sia i cavalli che chi li monta”.
“Sì, è proprio così”.
[III,III,3] “Orsù, allora adesso spiegaci prima di tutto questo: cioè quale sia il modo in cui tu pensi di rendere migliori i cavalli”.
“Questo però”, gli rispose il giovanotto, “non è compito mio; ma spetta a ciascun cavaliere individualmente, il prendersi cura del proprio cavallo”.
[III,III,4] “Ma se dei tuoi cavalieri”, continuò Socrate, “alcuni ti si presenteranno dinnanzi con dei cavalli che hanno i piedi o le gambe in pessimo stato oppure deboli; altri, con cavalli che sono talmente denutriti da non riuscire neppure a tenere il passo; altri ancora, con cavalli talmente intrattabili da non riuscire a mantenere il posto in cui tu hai ordinato di disporli; altri ancora, talmente recalcitranti da rendere impossibile persino il farli entrare in formazione: di che pro ti sarà una simile cavalleria? E come ti sarà possibile, al comando di una cavalleria di questo genere, il fare qualcosa di buono per lo Stato?”
“Mi stai ponendo delle giuste domande”, rispose il giovane, “ed io farò ogni sforzo per prendermi ogni possibile cura dei cavalli”.
[III,III,5] “E poi? Non metterai mano”, gli chiese Socrate, “a migliorare capacità e qualità dei cavalieri?”
“Lo farò di certo”.
“Dunque, per prima cosa non farai sì che i cavalieri montino a cavallo con la massima agilità e sicurezza?”
“Bisogna davvero che lo faccia”, fu la risposta. “Giacché in questo modo, se qualcuno di loro cade da cavallo, avrebbe maggiori possibilità di salvarsi”.
[III,III,6] “E che? Qualora si debbano affrontare situazioni pericolose, comanderai di attirare i nemici su terreno sabbioso, che è quello sul quale voi abitualmente vi siete esercitati; oppure cercherai di far addestrare i tuoi uomini anche a combattere su terreni diversi e sui quali i nemici vivono?”
“Certo, questa seconda scelta è la migliore”.
[III,III,7] “E che? Avrai cura di far colpire e gettare a terra dai cavalli il maggior numero possibile di nemici?
“Farò anche questo, che è la cosa migliore da fare”
“Hai pensato a come infervorare gli animi dei cavalieri e come aizzarli contro i nemici, così da esaltarne l’aggressività?”
“Non ancora; ma adesso mi sforzerò sicuramente di farlo”.
[III,III,8] “Ti sei preoccupato di far sì che i tuoi cavalieri ti obbediscano? Senza questa assoluta obbedienza a te, di nessun pro sono i cavalli e i cavalieri, pur se eccellenti ed aggressivi”.
“Tu dici il vero”, rispose il giovanotto, “e tuttavia, caro Socrate, quale potrebbe essere il modo migliore per spronarli a questa obbedienza?
[III,III,9] “Tu sai bene che in qualunque faccenda, gli uomini sono disposti ad ubbidire soprattutto a coloro che essi ritengono dei veri esperti. Così, nel caso di una malattia, essi obbediscono di buon grado a colui che ritengono essere il medico più capace; durante un viaggio per mare, a colui che essi ritengono il nocchiero migliore; e in fatto di coltivazioni, a colui che è il più esperto di agricoltura”.
“È assolutamente così”.
“Pertanto è verosimile”, continuò Socrate, “che anche nel caso della cavalleria, colui che mostra di avere piena e completa conoscenza di cosa si deve fare, è a costui che gli altri cavalieri sono disposti ad ubbidire”.
[III,III,10] “Socrate, quindi se è manifesto che io”, rispose il giovanotto, “sono di gran lunga miglior cavaliere di tutti loro; ebbene, basterà questo a far sì che essi mi ubbidiscano?”
“Basterà”, fu la risposta di Socrate, “se oltre a ciò, spiegherai loro che l’obbedire ai tuoi ordini sarà per essi la scelta più onorevole e quella che li salvaguarda il più possibile dai pericoli”.
“E come farò a spiegarlo loro?”
“Ma spiegare questo”, sorrise Socrate, “per Zeus, ti sarà certo più facile che se dovessi spiegare loro che i mali sono migliori e più vantaggiosi dei beni”.
[III,III,11] “Mi stai dicendo”, chiese a questo punto il giovanotto, “che il Comandante della cavalleria, oltre ai compiti che già ha, deve anche essere capace di curarsi del modo in cui si esprime?”
“E tu ritenevi”, continuò Socrate, “che il Comandante della cavalleria dovesse svolgere i suoi compiti stando zitto? Non hai ben ponderato il fatto che tutte quante le conoscenze che abbiamo appreso essere di norma le migliori in assoluto, ed in armonia con le quali sappiamo vivere, le abbiamo tutte quante imparate attraverso il discorso ragionato; che se qualcuno impara qualche nozione di valore, la impara attraverso il discorso ragionato; e che coloro che meglio insegnano, utilizzano soprattutto il discorso ragionato; e che quanti hanno conoscenze più approfondite discutono meglio di chiunque altro? [III,III,12] Oppure non hai ben ponderato il fatto che con il coro formato unicamente da cittadini di questa città, come quello che viene inviato a Delo, nessuno proveniente da qualunque altro luogo osa competere; né mai si raccoglie insieme in qualche altra città un coro paragonabile per capacità e valore a quello di questa?”.
“Stai dicendo la verità”.
[III,III,13] “Invero, gli Ateniesi non differiscono granché dagli altri Greci, né per la stazza né per la vigoria del corpo, quanto invece per l’ambizione di onori e di gloria che essi nutrono, ambizione che acuisce il loro desiderio di imprese belle e che fanno onore”.
“Anche questo è vero”, assentì il giovanotto.
[III,III,14] “Dunque non pensi tu”, disse Socrate, “che se un Ateniese si prendesse cura della cavalleria come accade per il coro, essa diverrebbe ben superiore, in armi e cavalli, alle altre cavallerie: per la sua preparazione, per la sua disciplina, per la sua prontezza nell’affrontare i pericoli del combattimento contro i nemici, poiché gli Ateniesi riterranno che, così facendo, ne otterranno attestati di valore e gloria?”
“Sì, ciò è del tutto verosimile”
[III,III,15] “Quindi non peritarti”, concluse Socrate, “e sforzati di esortare i tuoi uomini al raggiungimento di questi risultati, dai quali trarrete giovamento tu, e gli altri cittadini grazie a te”.
“Sì, per Zeus, farò ogni sforzo in questo senso”.
[III,IV,1] Una volta, vedendo Nicomachide che si allontanava dai seggi elettorali, Socrate gli domandò: “Nicomachide, chi sono gli eletti alla carica di Comandante Generale?”
“Socrate”, gli rispose Nicomachide, “ma ti pare che gli Ateniesi possano essere gente con una testa diversa? Infatti, non hanno eletto me, che mi sono logorato prestando servizio, prima come soldato semplice, poi come capo-plotone, poi come capo-reggimento, e che ho un gran numero di ferite infertemi dai nemici, (e a questo punto si denudò e sfoggiò le cicatrici delle ferite). E invece hanno eletto Antistene, uno che non ha mai servito come oplita, che non ha mai combinato alcunché di notevole nella cavalleria, e che non sa fare altro che accumulare quattrini”.
[III,IV,2] “Ma se egli sarà capace”, gli rispose Socrate, “di provvedere ai soldati tutto ciò di cui essi han bisogno, non è questa un’ottima cosa?”
“Ma pure i mercanti”, gli ribatté Nicomachide, “sono capaci di accumulare denaro; ma non per questo potrebbero fare i Comandanti Generali”.
[III,IV,3] Al che Socrate rispose: “Ma Antistene ama anche moltissimo vincere: il che ben conviene attagliarsi ad un Comandante Generale. Non hai visto come tutte le volte che ha capeggiato un coro, il suo ha vinto su tutti gli altri?”
“Per Zeus”, disse Nicomachide, “ma non è affatto la stessa cosa dirigere un coro e dirigere un esercito”.
[III,IV,4] “E tuttavia Antistene”, continuò Socrate, “senza essere esperto di canto né maestro di cori, è stato ugualmente capace di trovare i migliori esperti in materia”.
“Quanto a questo”, disse Nicomachide, “anche nell’esercito egli troverà che altri sono coloro che danno gli ordini al posto suo, e altri sono quelli che combattono”.
[III,IV,5] “Quindi”, disse Socrate, “se egli sarà capace di trovare e di scegliere i migliori esperti di questioni militari e di guerra, come egli ha fatto con i cori; verosimilmente riporterà la vittoria anche in questa contesa. Ed è anche verosimile che egli preferirà spendere il suo denaro per una vittoria contro i nemici, vittoria che coinvolge l’intero Stato; piuttosto che spenderlo per una vittoria nei cori, che coinvolge soltanto la sua tribù”.
[III,IV,6] “Socrate mio”, disse Nicomachide, “tu stai sostenendo che l’uomo capace di essere vittorioso come Capo di un coro, è anche all’altezza di vincere una guerra come Comandante Generale?”
“Io sto affermando”, sottolineò Socrate, “che chiunque sia il Capo, se conoscerà le cose di cui c’è bisogno e sarà capace di provvederle, sarebbe un eccellente Capo, tanto di un coro quanto di una casa, di uno Stato o di un esercito”.
[III,IV,7] Nicomachide allora sbottò: “Socrate, non mi sarei mai aspettato da sentir dite da te, che i bravi padroni di casa sarebbero anche degli eccellenti Comandanti Generali”.
“Suvvia”, lo invitò Socrate, “facciamo un’accurata indagine delle opere di ciascuno di essi, al fine di appurare se esse siano le stesse, oppure se differiscano per qualcosa”.
“Facciamola pure”.
[III,IV,8] “Dunque”, cominciò Socrate, “non è un lavoro sia dell’uno che dell’altro, quello di fare in modo che i loro subordinati prestino orecchio e siano obbedienti ai loro comandi?”
“Assolutamente sì”,
“E inoltre, l’assegnare ciascun compito a chi è idoneo a svolgerlo?”
“Anche questo è vero”.
“Inoltre, io ritengo che ben si convenga ad entrambi il castigare i malvagi e il premiare i buoni”.
“Assolutamente sì”.
[III,IV,9] “E il far sì che i loro subordinati siano ben disposti nei loro confronti, come potrebbe non essere un bene per entrambi?”
“Anche questo è vero”.
“Attirare a sé cobelligeranti ed alleati, pare a te che sia utile ad entrambi, oppure no?”
“Assolutamente utile, sì”.
“Non conviene ad entrambi, essere attenti custodi delle loro cose?”
“Al massimo grado!”
“Quindi, non conviene ad entrambi essere solerti e laboriosi nelle opere loro?”
[III,IV,10] “Queste sono tutte cose che hanno la stessa natura per entrambi, ma”, protestò Nicomachide, “il combattere con le armi in pugno, non è appannaggio di entrambi”.
“Ma non accade che nascano dei nemici, sia per l’uno che per l’altro?”
“Sì, certo, anche questo sicuramente accade”.
“Dunque, l’avere il sopravvento sopra questi nemici, non è cosa comunque utile ad entrambi?
[III,IV,11] “Sono pienamente d’accordo su ciò; ma tu trascuri questa questione: se bisognerà combattere una guerra, di quale giovamento sarà l’economia?”
“Ti assicuro che l’economia”, rispose Socrate, “sarà del massimo giovamento. Infatti l’uomo d’affari, ben sapendo che nulla vi è di così vantaggioso e profittevole come la vittoria contro i nemici sul campo di battaglia, né alcunché di così svantaggioso e punitivo come la sconfitta, si darà da fare col massimo slancio per procurare tutti i denari utili per la vittoria; e prenderà in esame con ogni cura e starà bene in guardia dallo sprecare denaro in spese che potessero portare invece alla sconfitta. E il Comandante Generale si tiene ben pronto ad attaccare il nemico, se vede di essere sufficientemente preparato per vincerlo; ed evita assolutamente lo scontro con esso quando invece vede di non essere pronto a farlo. [III,IV,12] E tu, mio caro Nicomachide, non spregiare”, continuò Socrate, “gli uomini d’affari: Infatti la sollecitudine che si dedica al trattamento degli affari privati differisce da quella che si dedica al trattamento degli affari pubblici, soltanto per le quantità di denaro che sono in gioco, mentre per tutti gli altri aspetti essi sono similari. La somiglianza più grande è comunque questa: che né gli uni né gli altri possono avvenire senza il concorso di uomini; e che il trattamento degli affari privati e quello degli affari pubblici non è opera di due classi distinte di uomini. Infatti coloro che si interessano di affari pubblici non utilizzano a questo scopo uomini d’affari diversi da quelli che trattano affari privati. Pertanto coloro che sanno utilizzare entrambi hanno successo sia negli affari privati che in quelli pubblici, mentre coloro che non sanno utilizzare entrambi, sono e restano dei falliti”.
[III,V,1] Discorrendo con il Pericle figlio del grande Pericle, una volta Socrate gli disse: “Essendo tu adesso diventato Comandante Generale, io ho buona speranza che lo Stato sarà d’ora in poi molto meglio governato, che godrà di assai maggiore credibilità in fatto di guerra, e che riuscirà a sconfiggere e padroneggiare i suoi nemici”.
“Caro Socrate”, gli rispose Pericle, “io vorrei davvero che accadesse quel che stai dicendo; ma che le cose prenderanno davvero questa piega, non posso saperlo”.
“Vuoi dunque”, continuò Socrate, “che discutendone, noi si prenda in attento esame in che modo il ‘possibile’ può realizzarsi?”.
“Sono disposto a discuterne”,
[III,V,2] “Dunque tu sai che, per numero di abitanti, gli Ateniesi non sono da meno dei Beoti”.
“Lo so”, rispose Pericle.
“Tu pensi che gli individui di sana e robusta costituzione fisica siano stati arruolati in maggior numero tra i Beoti oppure tra gli Ateniesi?”
“A me pare” , rispose Pericle, “che, dei due Stati, neppure a questo riguardo ce ne sia uno che rimane dietro l’altro”.
“E degli abitanti di ciascuno Stato”, chiese Socrate, “quali ritieni che siano più amichevolmente disposti tra di loro?”
“Io penso”, disse Pericle, ”che i più amichevolmente disposti tra di loro siano gli Ateniesi. Giacché molti abitanti della Beozia sono trattati con superiorità e disprezzo dai Tebani, e per questo motivo essi provano avversione e ostilità verso di loro. Invece, tra gli Ateniesi io vedo non accadere nulla del genere”.
[III,V,3] “Eppure gli Ateniesi sono i più ambiziosi di gloria e i più d’alto sentire tra tutti gli uomini: il che li incentiva non poco a correre, in difesa della patria, gravi pericoli, purché ciò procuri loro gloria”.
“Né gli Ateniesi”, commentò Pericle, “sono da biasimare per questi atti di eroismo”.
“Senza dimenticare”, continuò Socrate, “che non ci sono nobili opere ed imprese, più grandi e più numerose di quelle che sono state lasciate in eredità agli Ateniesi, e a nessun altro popolo, dai loro avi. Fatto dal quale molti si sentono esaltati e spronati a darsi cura della virtù, e a diventare uomini valorosi”.
[III,V,4] “Tutte le cose che stai dicendo”, caro Socrate, “sono pura verità. Eppure tu vedi bene che da quando avvennero: a Lebadea la disgraziata sconfitta dei mille capeggiati da Tolmide; e a Delio quella dell’esercito comandato da Ippocrate; ebbene, da quel momento in poi la fama degli Ateniesi presso i Beoti è caduta assai in basso; mentre è andata crescendo l’animosità dei Tebani verso gli Ateniesi. Sicché i Beoti, i quali in precedenza non osavano, neppure sul loro territorio, affrontare militarmente gli Ateniesi senza l’aiuto degli Spartani e degli altri abitanti delle città del Peloponneso; ora minacciano di invadere l’Attica anche da soli. Al contrario gli Ateniesi, che in precedenza avevano saccheggiato la Beozia, hanno adesso il timore che i Beoti possano devastare l’Attica”.
[III,V,5] “Mi rendo conto”, disse Socrate, “che le cose stanno in questi termini; e però a sembra che la nostra città sia oggi molto meglio disposta di prima, ad accettare come Comandante qualcuno che sia anche un uomo per bene. Infatti, l’eccessiva fiducia in sé ingenera trascuratezza, pigrizia e disobbedienza; mentre invece la paura rende gli uomini più attenti, più disponibili all’obbedienza, più disciplinati. [III,V,6] Potresti avere una chiara prova di ciò, se pensi a dei marinai in navigazione. Finché essi non hanno alcuna paura, tutto sulla nave è in disordine. Ma non appena siano preda del timore di una tempesta o dell’avvinarsi di navi nemiche, essi non soltanto eseguono tutti gli ordini che avevano trascurato, ma tacciono in attesa dei comandi che riceveranno, come fanno i cantanti di un coro”.
[III,V,7] “Certo”, rispose Pericle, “se al giorno d’oggi gli Ateniesi ubbidissero davvero, allora sarebbe giunta l’ora di chiederci come potremmo spronarli a rinnamorarsi dell’antica virtù, della gloria e della felicità”.
[III,V,8] “Ebbene”, gli rispose Socrate, “se noi volessimo che gli Ateniesi pretendano per sé del denaro di cui altri Greci sono in possesso, li spingeremmo ad impadronirsene soprattutto col dimostrare loro che tali ricchezze erano dei loro padri, e che quindi sono di loro appartenenza. E poiché noi vogliamo che gli Ateniesi si dedichino a primeggiare per valore e nobiltà d’animo; questo, a sua volta, è da ottenersi con il dimostrare che tale virtù si confà loro sin dai tempi più antichi; e che dandosi continua cura di essa, gli Ateniesi diventerebbero i più potenti di tutti i Greci”.
[III,V,9] “E come potremmo spiegare ciò agli Ateniesi?”
“Io credo che ci riusciremmo, se ricordassimo loro chi erano i più antichi progenitori dei quali noi abbiamo sentito parlare, e che anche gli Ateniesi hanno già sentito dire che erano uomini con il più nobile degli animi”.
[III,V,10] “Ti riferisci al giudizio degli dei, il cui verdetto essi pronunciarono dinnanzi a Cecrope, a causa della sua virtù?”
“Sì, mi riferisco a loro; ed anche alla nascita e all’allattamento di Eretteo; alla guerra combattuta a quel tempo contro di lui da parte di tutti i confinanti; alla guerra dei figli di Eracle contro gli abitanti del Peloponneso; a tutte le guerre combattute ai tempi di Teseo, tempi nei quali è manifesto che i progenitori degli Ateniesi eccelsero per atti di valore su tutti gli uomini del loro tempo. [III,V,11] E se vuoi, mi riferisco anche alle imprese che successivamente compirono i loro discendenti, nati non molto tempo prima di noi; imprese, alcune delle quali essi conclusero da soli, contro coloro che erano padroni di tutta l’Asia e dell’Europa fino alla Macedonia: che avevano un potere e che detenevano risorse come nessun altro al mondo, che avevano fatto edificare costruzioni immense. E mi riferisco anche alle eccelse imprese che noi abbiamo compiuto insieme ai popoli del Peloponneso, sia per terra che per mare. E si parla di questi Ateniesi come di persone che eccellevano per valore su tutti gli uomini dei loro tempi”.
“Effettivamente”, rispose Pericle, “così si parla di loro”.
[III,V,12] “Perciò, pur essendo avvenute in Grecia molte migrazioni, gli Ateniesi rimasero stabilmente sulla loro terra. Molti si rivolsero a loro per risolvere delle controversie legali; e molti altri ancora, che erano oggetto di angherie brutali da parte di popoli più potenti, trovavano rifugio presso di loro”.
[III,V,13] Pericle allora disse: “Socrate, io mi stupisco di come il nostro Stato abbia potuto prendere questa piega decisamente verso il peggio”.
“Io penso”, gli rispose Socrate, “che, come alcuni atleti, a causa dell’essere nettamente superiori agli altri, impigriscono e diventano inferiori ai loro competitori; allo stesso modo è accaduto che gli Ateniesi, essendo di molto superiori agli altri popoli, hanno trascurato se stessi e così sono diventati peggiori”.
[III,V,14] “Ordunque”, gli chiese allora Pericle, “facendo che cosa, noi potremmo riprenderci l’antica virtù?”
“A me, questa non sembra affatto”, gli rispose Socrate, “una faccenda misteriosa. Infatti gli Ateniesi, riscoprendo il modo di agire dei loro avi e non facendo peggio di loro, ecco che neppure diventerebbero peggiori di quelli. Altrimenti, basta che essi imitino i modi di agire di coloro che adesso primeggiano tra i Greci; e, agendo come quelli, per certo non sarebbero peggiori di loro; anzi, se li praticassero con ancor più cura, forse sarebbero anche migliori di loro”.
[III,V,15] “Tu stai dicendo”, gli rispose Pericle, “che la nobiltà d’animo se ne sta da qualche parte ben lontana dalla nostra città. Infatti, quando mai gli Ateniesi hanno rispetto, come invece hanno gli Spartani, per le persone più anziane? Proprio gli Ateniesi, che anzi iniziano a mostrare disprezzo per gli anziani già a cominciare dai loro padri? Oppure che fanno esercizi ginnici nelle palestre, come invece fanno gli Spartani; ed evitando di farli, trascurano del tutto la buona forma fisica; ed anzi irridono coloro che se ne curano? [III,V,16] Quando mai gli Ateniesi obbediscono ai loro comandanti: proprio loro, che si compiacciono piuttosto di disprezzare coloro che comandano? Quando mai essi vanno d’accordo gli uni con gli altri: proprio loro che invece di collaborare per la comune utilità, si calunniano a vicenda e sono gonfi di invidie reciproche, più che di invidia verso tutti gli altri uomini? Che litigano nelle riunioni sia private che pubbliche più di tutti gli altri Greci? Che si muovono l’un l’altro moltissime accuse che poi diventano denunce nei tribunali? Che prescelgono di ricavare dei quattrini l’uno dall’altro, piuttosto che di giovarsi reciprocamente? Che considerano gli affari pubblici come cose altrui che non li riguardano, e circa le quali tuttavia di nuovo litigano, e si rallegrano moltissimo di avere la facoltà di mettere becco su di essi? [III,V,17] Da tutto ciò si ingenerano nello Stato gravi danni, molte inimicizie personali, odio reciproco tra i cittadini; tutte cose a causa delle quali, io sempre temo molto che accada ad Atene un qualche male più grande di quello che la città può sopportare”.
[III,V,18] “No, no, Pericle”, gli disse Socrate, “non ritenere che gli Ateniesi siano ammalati di una malvagità tanto incurabile. Non vedi come essi siano disciplinati in tutte le operazioni che riguardano la flotta; quanto disciplinatamente essi accettino i verdetti degli arbitri nelle gare atletiche; ed eseguano alla perfezione, come nessun altro dei Greci, tutto ciò che i maestri del coro insegnano loro a fare?”
[III,V,19] “Certo, questo è vero”, gli rispose Pericle, “ma stupefacente è il fatto che gli Ateniesi citati da te siano obbedienti a chi li comanda; e che invece gli opliti e i cavalieri, i quali per coraggio e per valore hanno la fama di essere delle truppe scelte, siano i più disobbedienti di tutti i cittadini”.
[III,V,20] Al che Socrate gli chiese: “Pericle, ma il Consiglio dell’Areopago non consta tutto di membri giudicati sceltissimi?”
“Sì, assolutamente sceltissimi”.
“Dunque conosci tu”, continuò Socrate, “tra coloro che amministrano la giustizia e che svolgono tutte le altre funzioni, qualcuno che sia migliore, più obbediente alla legge, più solenne e più giusto dei membri dell’Areopago?”
“Io non biasimo nessuno di costoro”.
“Pertanto non devi perdere fiducia negli Ateniesi, come se si trattasse di gente tutta indisciplinata”.
[III,V,21] “Eppure, nelle faccende militari”, insistette Pericle, “nelle quali soprattutto bisogna essere assennati, ben disciplinati e obbedienti agli ordini; ebbene, a nessuna di queste cose gli Ateniesi prestano attenzione”.
“Forse, il motivo di ciò è che a comandarli”, gli rispose Socrate, “sono degli ufficiali che ne sanno ben poco. Non vedi che nessuno si azzarda a dare dei comandi a coloro che suonano la certa, ai coristi o ai danzatori, se non è un perfetto conoscitore di quelle arti; e neppure ai lottatori o ai pancraziasti? Tutti i maestri di queste discipline sono in grado di dimostrare donde abbiano imparato l’arte alla quale soprintendono, mentre invece la maggior parte dei nostri Comandanti generali sono dei semplici improvvisatori. [III,V,22] Io reputo che tu non sia uno di costoro, e credo anzi che tu sia senza dubbio in grado di dimostrare donde hai cominciato ad apprendere l’arte di Comandante Generale, o quella di lottatore. Ritengo anche che molti dei princìpi di Strategia militare tu li abbia appresi da tuo padre, come pure li abbia messi insieme da ogni sorta di insegnamento occasionale, qualunque fosse la circostanza che ti permetteva di imparare qualcosa di giovevole al ruolo di Comandante Generale. [III,V,23] Credo inoltre che tu ti dia molto da fare affinché non ti sfugga la conoscenza di nozioni utili alla strategia militare; e che qualora tu ti renda conto di non sapere qualcosa, tu vada in cerca di coloro che queste cose le sanno, non risparmiando né donativi né ringraziamenti al fine di imparare da essi quello che non sai, e al fine di avere dei valenti collaboratori”.
[III,V,24] E Pericle gli rispose: “Mio caro Socrate, non mi sfugge che quel che dici, lo stai dicendo non perché tu ritenga che io stia davvero studiando queste materie, ma perché ti sforzi di insegnarmi che chi intende diventare Comandante Generale deve studiare con cura tutto ciò; e lo ammetto senz’altro anch’io”.
[III,V,25] “E tu, caro Pericle, ti sei già reso conto che le frontiere dell’Attica sono protette da una cintura di montagne altissime che si estendono fino alla Beozia, e grazie alle quali le vie di entrata sul nostro territorio sono strette e ripide? E sai anche che la parte centrale dell’Attica è cinta da piazzeforti montuose?”
“Sì, lo so benissimo”.
[III,V,26] “E dunque? Hai sentito dire che, nel territorio del Gran Re, i Misi e i Pisidi, mantenendo il controllo di posizioni montuose fortificate, anche se armati alla leggera, sono in grado di scendere rapidamente in pianura e di fare scorrerie sul territorio del Gran Re, pur continuando a vivere come uomini liberi?”
[III,V,27] “Anche questo l’ho sentito dire”.
“Non pensi tu”, continuò Socrate, “che degli agili e giovani Ateniesi, armati con armi leggere e tenendo il controllo dei passi montuosi che proteggono il nostro territorio, siano una spina nel fianco dei nostri nemici, e che rappresentino per i cittadini dell’Attica una potente difesa?”
“Io sono il primo a credere”, rispose Pericle, “che queste siano misure di grande utilità”.
[III,V,28] “Se pertanto, misure come queste sono di tuo gradimento”, concluse Socrate, “datti da fare per metterle in pratica, o mio ottimo amico. Ciascuna di quelle che farai effettuare, diventerà per te un motivo di lode ed un bene per lo Stato. E se ti risulterà impossibile farne realizzare qualcuna, non danneggerai la città, né ciò sarà per te causa di vergogna”.
[III,VI,1] Glaucone, figlio di Aristone, non aveva ancora vent’anni, ma aveva già il chiodo fisso di diventare Capo del Governo dello Stato. Nessuno dei suoi familiari né dei suoi amici riusciva a fargli cambiare idea, pur tirandolo giù ogni volta, a forza, dalla tribuna e coprendolo di scherno. Socrate fu l’unico, per via dell’amicizia con Carmide, zio di Glaucone; e con Platone, fratello di Glaucone, che riuscì a fargli cambiare idea.
[III,VI,2] Infatti, imbattutosi una volta in lui, sulle prime, per fargli attaccare discorso, lo trattenne dicendogli così: “Caro Glaucone, sei tu che hai concepito l’idea di diventare il Capo di Governo del nostro Stato?”
“Sì”, gli rispose Glaucone, “sono proprio io!”
“Sì, per Zeus”, gli disse allora Socrate, “la tua è un’idea bellissima, se mai ne esiste qualcun’altra ancora migliore tra gli uomini. Infatti, è manifesto che se tu riuscirai a metterla in pratica, sarai in grado di ottenere qualunque cosa tu voglia; capace di giovare ai tuoi amici; innalzerai fino al cielo il prestigio della casata di tuo padre; accrescerai la ricchezza della tua patria; diventerai un cittadino rinomato dapprima in Atene, poi nella Grecia intera, forse all’altezza di un Temistocle, e poi anche tra i barbari; e dovunque tu sarai, sarai dappertutto considerato una celebrità”.
[III,VI,3] Udendo queste parole, a Glaucone pareva di toccare il cielo con un dito, e quindi rimase ben volentieri in compagnia di Socrate.
Allora Socrate gli disse: “Glaucone, non è dunque manifesto che se vuoi essere tenuto in onore, ti tocca fare cose che giovino alla tua città?”
“Assolutamente manifesto, sì” rispose Glaucone.
“In nome degli dei”, lo implorò allora Socrate, “dunque non tenerci all’oscuro, e dicci da cosa comincerai per coprire di benefici lo Stato”.
[III,VI,4] Poiché Glaucone continuava a tacere, come se stesse considerando da cosa cominciare, Socrate lo incoraggiò dicendogli: “Per esempio, se tu decidessi di accrescere il prestigio della casata di un amico, certo faresti di tutto per farla diventare più ricca. Allo stesso modo, non ti sforzerai di far diventare più ricco il nostro Stato?”
“Sì, certo; farei proprio così”
[III,VI,5] “Ebbene, il nostro Stato non sarebbe più ricco se aumentassero le sue entrate?”
“Verosimilmente sì” rispose Glaucone.
“Adesso dimmi:”, continuò Socrate, “al giorno d’oggi donde provengono ed a quanto ammontano le entrate dello Stato? Senza dubbio tu hai analizzato la faccenda, al fine di accrescere le entrate, qualora esse fossero insufficienti, e di procacciarne per lo Stato di nuove, se l’incasso di qualcuna di esse risultasse non avvenuto”.
“Ma per Zeus”, protestò Glaucone, “io queste cose non le ho prese neppure in considerazione”.
[III,VI,6] “Ma se hai tralasciato di considerare le entrate dello Stato”, continuò Socrate, “parlaci allora delle sue uscite. Circa le spese dello Stato tu pensi, senza dubbio, di eliminare quelle superflue”.
“Ma per Zeus”, ribatté Glaucone, “io non ho passato il mio tempo a considerare queste bazzecole”.
“Dunque”, concluse Socrate, “soprassediamo pure sul progetto di rendere lo Stato più ricco. Com’è infatti possibile che si dia cura di spese ed entrate dello Stato, chi neppure sa cosa esse siano?”.
[III,VI,7] “Ma Socrate caro”, ridacchiò Glaucone, “lo Stato si può rendere ricco anche sconfiggendo e sottomettendo dei nemici”.
“Sì, per Zeus”, rispose Socrate, “addirittura ricchissimo, se sarà più forte dei suoi nemici. Ma se uno Stato è più debole dei suoi nemici, potrebbe perdere anche quel che ha”.
“Dici il vero”, gli rispose Glaucone.
[III,VI,8] “Pertanto”, continuò Socrate, “chi parteciperà al Consiglio nel quale si decide contro chi fare la guerra, deve conoscere alla perfezione quale sia la potenza militare del proprio Stato, e quale sia la potenza militare del nemico che ha davanti. Al fine di consigliare di prendere l’iniziativa di una guerra, se la forza militare del proprio Stato è prevalente; e invece di persuadere ad essere cauti, qualora appaia prevalente la potenza militare di chi ci si trova davanti”.
“Stai parlando rettamente”, rispose Glaucone.
[III,VI,9] “Dunque, per prima cosa”, disse Socrate, “spiegaci quale sia l’entità delle nostre truppe di terra e quale sia l’entità della nostra flotta, e poi quale sia quella dei nostri nemici”.
“Ma per Zeus, non saprei davvero riferirti questi numeri, così a memoria”.
“Se te li sei scritti da qualche parte, tirali pure fuori. Io proverei un grandissimo piacere nel sentire da te quali siano”.
“Ma per Zeus, io non me li sono scritti da nessuna parte”.
[III,VI,10] “Pertanto”, concluse Socrate, “sulle prime, ci asterremo anche dal dare consigli circa una eventuale guerra. Ed è forse a causa della enormità di questi problemi, e del fatto che hai da poco assunto la carica di Capo del governo, che non hai ancora avuto il tempo di indagarli. Io so tuttavia per certo, che ti sei interessato alla protezione delle frontiere dello Stato; che sai quante sono le guarnigioni in pieno assetto di difesa per questo scopo, e quante quelle che non lo sono; quante guardie sono sufficientemente armate e quante non lo sono; e che tu consiglierai di ingrandire le guarnigioni efficienti e di eliminare quelle superflue”.
[III,VI,11] “Sì, per Zeus”, rispose Glaucone, “io consiglierò piuttosto di eliminarle tutte quante, perché esse difendono talmente bene i nostri confini, che tutto quanto si produce nel nostro Stato viene rubato”.
“Ma se uno elimina le guarnigioni di frontiera”, obiettò Socrate, “non ritieni che chiunque lo voglia potrà sentirsi autorizzato a fare delle vere e proprie rapine? Nondimeno, sei andato tu in persona a fare questa indagine? Come fai a sapere che le nostre frontiere sono mal difese?”
“Io me lo immagino” rispose Glaucone.
“Dunque”, concluse Socrate, “anche su questa faccenda daremo il nostro consiglio quando non immagineremo soltanto, ma quando avremo la conoscenza certa di come stanno le cose?”
“Probabilmente”, assentì Glaucone, “questa è la miglior cosa da fare”.
[III,VI,12] “E per quanto concerne le miniere di argento”, chiese Socrate, “so con certezza che tu non sei arrivato fin là, sicché non puoi dire quale sia il motivo per cui da esse provengono oggi quantità di argento assai inferiori a quelle di prima’”.
“No, infatti non ci sono andato”.
“E sì, per Zeus; e ti capisco anche. Si racconta infatti”, spiegò Socrate, “che il luogo sia gravemente malsano; e che per chi debba dare un consiglio su tale argomento, questo è il pretesto che ti basterà come scusante”.
“Mi sento un po’ preso per i fondelli”, protestò Glaucone.
[III,VI,13] “Comunque c’è una faccenda”, continuò Socrate, “della quale sono sicuro che tu non ti sei disinteressato; e della quale, anzi, sei stato un attento analizzatore. Si tratta di quanto grano cresce nel territorio del nostro Stato, e quindi di sapere per quanto tempo esso sia in quantità sufficiente a nutrire tutti gli abitanti; e quindi anche di quanto grano c’è annualmente bisogno. Dico questo, affinché una improvvisa carestia che colpisca lo Stato, non ti trovi impreparato, ed affinché tu sappia consigliare le misure necessarie ed indispensabili per venire in soccorso dello Stato e salvarlo”.
“Tu stai parlando di un compito enorme”, disse Glaucone, “per chi dovrà studiare e prendersi cura anche di faccende di questo genere”.
[III,VI,14] “E tuttavia”, continuò Socrate, “nessuno sarà in grado di governare bene neppure la propria casa, se non sarà al corrente di tutto ciò di cui essa ha bisogno, e se non si curerà di rifornirla di tutto il necessario. E poiché il nostro Stato consiste di oltre diecimila case, ed è assai difficoltoso prendersi cura di un così gran numero di abitazioni; perché non provi a far arricchire dapprima quella di tuo zio <Carmide>? Egli ne ha davvero bisogno. E se sarai capace di fare questo, potrai darti da fare per un numero più grande di case. Se infatti non sei capace di giovare ad una, come potresti essere di giovamento a molte? Se uno non può mettere sul piatto un talento, come può non essere evidente che egli neppure può provare a metterne sul piatto molti di più?”
[III,VI,15] “Ma io”, disse Glaucone, “aiuterei ben volentieri il casato di mio zio, se egli fosse disposto ad ubbidirmi!”
“E dunque tu ritieni”, gli rispose Socrate, “incapace come sei di convincere tuo zio a darti retta, di poter fare in modo che tutti gli Ateniesi, compreso tuo zio, ti ubbidiscano? [III,VI,16] Caro Glaucone, mentre tu smani di acquistare fama e di diventare celebre, bada bene di non ottenere il risultato opposto! Non ti rendi conto di quanto sia scivoloso il percorso di chi vuole parlare di, o effettuare, cose che non conosce? Pondera bene la sorte cui vanno incontro tutte quelle altre persone che tu sai essere gente di questo genere. Pare a te che le persone le quali fanno mostra di dire e di fare cose che non sanno, per questo motivo vadano incontro a lodi oppure a denigrazioni? E che ne ottengano d’essere ammirati oppure di essere spregiati? [III,VI,17] Pondera bene anche la sorte cui vanno incontro coloro che sanno quel che dicono e quel che fanno. Tu scoprirai, come io ritengo, che in qualunque attività, gli uomini che hanno miglior fama e che godono di generale ammirazione fanno sempre parte del gruppo di coloro che hanno le più vaste e sicure conoscenze; mentre gli uomini che godono di cattiva fama e che sono più spregiati, fanno sempre parte del gruppo degli ignoranti e degli incolti. [III,VI,18] Pertanto, se tu smani di diventare famoso e di essere ammirato da tutti i cittadini, trova il modo da avere il massimo possibile di conoscenze certe e approfondite, su ciò che ti proponi di fare. Infatti, se metterai mano alla carriera politica, avendo questa differenza rispetto agli altri; non mi stupirei che tu potessi assai facilmente ottenere i risultati che smani di conseguire.
[III,VII,1] Socrate vedeva in Carmide, figlio del vecchio Glaucone, un uomo rimarchevole e molto più capace dei politici di quel tempo. Carmide però si peritava di parlare pubblicamente al popolo riunito in assemblea, e di interessarsi di affari pubblici. Per questo motivo, Socrate una volta gli chiese: “Dimmi un po’ Carmide: se uno che ha tutte le doti necessarie e sufficienti per vincere i grandi Giochi; grazie a ciò, per essere coperto di onori, e per rendere così la sua patria la più famosa di tutte in Grecia; il quale, però a quei Giochi non volesse partecipare: che sorta di uomo riterresti essere una persona simile?”
“Manifestamente”, gli rispose Carmide, “quest’uomo è un mollaccione e un codardo”.
[III,VII,2] “Se un tale”, continuò Socrate, “interessandosi degli affari politici di uno Stato, è capace di renderlo più ricco, e grazie a ciò di essere egli stesso coperto di onori; e si perita però di farlo: costui non sarebbe considerato a buon diritto un codardo?”
“Forse è così”, assentì Carmide, “ma a che scopo mi fai questa domanda?”
“Te la faccio, perché credo che tu, capace come sei di prenderti cura degli affari politici dello Stato, invece te ne periti; proprio quando, al contrario, si tratta di affari politici alla deliberazione sui quali è necessario che tu partecipi, in quanto di questo Stato tu sei a tutti gli effetti un cittadino”.
[III,VII,3] “Ma questa capacità, in quale genere di mia attività l’hai vista all’opera, e quindi la riconosci come mia?”
“Nelle conversazioni alle quali sei presente”, rispose Socrate, “con i responsabili della politica dello Stato. Infatti, qualora essi ti mettano al corrente di qualcosa, ti vedo sempre offrire ottimi consigli, e qualora essi commettano qualche sbaglio, ti vedo sempre criticarli rettamente”.
[III,VII,4] “Socrate caro”, disse Carmide, “ non è mica la stessa cosa discutere in privato, oppure dibattere su qualcosa in piena assemblea”.
“Ma tuttavia chi è capace di discutere sulla base di solidi dati numerici”, obiettò Socrate, “è capace di farlo altrettanto bene sia da solo, che in mezzo ad una assemblea. Così pure, i citaristi bravissimi a suonare la cetra quando sono soli, la padroneggiano altrettanto bene anche se si trovano attorniati dalla folla”.
[III,VII,5] “Socrate, ma non vedi”, gli rispose Carmide, “come un certo ritegno e una certa paura siano ingenerati negli uomini, e come ritegno e paura stiano sempre accanto agli uomini molto di più quando essi sono davanti ad una folla, che in occasione di conversazioni private?”.
“Mi affretto a spiegarti il perché di ciò che penso, dicendoti che tu ti vergogni di parlare in assemblea non per il ritegno che hai davanti ai presenti più assennati, né per paura dei presenti più esagitati. [III,VII,6] Infatti, che modo puoi mai tu provare vergogna davanti a dei gualcherai, a dei calzolai, a dei falegnami, a dei fabbri, a degli agricoltori, a dei commercianti, a gente che traffica tutto il giorno al mercato e d’altro non si preoccupa che di comprare a poco prezzo e di rivendere a caro prezzo? L’assemblea è fatta tutta quanta di persone di questo genere. [III,VII,7] Perché, dunque, credi che ciò che fai sia diverso da ciò che fa chi è superiore ed è in grado di battere dei corridori bene allenati, ed invece ha paura di gente qualunque senza allenamento alcuno? Tu, inoltre, dialoghi con facilità con dei personaggi di primo piano dello Stato, taluni dei quali sono sprezzanti con te; e sei di molto superiore ai politici correnti nel discutere. E quando invece ti trovi davanti a persone che non si sono mai preoccupate di politica, e che di certo non ti hanno trattato con spregio, ti periti di parlare, temendo di essere da loro ridicolizzato”.
[III,VII,8] “Di che ti stupisci? Non ti pare”, obiettò Carmide, “che spesso i presenti all’assemblea mettano in ridicolo coloro che dicono cose giuste e sensate?”
“Ma questo lo fanno anche altri”, insistette Socrate, “ed io mi meraviglio di te, perché mentre hai facilmente la meglio su coloro che ti ridicolizzano al di fuori dell’assemblea, ritieni invece di non potere assolutamente tirare dalla tua parte i presenti in assemblea. [III,VII,9] Mio caro, non ignorare chi sei, e non commettere gli errori che la maggior parte degli uomini commette. Infatti i più, trascinati come sono a considerare i fatti altrui, non si volgono ad indagare i fatti loro propri. Dunque, non essere pigro a questo riguardo, ma sforzati di rivolgere ogni attenzione piuttosto a te stesso; e non trascurare gli affari di Stato, ove vi sia in esso qualcosa che grazie a te può essere migliorato. Infatti, se gli affari di Stato ricevono le cure loro dovute, tu sarai di giovamento non soltanto agli altri cittadini, ma anche ai tuoi amici, e non poco pure a te stesso”.
[III,VIII,1] Una volta Aristippo sottopose Socrate ad interrogatorio, così come in precedenza Socrate aveva sottoposto lui. Ora Socrate, volendo in qualche modo giovare ai sodali presenti, dette le sue risposte non come fanno coloro la cui unica preoccupazione è che il discorso non esca in qualche modo fuori dal seminato; ma come chi è convinto di fare il proprio dovere il meglio possibile.
[III,VIII,2] Aristippo, dunque, gli chiese se egli sapesse cos’è ‘bene’; per potergli così dimostrare, se egli avesse risposto che bene sono cose del tipo: cibo, bevande, denaro, salute, robustezza, audacia; che talvolta queste stesse cose sono ‘male’. Ora Socrate, sapendo che se qualcosa ci dà fastidio, abbiamo bisogno di un rimedio che faccia cessare il fastidio, rispose ad Aristippo in quel modo che fa l’uomo insuperabile.
[III,VIII,3] “Mi stai chiedendo se conosco un buon antipiretico?”
“No, non ti sto chiedendo questo”, rispose Aristippo.
“Se conosco un buon rimedio per il mal d’occhi?”
“Neppure questo”
“Allora un buon rimedio contro la fame?”
“Neanche per la fame”
“Ma allora, se tu mi chiedi se io conosca qualche bene che sia il bene di nulla, ti dirò”, gli rispose Socrate, “che questo bene io né lo conosco né sento il bisogno di conoscerlo”.
[III,VIII,4] Allora Aristippo lo interrogò di nuovo, chiedendogli se conoscesse qualcosa ‘bello’; e Socrate gli rispose: “Sì, cose belle ne conosco molte”.
“E dunque”, continuò Aristippo, “tutte sono simili una all’altra?”
“Al contrario”, rispose Socrate, “talune sono il più possibile dissimili una dall’altra”.
“E com’è possibile”, chiese Aristippo, “che una cosa bella sia dissimile dal ‘bello’ ?”
“Sì, è così, per Zeus”, continuò Socrate, “perché è possibile che un atleta bello per la lotta, sia dissimile da uno bello per la corsa; e si dà il caso che uno scudo bello per la difesa personale sia quant’altri mai dissimile da un giavellotto bello a viaggiare veloce e dotato di una grande forza”.
[III,VIII,5] “Non mi stai dicendo nulla di diverso da ciò che mi hai risposto quando ti interrogai chiedendoti se conoscessi qualcosa ‘buono’ ”
“Tu credi che una cosa sia il ‘buono’ e un’altra cosa il ‘bello’? Non sai che tutte le cose sono identicamente belle e buone? Infatti, in primo luogo, la virtù non è il ‘buono’ per alcune cose, e per altre cose il ‘bello’. In secondo luogo, gli uomini sono chiamati belli e buoni nello stesso modo e per le stesse cose. Anche i corpi degli uomini si mostrano belli e buoni in relazione alle stesse cose. E tutte le altre cose delle quali gli uomini si servono sono ritenute belle e buone, in relazione alla loro capacità di essere per essi profittevoli”.
[III,VIII,6] “Dunque, anche il pitale per gli escrementi è bello?”
“Sì, per Zeus”, rispose Socrate, “e uno scudo dorato è brutto; se il pitale è ben fatto per l’uso a cui serve, e lo scudo invece è mal fatto”.
“Tu stai dicendo che le stesse cose sono belle e brutte?”
[III,VIII,7] “Sì, io sto dicendo proprio questo”, continuò Socrate, “e che le stesse cose sono anche bene e male. Infatti, molte volte ciò che è bene per la fame, è male per la febbre; e ciò che è bene per la febbre è male per la fame. E spesso ciò che è bello per la corsa, è brutto per la lotta; e ciò che è bello per la lotta è brutto per la corsa. Infatti, tutte le cose sono buone e belle in relazione alle attività cui si adattano alla perfezione; mentre sono cattive e brutte in relazione a quelle cui mal s’adattano”.
[III,VIII,8] Quando Socrate diceva, a proposito di case, che la casa deve essere bella ed insieme funzionale; a me pareva che egli suggerisse ai presenti quali case è opportuno edificare.
Egli soleva infatti guardare alla sua costruzione in questo modo: “Chi è intenzionato ad avere una casa come si deve, non è forse opportuno che faccia in modo da poterci vivere dentro il più piacevolmente possibile, e che essa sia la più funzionale possibile?”
[III,VIII,9] Una volta trovato l’accordo di tutti, Socrate disse: “Dunque, non è forse piacevole che d’estate la casa sia fresca, e che sia tiepida d’inverno?”
Dopo che anche questo fu condiviso, Socrate continuò: “Dunque, nelle case che guardano verso sud, d’inverno il sole è basso sull’orizzonte e ne illumina i porticati, mentre d’estate il sole splende a picco su di noi e sui tetti, fornendoci così ombra per il nostro cammino. Pertanto, se è bello che gli eventi accadano in questo modo, è opportuno che le parti degli edifici rivolte verso sud siano più alte affinché il sole invernale possa illuminarle e non rimanere del tutto intercettato; e che siano più basse le parti degli edifici rivolte verso nord, affinché esse non siano colpite in pieno dai venti freddi che da lì provengono. [III,VIII,10] Riassumendo il tutto in breve, possiamo dire che il luogo in cui il proprietario possa rifugiarsi il più piacevolmente possibile tutte le stagioni dell’anno, e conservarvi tutti i suoi beni nel modo più sicuro: ebbene, questa verosimilmente sarebbe anche l’abitazione più piacevole e più bella di tutte. Quanto ai dipinti ed agli ornamenti vari, essi sottraggono più diletti di quanti ne procaccino.
Riguardo ai templi ed agli altari, Socrate soleva dire che il territorio che meglio si confà loro sarebbe quello il più aperto possibile alla vista, il più lontano dalla città e il meno frequentato possibile. Giacché chi li vede da lontano pronuncia con piacere parole beneauguranti, ed ha piacere di accostarsi loro con purezza rituale.
[III,IX,1] Successivamente, quando gli fu chiesto se la virilità possa essere insegnata, oppure se si tratti di una dote naturale, Socrate rispose: “Io credo che, come un corpo è per natura più resistente di un altro dinanzi alla fatica; così pure un animo è per natura più vigoroso di un altro, se si trova di fronte a dei cimenti terribili. Io vedo, infatti, che individui cresciuti obbedendo alle stesse leggi e condividendo gli stessi costumi, quanto ad audacia hanno comportamenti assai diversi uno dall’altro. [III,IX,2] Io ritengo, tuttavia, che la virilità innata di qualunque uomo possa essere accresciuta dall’apprendimento e dalla pratica costante. Infatti è risaputo che gli Sciti e i Traci non ardirebbero, se armati soltanto di scudi e di lance, affrontare un combattimento contro gli Spartani. Ed è chiaro che a loro volta gli Spartani, se armati soltanto di scudo leggero e di giavellotti, non sarebbero affatto disposti a competere contro i Traci; né, se armati soltanto di arco e frecce, contro gli Sciti. [III,IX,3] Io stesso ho quindi modo di vedere che, similmente, gli uomini differiscono per natura uno dall’altro anche per tutti gli altri riguardi, e che progrediscono di molto con una pratica costante. Da queste constatazioni deriva manifestamente che tutti gli uomini, sia i più dotati naturalmente, sia i meno dotati naturalmente, devono, nelle attività nelle quali intendono diventare rinomati, queste apprendere e praticare con costanza”.
[III,IX,4] Socrate non faceva una netta distinzione tra sapienza e temperanza; ed usava giudicare sapiente e al contempo temperante, colui che riconosceva ed usava tutto ciò che è bello e buono, e che sapeva come tenersi lontano da tutto ciò che è brutto. Quando una volta gli fu chiesto se ritenesse sapienti e padroni di sé, coloro che hanno scienza di ciò che si deve effettuare, e che però fanno il contrario, rispose: “Costoro sono nulla di più che persone insipienti e prive di padronanza di sé. Io reputo, infatti che, tra le azioni fattibili, tutti scelgono deliberatamente quelle che essi ritengono per loro le più convenienti, e queste effettuano. Io credo, quindi, che quanti operano non rettamente siano individui né sapienti né temperanti. [III,IX,5] Soleva poi aggiungere che la giustizia e tutte le altre forme di virtù, sono sapienza. Che tutte le azioni giuste e tutte quelle che si effettuano virtuosamente, sono azioni belle e buone. Che quanti sanno questa verità non sceglierebbero mai deliberatamente altro che queste azioni. Che quanti non ne hanno scienza non possono effettuarle; e che qualora vi mettessero mano, fallirebbero miseramente. Pertanto, i sapienti effettuano le azioni belle e buone, gli insipienti non possono effettuarle e qualora vi pongano mano, falliscono miseramente. Quindi, poiché tutte le azioni belle e buone sono azioni virtuose, è manifesto che anche la giustizia e tutte le altre virtù sono forme di sapienza. [III,IX,6] Socrate sosteneva che la pazzia è il contrario della sapienza, ma non riteneva pazzia l’assenza di conoscenze certe; o l’ignorare chi si è, oppure l’opinare di sapere ciò che invece uno non sa. Tutte queste cose, egli le computava non come pazzia, ma come cose che si avvicinavano moltissimo alla pazzia. Diceva quindi di negare che fossero pazzi i molti che ignorano ciò che la maggior parte degli uomini ignora, e coloro che su queste questioni si sono sbagliati; e di chiamare invece pazzi coloro che si sono sbagliati su faccende che la maggior parte degli uomini conosce bene. [III,IX,7] Per esempio: se uno ritiene di essere così grande e grosso da chinarsi quando esce dalle porte delle mura cittadine. Se uno si ritiene così forte che prova a sollevare delle case intere, oppure se si dedica a qualcun’altra di quelle imprese che sono manifestamente impossibili per chiunque. Ebbene, allora Socrate diceva che costoro erano pazzi. Egli diceva anche che quanti sbagliano su faccende di poco conto, ai più non sembrano pazzi; e che i più, come chiamano ‘potente smania’ la passione amorosa, così chiamano ‘grande confusione mentale’ la pazzia.
[III,IX,8] Considerando cosa fosse l’invidia, Socrate trovava che essa è una sorta di afflizione; afflizione la quale, tuttavia, non riguarda le sfortune degli amici o le fortune dei nemici. Egli sosteneva, infatti, che invidiosi sono soltanto coloro che provano fastidio per la prosperità degli amici. Poiché taluni si meravigliavano del fatto che esistesse qualcuno il quale si affliggeva per la prospera fortuna di un amico, Socrate soleva rammentare loro che molte persone sono disposte in modo tale da non poter evitare di badare a quanti se la passano male, e che quindi soccorrono sì gli sfortunati, ma poi si affliggono quando un colpo di fortuna ne fa cambiare la sorte. Tuttavia, aggiungeva che una cosa simile non accadrebbe mai ad un uomo saggio, mentre a sperimentarla sono sempre gli sciocchi.
[III,IX,9] Considerando cosa fosse l’essere padroni del proprio tempo, Socrate diceva di trovare che la maggior patte degli uomini qualcosa sta sempre facendo. Infatti, anche chi gioca a dadi, anche chi racconta barzellette, sta facendo qualcosa; ed egli diceva che tutti costoro sono padroni del proprio tempo, in quanto hanno la potestà di dedicarsi ad effettuare cose più nobili di quelle che stanno effettuando. Ma nessuno di coloro che passano da attività degne ad attività indegne, è più padrone del proprio tempo; e Socrate affermava che chi ciò effettuasse, e quindi non fosse più padrone del proprio tempo, faceva molto male a farlo.
[III,IX,10] Socrate spiegava, poi, che re e condottieri non sono coloro che hanno in mano degli scettri, né quanti sono stati scelti da chi capita, né quanti sono stati estratti a sorte, né quanti ottengono tali scettri con la violenza oppure con l’inganno; bensì coloro che conoscono l’arte di comandare. [III,IX,11] Infatti, una volta ammesso che il compito del comandante è quello di impartire gli ordini sul da farsi, e che il compito dei comandati è quello di ubbidire agli ordini; Socrate metteva in evidenza che, su una nave, chi conosce l’arte del comando, comanda; mentre il proprietario della nave, e tutto il resto dell’equipaggio, obbedisce a chi sa. Anche nel caso dell’agricoltura è così per i proprietari dei terreni; in caso di malattia per i malati; negli esercizi ginnici per i ginnasti; e in tutti gli altri casi per i quali ci sia bisogno di conoscenze specifiche e di attenta cura. Tutti coloro che ritengono di avere queste conoscenze specifiche e la cura necessaria, procedono da soli; ed altrimenti obbediscono agli esperti non solo quando questi sono presenti; ma li mandano a chiamare qualora siano assenti ed obbediscono loro, così da fare quel che si deve. Anche nel filare e lavorare la lana, Socrate diceva che sono le donne a comandare gli uomini, poiché esse sanno bene come trattarla, mentre gli uomini non lo sanno.
[III,IX,12] A chi affermasse che però è in potestà del tiranno il non obbedire ai comandanti che impartiscono corretti ordini sul da farsi, Socrate soleva rispondere: “E come potrebbe il tiranno non obbedire al giusto ordine di un comandante, visto che nella disobbedienza stessa ad un giusto ordine è già insita per chiunque la pena? Infatti, in seguito alla disobbedienza ad un giusto ordine, costui commetterà un grave errore, e quindi dovrà per forza pagarne le conseguenze”.
[III,IX,13] Ed a chi insisteva dicendo che il tiranno ha anche la potestà di far uccidere un buon comandante, Socrate rispondeva: “Ma tu credi che chi fa uccidere i suoi più poderosi alleati, ne scampi la pena o vada incontro ad una punizione soltanto casuale? Tu credi che così facendo, il tiranno salvaguardi meglio la propria sicurezza, oppure che andrà più rapidamente incontro alla propria rovina?”.
[III,IX,14] Quando uno gli chiese quale egli giudicasse essere la migliore delle attività possibili per un uomo, Socrate gli rispose: “il ben fare”. E richiesto nuovamente di dire se ritenesse che anche la buona sorte è un’attività umana, egli rispose: “Io credo fermamente che fortuna ed attività umana siano proprio il contrario una dell’altra. Infatti, se uno ottiene qualche cosa di cui manca e che neppure sta ricercando: questo io lo credo essere ‘buona sorte’. Ritengo invece essere ‘ben fare’ l’effettuare bene qualcosa, avendola imparata e studiata a fondo; e pertanto quanti questa attività praticano a me paiono uomini che fanno bene”. [III,IX,15] Aggiungeva anche che gli uomini in assoluto migliori e più cari agli dei sono, in campo agricolo, coloro che praticano bene l’agricoltura, in medicina coloro che praticano bene l’arte medica, in politica coloro che praticano bene l’arte politica. Chi invece nulla pratica bene, Socrate lo definiva un essere né proficuo, né caro agli dei.
[III,X,1] Quando gli capitava di dialogare con qualcuno degli artisti professionisti e del loro lavoro, la conversazione con Socrate riusciva ad essere davvero di giovamento anche a costoro.
Infatti, entrato una volta nella bottega del pittore Parrasio e discutendo con lui, Socrate gli chiese: “Dunque voi pittori, grazie all’uso dei colori, dipingendo rappresentate fedelmente l’aspetto che hanno entità corporee basse ed alte, scure e chiare, dure e molli, ruvide e lisce, giovani e vecchie”.
“Stai dicendo il vero” rispose Parrasio.
[III,X,2] “E invero, poiché non è facile imbattersi in un individuo, tutte le parti del cui corpo siano irreprensibili; voi da molti uomini diversi traete e radunate insieme i particolari migliori di ciascuno, e così fate in modo che i corpi che dipingete appaiano belli?”.
[III,X,3] “Sì, questo è quel che noi facciamo”, rispose Parrasio.
“E che? Siete dunque capaci”, riprese Socrate, “di ritrarre fedelmente in un dipinto il carattere dell’animo di un personaggio qualunque: per esempio, un animo straordinariamente accattivante, o dolcissimo, o amichevolissimo, o colmo di bramosia, o perdutamente innamorato? Oppure si tratta di qualcosa che è impossibile ritrarre?”
“Socrate, e come puoi pensare che si possa ritrarre ciò che è informe, incolore, che non possiede alcuno dei caratteri che tu hai appena detto, e che neppure è visibile?”
[III,X,4] “Ma avviene”, replicò Socrate, “che un uomo indirizzi verso taluni uno sguardo che è amichevole, e verso altri uno sguardo da nemico?”
“Mi pare proprio di sì”.
“E questo sguardo non lo si può imitare, dipingendo opportunamente gli occhi?”
“Certo che si può”.
“E tu pensi che i successi e gli insuccessi degli amici”, continuò Socrate, “producano le stesse espressioni del viso in chi di loro si preoccupa, e in chi di loro non si preoccupa?”
“Per Zeus, no di sicuro!”, rispose Parrasio, “In caso di successo degli amici, quei volti diventano raggianti; mentre in caso di insuccesso essi diventano accigliati”.
“E dunque”, chiese Socrate, “è possibile riprodurre fedelmente anche queste espressioni dei volti?”
“Certamente sì!”
[III,X,5] “E inoltre anche magnificenza e liberalità, meschinità e grettezza, moderazione e accortezza, insolenza e assenza di buongusto, si palesano chiaramente nei volti e negli atteggiamenti di uomini sia fermi che in movimento?”.
“Sì, è vero”.
“Dunque anche questi caratteri possono essere riprodotti fedelmente?”
“Senza alcun dubbio”.
“E quale credi che sia il dipinto più gradevole a vedersi? Quello di uomini da cui traspaiono nobiltà d’animo e amabilità; oppure quello di uomini da cui traspaiono disonore, depravazione e odiosità?”
“Per Zeus, c’è una gran differenza tra i due!”
[III,X,6] In un’altra occasione, entrato una volta nella bottega dello scultore Clitone e discutendo con lui, Socrate gli chiese: “Io so e vedo che tu scolpisci belle statue di corridori, di lottatori, di pugili e di pancraziasti. Ma come fai, e questo è ciò che più colpisce l’animo degli osservatori, a scolpirle dando l’impressione che esse siano viventi?”
[III,X,7] Visto che Clitone era incerto e non gli rispondeva subito, Socrate riprese la parola e gli disse: “È quindi raffigurando fedelmente le fattezze di atleti viventi, che fai apparire viventi le tue statue?”
“Sì, è proprio così”
“Dunque, è scolpendo corpi che si rannicchiano e che si rialzano, corpi bloccati nell’immobilità e che si divincolano, corpi tesi come archi e che si rilassano, nel modo più fedele possibile a quelli veri, che riesci a far apparire le tue statue così convincenti?”
“Sì, certamente” rispose Clitone.
[III,X,8] “E a dilettare gli spettatori, non è anche la fedele imitazione di ciò che quei corpi stanno sperimentando?
“Verosimilmente sì”
“E non vanno anche fedelmente imitate le occhiate minacciose dei combattenti, come pure lo sguardo trionfante dei vincitori?”
“Assolutamente sì”
“Pertanto”, concluse Socrate, “lo scultore deve saper raffigurare fedelmente anche i moti dell’animo dei suoi modelli”.
[III,X,9] Una vola Socrate entrò nella bottega di Pistia, il produttore di corazze; e poiché quello faceva sfoggio delle sue corazze ben lavorate, gli disse: “Sì, per Era, caro Pistia, è un gran bel ritrovato quello che protegge il torace, che è la parte dell’uomo che più ha bisogno di protezione, senza però impedirgli l’uso delle mani. [III,X,10] E tuttavia dimmi il motivo per cui, producendo corazze che sono né più resistenti né più pregiate di quelle di altri artigiani, tu le vendi ad un prezzo più alto”.
“Caro Socrate”, gli rispose Pistia, “il fatto è che io le faccio su misura”.
“E le misure che spiegano il loro maggior costo”, chiese Socrate, “sono misure di lunghezza o di peso? Infatti io non credo che tu faccia le corazze tutte dello stesso peso né della stessa lunghezza, se le fai adattabili”.
“Si, per Zeus; le faccio adattabili. Una corazza non è di alcun giovamento se non è fatta su misura”.
[III,X,11] “E dunque”, gli chiese Socrate, “i corpi di alcuni uomini sono proporzionati, mentre quelli di altri sono sproporzionati?”
“Ecco, sì: è proprio così”
“E come fai tu, adattando la corazza ad un corpo sproporzionato, a renderla proporzionata?”
“Appunto adattandola alla sproporzione di quel corpo; giacché è questo adattamento che rende la corazza proporzionata”
[III,X,12] “A me sembra quindi che tu intenda dire questo: ossia che proporzionata non è la corazza di per sé, ma il fatto che essa si adatti armoniosamente al corpo di chi la indossa. Così come si direbbe di uno scudo, che se si adatta bene alla corporatura di qualcuno, ecco che esso è uno scudo proporzionato. E si potrebbe dire la stessa cosa di una mantellina corta, o di qualunque altra cosa che paia a te. [III,X,13] Inoltre, forse c’è anche un altro non piccolo vantaggio congiunto all’adattamento”.
“Caro Socrate”, disse Pistia, “dimmelo subito, se ne hai in mente qualcuno”
“Le corazze ben adattate”, spiegò Socrate, “opprimono chi le indossa meno di quelle non ben adattate, pur avendo entrambe lo stesso peso. Infatti queste ultime, facendo gravare tutto il peso sulle spalle soltanto, o schiacciando pesantemente qualche altra parte del corpo, diventano gravose e scomode da indossare. Invece quelle ben adattate, suddividendo il loro peso in parte sulle clavicole, sulla sommità delle spalle, sulle spalle stesse, sul petto, sulla schiena e sull’addome, poco manca che somiglino non ad un gravame ma ad un accessorio”.
[III,X,14] “Quel che hai appena detto”, gli rispose Pistia, “spiega perché io ritenga che il mio lavoro merita di essere considerate di maggior valore di quello di altri. Comunque, ci sono sempre taluni i quali preferiscono comprare corazze variopinte ed indorate”.
“Invero”, gli disse Socrate, “se questo è il motivo per cui essi non acquistano corazze fatte su misura, a me sembra che con quelle variopinte ed indorate essi facciano un pessimo affare. [III,X,15] E tuttavia, poiché il corpo non mantiene sempre la stessa posizione, ma ora si incurva ed ora si raddrizza, come fanno le corazze fatte su misura ad adattarsi ai suoi movimenti?”
“Non c’è modo possibile”
“Tu stai dicendo che ad adattarsi non sono le corazze fatte su misura, ma quelle che non danno fastidi quando le si usa?”
“Tu l’hai detto, Socrate, e l’hai appena approvato rettissimamente”.
[III,XI,1] Una volta capitò che si trovasse ad Atene una bella donna, di nome Teodota, la quale accettava la compagnia di chiunque le piacesse. Quando uno dei presenti ne citò il nome, riferì che la bellezza di quella donna era al di sopra di qualunque possibile descrizione. Aggiunse pure che dei pittori si recavano da lei per farle dei ritratti, e che ad essi ella mostrava di sé proprio tutto quanto stava bene mostrare. “Sarebbe il caso”, disse allora Socrate, “che noi andassimo a vederla con i nostri occhi; giacché di certo, più che ascoltare delle parole su di lei, è molto meglio vederla in carne ed ossa”.
[III,XI,2] Al che, colui che l’aveva citata, disse: “Non perdete l’occasione di vederla!” Così Socrate ed altri si misero in cammino verso la casa di Teodota. La trovarono in compagnia di un pittore che la stava ritraendo, ed ebbero tutto l’agio di osservarla. Quando il pittore ebbe finito, Socrate chiese: “Signori, chi dei presenti deve mostrare più gratitudine? Noi a Teodota, per averci sfoggiato tutta la sua bellezza? Oppure Teodota a noi, perché di tale bellezza siamo rimasti qui spettatori? E lo sfoggio di tanta bellezza giova di più a lei, e quindi è lei tenuta a ringraziare noi; oppure siamo noi tenuti a ringraziare lei, per lo spettacolo cui abbiamo assistito?”
[III,XI,3] Poiché un tale diceva che la sua osservazione era giusta, Socrate continuò: “Costei si è ormai guadagnata la nostra lode, e dal momento che noi ne spargeremo in giro la notizia, di certo ella ne trarrà ancor più giovamento. Insomma, noi ormai smaniamo di toccare con mano tutto ciò che abbiamo appena visto. Ce ne andiamo quindi profondamente eccitati, ed una volta lontani, di lei conserveremo la brama. La verosimile conseguenza di ciò è che noi saremo i suoi adoratori, e lei l’adorata Teodota”. A questo ella rispose: “Sì, per Zeus. Se le cose stanno in questi termini, dovrei io essere grata a voi per avere assistito allo spettacolo”.
[III,XI,4] Tempo dopo, quando Socrate vide Teodota acconciata in modo costoso; vide la madre di lei in abiti non qualunque, ma molto curati; vide molte domestiche di bell’aspetto e che lavoravano senza sciatteria; e quando vide, oltre al resto, che la casa era abbondantemente fornita di suppellettili, Socrate le chiese: “Teodota, ma tu sei proprietaria di coltivi?”
“Io? No di certo”
“Di una casa da cui ricavi un affitto?”
“No, neppure di una casa”
“Forse hai alle tue dipendenze dei manovali?”
“No, neppure dei manovali”
“Ma allora come fai a procacciarti ciò che ti serve per vivere?”
“Se uno, che è diventato mio amico, vorrà fare del bene: ecco, costui è la mia vita”
[III,XI,5] “Sì, per Era”, disse Socrate, “il tuo è davvero uno splendido possesso, cara Teodota; e molto migliore del possesso di pecore, di capre e di buoi. E tuttavia”, continuò Socrate, “dimmi: che uno diventi tuo amico, tu lo deleghi interamente alla fortuna, come si trattasse di una mosca che si posa su di te; oppure anche tu metti in opera qualche accorgimento al riguardo?”
[III,XI,6] “E come potrei io”, gli rispose Teodota, “inventarmi un espediente per ottenerlo?”
“Per Zeus, sì che c’è”, le rispose Socrate, “ed ancora più spediente di quelli che impiegano i falanghi. Come tu sai, i falanghi vanno a caccia di quanto loro serve per vivere. A questo fine, essi tessono delle sottili tele di ragno e qualunque cosa cada in queste tele, essi di quella si cibano”.
[III,XI,7] “Tu dunque”, gli rispose Teodota, “mi consigli di tessete qualcosa di simile ad una ragnatela?”
“No di certo. Non è pensandola in un modo così rozzo”, le rispose Socrate, “che bisognerà praticare la caccia agli amici, ossia la più degna di tutte le caccie. Non vedi che anche per la caccia alla lepre, che è una caccia di ben poco valore, i cacciatori mettono in opera un sacco di astuzie? [III,XI,8] Infatti, poiché le lepri pasturano di notte, i cacciatori si provvedono di cani addestrati alla caccia notturna, e con questi le cacciano. E poiché all’alba le lepri fuggono lontano dai luoghi di pastura, i cacciatori sono provvisti di una muta di altri cani i quali, quando le lepri lasciano il luogo per ritirarsi nei loro covili, le individuano e le rintracciano grazie al loro finissimo odorato. E poiché le lepri sono velocissime nella corsa, tanto da sparire alla vista anche correndo in campo aperto, i cacciatori hanno pronta anche un’altra muta di cani, i quali sono capaci di inseguirle e catturarle seguendone le orme. E poiché qualche lepre riesce comunque a sfuggire anche a questi levrieri, i cacciatori dispongono delle reti sui loro percorsi di fuga, al fine da farle cadere in esse e così rimanere impastoiate”.
[III,XI,9] “Con quale di questi metodi”, chiese Teodota, “potrei dunque andare a caccia di amici?”
“Un metodo c’è, per Zeus”, le rispose Socrate, “Tu, invece di un cane, ti procurerai qualcuno che in tua vece, seguendo le loro orme, trovi per te degli uomini ricchi e amanti del bello; e una volta trovatili, escogiti il modo per farli imbattere nelle tue reti”.
[III,XI,10] “Ma quale sorta di reti, posseggo mai io?”
“Intanto una rete meravigliosamente atta ad avvilupparli è, di sicuro, il tuo corpo. Poi, all’interno di questo corpo c’è l’animo tuo. Animo, grazie al quale, all’istante sai decifrare come renderti gradita con uno sguardo; come allietare con una parola; come si deve accogliere di buon grado chi si prende cura di te, e invece chiudere la porta in faccia allo smargiasso; visitare con sincera preoccupazione l’amico che è caduto ammalato; compiacerti fino in fondo con l’amico che fa qualcosa di bello; e ringraziare di cuore chi si preoccupa davvero di te. Quanto al fare l’amore, io so bene che ne sei esperta, e non soltanto nel farlo con tenerezza ma anche con affetto. E so anche che gli amici a te più graditi, li convinci di ciò non con le parole ma con i fatti”.
“Ma per Zeus”, esclamò Teodota, “io non metto in opera neppur una delle smorfioserie che hai appena citato!”
[III,XI,11] “E comunque”, continuò Socrate, “è sempre un segno di grande distinzione il rivolgersi ad un uomo con naturalezza e insieme con correttezza. Infatti, non è con la violenza che potresti catturare e trattenere teco un amico, giacché puoi accattivarti questa preda e farla rimanere fedele, soltanto con il ben operare e la piacevolezza dei tuoi modi”.
“Quel che dici è vero”.
[III,XI,12] “In primo luogo bisogna pertanto”, insistette Socrate, “chiedere a coloro che mostrano di darsi pensiero di te, quel genere di favori per fare i quali essi avranno il minimo di difficoltà. E poi, in secondo luogo, bisogna poter contraccambiare con la stessa moneta il favore ricevuto. In questo modo, infatti, essi diventerebbero amici sempre più stretti, più duraturi e capaci di fare dei favori sempre più grandi. [III,XI,13] E faresti cosa sommamente gradita agli amici, se facessi loro un dono da parte tua quando essi ne hanno bisogno, e non prima. Tu vedi, infatti, che anche i cibi più gradevoli, qualora vengano serviti in tavola prima di essere desiderati, appaiono sgradevoli e, a coloro che sono già sazi, procurano pure la nausea. Se invece uno serve in tavola dei cibi sia pur poverissimi, ma a gente affamata, questi appaiono gradevolissimi.
[III,XI,14] “E come potrei io rendere qualcuno affamato del mio cibo?”
“Sì, che lo puoi, per Zeus. In primo luogo”, soggiunse Socrate, “a coloro che sono già sazi, non serviresti in tavola né rammenteresti i tuoi cibi, fino a quando essi non abbiano smaltito la sazietà e ne sentano di nuovo la carenza. Successivamente, comportandoti come un modello di buona relazione, rammenteresti a coloro che ne sentono il bisogno, che tu sei riluttante a cedere, e ti tratterresti in disparte fino a che essi sentissero al massimo grado il bisogno di te. Infatti, allora i medesimi regali sono molto più graditi da chi li riceve, di quando essi siano offerti prima di essere stati desiderati.
[III,XI,15] “Caro Socrate, perché dunque”, esclamò allora Teodota, “non diventi mio compagno nella caccia agli amici?”
“Se riuscirai a persuadermi di farlo”, rispose Socrate.
“E come farei a persuaderti?”
“Questo modo lo troverai tu stessa, e lo metterai in opera se avrai bisogno da me di qualcosa”.
“Vieni, dunque, a trovarmi spesso!”, lo invitò Teodota.
[III,XI,16] Allora Socrate, con la mente al proprio desiderio di tenersi ben lontano da qualunque noia, disse a Teodota: “Per me non è affatto facile avere del tempo libero a disposizione. Infatti, molti affari sia privati che pubblici me ne tengono lontano. E inoltre ci sono anche delle mie amiche le quali, sia di giorno che di notte, mi impediscono di allontanarmi; poiché da me stanno imparando come si fanno dei filtri magici e degli incantesimi”.
[III,XI,17] “Socrate”, chiese stupita Teodota, “ma tu sai fare anche queste cose?”
“Ma per quale ragione credi tu, che Apollodoro e Antistene non mi lascino mai solo? E perché credi che Cebete e Simmia vengano a trovarmi provenendo fin da Tebe? Tu sai di sicuro, che cose come queste non càpitano se non ci sono di mezzo filtri magici, incantesimi e ruote fatate”.
[III,XI,18] “Metti dunque in funzione per me la tua ruota fatata”, disse allora Teodota, “affinché essa ti attiri a me per primo”
“Ma per Zeus”, le rispose Socrate, “io non voglio affatto essere attirato verso di te, bensì che sia tu a procedere verso di me”
“Ma ci procederò di sicuro; e speriamo che tu mi accolga”
“Io ti accoglierò, se non ci sarà dentro di me un’altra cosa che mi è amica assai più di quanto lo sia tu”.
[III,XII,1] Vedendo che Epigene, uno dei suoi sodali, pur essendo giovane era in assai cattive condizioni fisiche, Socrate una volta lo apostrofò dicendogli: “Caro Epigene, sei davvero a corto di allenamento fisico”.
Al che, Epigene rispose: “Caro Socrate, il fatto è che io sono un cittadino qualunque”.
“Certo non più allenato”, gli fece notare Socrate, “di coloro che sono in procinto di gareggiare ad Olimpia. Ma ti sembra una piccola cosa la lotta per la sopravvivenza che, quando capitasse, gli Ateniesi ingaggeranno contro i nemici? [III,XII,2] Eppure non sono pochi coloro che, a causa del pessimo stato fisico, muoiono nel corso delle tante situazioni pericolose legate alla guerra, oppure che si salvano a prezzo di viltà e disonore. Poi, molti di coloro che, a questo prezzo, sopravvivono, vengono catturati, e una volta prigionieri, o passano il resto della vita da schiavi, se così loro capita, nella più terribile schiavitù; oppure, caduti nelle ristrettezze più dolorose, e dopo avere pagato a volte più di quanto posseggano, passano il resto della vita nella indigenza delle cose più essenziali, e sopravvivono sottoposti a sofferenze inenarrabili. Molti sono, poi, coloro che acquisiscono una cattiva fama a causa della loro impotenza fisica, e che vengono ritenuti dei codardi. [III,XII,3] Tu spregi queste condanne del pessimo stato fisico, e pensi di poter sopportare a lungo siffatta nomea? Io credo che l’ottimo stato fisico del proprio corpo, sia un risultato assai più facile da ottenere e più gratificante della nomea di codardo. Oppure tu credi che il pessimo stato fisico sia più sano e, per il resto, più proficuo, dell’ottimo stato fisico? Oppure tu hai in spregio gli effetti dell’ottimo stato fisico? [III,XII,4] Eppure, a quanti sono in buone condizioni fisiche, accade tutto il contrario di ciò che accade a quanti sono in pessime condizioni fisiche. Infatti, quanti hanno il corpo in ottime condizioni, sono sani e pieni di forza. Grazie a ciò, sono molti coloro che si salvano valorosamente nei combattimenti sul campo di battaglia, e che sfuggono a tutti i terribili pericoli legati alla guerra. Molti sono anche coloro che vanno in soccorso degli amici; che fanno onore alla patria e che, per questa ragione, diventano degni di riconoscimenti; che acquisiscono grande fama; che ottengono splendidi doni e che quindi vivono meglio per il resto della loro vita, e che perciò lasciano in eredità ai loro figli risorse economiche più abbondanti.
[III,XII,5] Ora, il fatto che lo Stato non provveda, a pubbliche spese, alla buona condizione fisica dei suoi cittadini, non deve diventare, per questi, un motivo per trascurare la cura privata delle proprie condizioni fisiche; e quindi essi devono prendersi cura di esse nonostante tutto. Tu, infatti, sai bene che in nessuna gara ed in nessuna attività avrai la peggio, a causa dell’aver migliorato le tue condizioni fisiche. In tutte le attività pratiche nelle quali gli uomini si impegnano, il corpo è di fondamentale utilità; e in tutti gli impieghi del corpo, fa una gran differenza l’avere il proprio corpo nelle condizioni migliori possibili. [III,XII,6] Infatti, anche in attività nelle quali a te sembra esserci il minimo impiego del corpo, come nel pensare; chi non sa che anche in questa attività, molti commettono grandissimi errori a causa della cattiva salute del loro corpo? Spesso, a causa del loro pessimo stato fisico, la perdita della memoria, lo scoramento, la biliosità e la pazzia si abbattono su molti, in modo tale da privarli addirittura delle cognizioni che avevano. [III,XII,7] Per coloro il cui corpo è in ottime condizioni, non c’è invece alcun pericolo, e c’è la sicura garanzia di non sperimentare alcunché di simile a ciò che dipende da un pessimo stato fisico. Anzi, è del tutto verosimile che un ottimo stato fisico sia proficuo per ottenere tutto il contrario, e dunque per non imbattersi nelle conseguenze di un pessimo stato fisico. Di certo, a causa delle contrarietà appena citate, quali fatiche non sosterrebbe una persona assennata?
[III,XII,8] È vergognoso essere diventato vecchio per trascuratezza, senza mai vedere quale livello di bellezza e di forza fisica avrebbe potuto raggiungere il nostro corpo. Queste sono cose che chi non si è preso cura di sé non potrai mai vedere, poiché si tratta di cose che non accadono automaticamente e per conto loro.
[III,XIII,1] Una volta, un tale s’era adirato poiché, avendo salutato qualcuno, costui non gli aveva ricambiato il saluto. “La tua ira è ridicola”, gli disse Socrate, “giacché non ti saresti adirato se avessi incontrato qualcuno in condizioni di salute peggiori delle tue. Invece ti affliggi per esserti imbattuto in qualcuno il cui animo è disposto in modo più selvatico e rozzo del tuo.
[III,XIII,2] Poiché un altro andava dicendo di non provare alcun piacere nel mangiare, Socrate gli disse: “Per questa malattia, Acumeno spiega di avere un’ottima medicina”. “Di che medicina si tratta?”, gli fu chiesto. “Smettere di mangiare”, gli rispose Socrate, “giacché smettendo di mangiare, la farai passare in un modo più piacevole, più a buon mercato e più sano”.
[III,XIII,3] A sua volta, un altro andava dicendo che a casa sua l’acqua da bere era calda. “Ma allora”, gli disse Socrate, “quando deciderai di fare un bagno caldo, avrai l’acqua già bella pronta”.
“Ma per fare un bagno caldo”, obiettò l’altro, “quest’acqua risulta fredda”
“Quindi, i tuoi di casa si adontano per quest’acqua, sia quando la bevono, sia quando la usano per fare un bagno caldo?”
“No, per Zeus; ed io, più di una volta, sono rimasto stupito di come essi se ne servano con molta soddisfazione per entrambi gli usi”
“Ma l’acqua da bere più calda è quella di casa tua, oppure quella del tempio di Asclepio <ad Epidauro>?”
“Quella del tempio di Asclepio”
“E per fare un bagno caldo, è più fredda l’acqua di casa tua oppure quella del tempio di Anfiarao <ad Oropo>?”
“Quella del tempio di Anfiarao”
“Dunque, fatti coraggio”, concluse Socrate, “perché rischi di essere più maldisposto di quei di casa tua e di quanti sono infermi”.
[III,XIII,4] Una volta, avendo visto che un tale puniva molto duramente uno dei servi che aveva al seguito, Socrate gli chiese perché mai si fosse tanto adirato con quello. La risposta che ebbe fu: “Perché essendo un mangione ingordo come pochi, è un codardo di un’indolenza senza pari; e in quanto avidissimo di denaro, è di una pigrizia assoluta”.
“Ma hai già avuto il tempo di esaminare per bene”, gli chiese Socrate, “chi di voi due abbia più bisogno di botte: tu che ne sei il padrone oppure il tuo servo?”
[III,XIII,5] Poiché un tale aveva paura di mettersi in viaggio per Olimpia, Socrate gli disse: “Perché hai paura di questa camminata? Quando sei a casa, non passeggi forse quasi tutto il giorno? Anche quando camminerai fin là, dopo una passeggiata farai colazione, poi dopo un’altra passeggiata pranzerai e poi ti prenderai un po’ di riposo. Non sai che sommando tutte le passeggiate che fai adesso, in cinque o sei giorni avresti già facilmente coperto la distanza che separa Atene da Olimpia? Inoltre, è più confortevole anticipare la partenza di un giorno, piuttosto che ritardarla di altrettanto. Infatti, essere costretti ad allungare oltre misura la distanza percorsa in un giorno di cammino, fa diventare la camminata sgradevole; mentre invece l’avere un giorno in più a disposizione per essa, la fa diventare molto più comoda. Pertanto è meglio anticipare l’inizio del viaggio, piuttosto che allungare le distanze da percorrere ogni giorno”.
[III,XIII,6] Sentendo un altro tale dire che una lunga camminata lo aveva sfinito, Socrate gli domandò se avesse con sé anche del bagaglio.
“Per Zeus, sì, certo. Ma io ho con me soltanto la mia toga”
“Ma hai camminato da solo, o avevi qualcuno al tuo seguito?”
“Sì. Avevo uno al mio seguito”
“E costui era senza bagaglio oppure portava qualcosa?”
“Per Zeus, portava le mie coperte ed altre suppellettili”
“E come se l’è cavata”, gli chiese Socrate, “in questo viaggio?”
“A me sembra che se la sia cavata meglio di me”
“E dunque? Se avessi dovuto portare tu il suo bagaglio, come ti saresti comportato?
“Sì, assai male. O piuttosto, diciamo che non sarei stato capace di trasportarlo fin qua”
“E ti pare che sia degno di un uomo ben esercitato, l’essere così tanto meno capace di faticare di un servo?
[III,XIV,1] Ogni volta che, dei partecipanti ad un pranzo, taluni conferivano una piccola quantità di cibo mentre altri ne conferivano una quantità assai maggiore, Socrate soleva imporre al servitore di mettere in comune sia le piccole che le meno piccole quantità, e di suddividere il tutto in parti uguali per ciascun commensale. I partecipanti che conferivano una quantità di cibo maggiore degli altri, si vergognavano infatti di non mettere in comune quanto avevano conferito, e di trattenerlo per sé. Essi mettevano quindi in comune anche i loro contributi; ma poiché ottenevano una quantità di cibo, di certo non maggiore di quella che ottenevano quanti avevano conferito di meno, smisero ad un certo punto di spendere più degli altri per l’acquisto del cibo.
[III,XIV,2] Una volta, Socrate si accorse che uno dei commensali aveva smesso di mangiare del pane e mangiava soltanto il companatico. Poiché il discorso era caduto sui nomi, cioè su quale fosse il nome che si confaceva a ciascuna azione, Socrate chiese: “Signori, avremmo noi modo di dire quale sia l’azione specifica per la quale un uomo viene chiamato: mangione ingordo? Tutti gli uomini mangiano il companatico con del pane, quando ce ne sia. Ma io non credo che sia questo il motivo per cui essi sono chiamati mangioni ingordi”.
“No di certo”, disse uno dei presenti.
[III,XIV,3] “E dunque?”, continuò Socrate, “Se uno mangerà la pietanza senza mangiare del pane, e se lo farà non perché sta seguendo una dieta da atleta in allenamento ma per puro piacere, a voi sembra che costui sia un mangione ingordo oppure no?”
“Se non è a dieta, non si vede chi altro sia un mangione ingordo”
A questo punto, un altro dei presenti chiese: “E come si chiama chi mangia poco pane e molto companatico?”
“A me pare”, gli rispose Socrate, “che anche costui sia giustamente chiamato ‘mangione ingordo’, giacché quando gli altri uomini auspicano di ottenere dagli dei abbondanza di frutti, costui verosimilmente auspicherebbe di ottenere dagli dei abbondanza di pietanza”.
[III,XIV,4] Mentre Socrate pronunciava queste parole, il giovanotto, ritenendo che esse fossero rivolte a lui, non smise di mangiare la pietanza, ma le aggiunse anche del pane. Allora Socrate, resosene conto avvertì: “Voi che gli state accanto, tenete d’occhio il giovanotto, per capire se egli utilizzerà il pane come pietanza oppure la pietanza come pane”.
[III,XIV,5] Una volta, vedendo uno dei commensali che gustava pietanze diverse, da lui mescolate insieme su un unico pezzo di pane, Socrate disse: “Potrebbe mai realizzarsi una cucina di pietanze più costosa o che più ne guasta il sapore, di quella che cucina per sé chi mette insieme pietanze diverse e porta alla bocca ogni sorta di insieme di salse? Costui fa diventare le pietanze ancor più costose di quelle che preparano i cuochi, mescolando vari ingredienti. Infatti gli ingredienti che i cuochi non mescolano perché non si armonizzano tra di loro, costui invece li mescola: e quindi, o i cuochi non operano rettamente, oppure è lui che sbaglia e manda al macero la loro arte. [III,XIV,6] E inoltre come può non essere ridicolo il comportamento di colui che assolda dei cuochi che conoscono meglio di tutti l’arte del cucinare, e che, senza neppur pretendere di conoscere quest’arte, altera del tutto il sapore dei cibi da essi cucinati? Succede pure qualcos’altro ancora a chi ha l’abitudine di mangiare cibi diversi mescolati assieme. Infatti, se non c’è varietà di cibi, a costui parrebbe esserci scarsità di quelli che abitualmente desidera; mentre invece chi è abituato a mangiare una sola pietanza con un solo pezzo di pane, quando di pietanze diverse non ce ne fossero molte, egli potrebbe servirsi di quella soltanto senza alcun disagio.
[III,XIV,7] Socrate soleva anche dire che l’espressione ‘trattarsi bene’, nel dialetto di Atene era sinonimo di ‘mangiare’. E ribadiva che la presenza dell’avverbio ‘bene’ implicava il mangiare dei cibi che non creavano disagio né al corpo né all’animo, e che non erano difficili da trovare. Sicché, secondo lui, il trattarsi bene si attagliava anche a quanti avevano un tenore di vita ordinato e regolare.
Libro IV
Introduzione
Quelli che la tradizione ha raccolto sotto il generico nome di ‘Memorabilia’, ovvero di ‘Detti e fatti memorabili’, sono appunti disparati che Senofonte scrisse in tempi diversi e senza un ordine preciso. L’unico elemento che appare tenerli uniti è la presenza costante del personaggio ‘Socrate’, come visto ed interpretato da Senofonte.
Per comodità, io ho raccolto ciascun appunto in altrettanti paragrafi. Gli appunti che formano il Libro IV sono in totale 26, e l’argomento di ciascuno di essi è il seguente:
Appunto 1 – [IV,I,1-2] Chi erano le persone delle quali Socrate si innamorava spesso.
Appunto 2 – [IV,I,3-5] Chi erano le persone che Socrate chiamava stupide e dannose.
Appunto 3 – [IV,II,1-2] Il giovane Eutidemo rifiuta sistematicamente ogni contatto con Socrate.
Appunto 4 – [IV,II,3-8] Socrate trova il modo di aprire una breccia nel mutismo di Eutidemo.
Appunto 5 – [IV,II,9-11] Eutidemo confida a Socrate di mirare a quella eccellenza che ci rende capaci di essere giusti e di governare gli Stati.
Appunto 6 – [IV,II,12-13] Socrate propone, ed Eutidemo accetta, di raccogliere in una colonna G tutte le opere giuste, ed in una colonna I tutte le opere Ingiuste.
Appunto 7 – [IV,II,14-19] Socrate sorprende Eutidemo, dimostrandogli che tutte le azioni poste in G, sono le stesse che possono essere poste anche in I.
Appunto 8 – [IV,II,20-23] Socrate chiede ad Eutidemo se la scienza del giusto e la scienza delle lettere siano la stessa scienza?
Appunto 9 – [IV,II,24-29] Socrate ed Eutidemo discutono sul ‘Riconosci te stesso’.
Appunto 10 – [IV,II,30-33] Socrate ed Eutidemo discutono sui beni e sui mali.
Appunto 11 – [IV,II,34-36] Socrate ed Eutidemo si chiedono se la felicità sia sempre un bene.
Appunto 12 – [IV,II,37-40] Socrate ed Eutidemo discutono su cosa sia la democrazia. Eutidemo, persa ogni fiducia sul proprio presunto sapere, si allontana.
Appunto 13 – [IV,III,1-18] Socrate ed Eutidemo discutono sugli dei e sulla importanza del loro culto.
Appunto 14 – [IV,IV,1-5] Il rispetto di Socrate per la giustizia e per le leggi dello Stato.
Appunto 15 – [IV,IV,6-25] Socrate discute di giustizia e di legalità con Ippia di Elide.
Appunto 16 – [IV,V,1-12] Socrate discute con Eutidemo dell’importanza della temperanza, e del pieno controllo di se stessi, in vista di una vita armoniosa, felice, e ricca di nobili imprese.
Appunto 17 – [IV,VI,1-5] Socrate ad Eutidemo sul come definire il ‘culto degli dei’.
Appunto 18 – [IV,VI,6] Socrate ad Eutidemo sul come definire le ‘azioni giuste’.
Appunto 19 – [IV,VI,7] Socrate ad Eutidemo sul come definire la ‘sapienza’.
Appunto 20 – [IV,VI,8] Socrate ad Eutidemo sul come definire il ‘bene’.
Appunto 21 – [IV,VI,9] Socrate ad Eutidemo sul come definire il ‘bello’.
Appunto 22 – [IV,VI,10-11] Socrate ad Eutidemo sul come definire la ‘virilità’.
Appunto 23 – [IV,VI,12-15] Governo sovrano e governo tirannico, secondo Socrate.
Appunto 24 – [IV,VII,1-10] Socrate insegnava anche fino a quale livello di esperienza di ciascuna faccenda pratica, debba pervenire l’uomo correttamente educato.
Appunto 25 – [IV,VIII,1-3] Socrate parla del suo démone.
Appunto 26 – [IV,VIII,4-11] Ermogene riferisce a Senofonte, i pensieri di Socrate nei suoi ultimi giorni di vita.
Traduzione
[IV,I,1] Su qualsivoglia faccenda e comunque la si considerasse, Socrate era di tale giovamento, che per chi prendeva sul serio le sue parole e ne comprendeva a sufficienza il significato, era evidente non esservi scelta più giovevole di quella di rimanere in sua compagnia, e quindi di discuterne con lui in qualunque luogo e in qualunque momento della giornata. Anche quando era assente, il semplice ricordarsi del suo punto di vista risultava di non piccolo giovamento a quanti erano abituati alla sua compagnia e lo accettavano come maestro; giacché, sia scherzando e sia parlando sul serio, egli era di non minore vantaggio ai suoi interlocutori. [IV,I,2] Per esempio, Socrate soleva spesso dire di essere innamorato di qualcuno; ma era evidente che egli si riferiva non all’amore per i corpi di persone nel fior degli anni, bensì alle persone bennate il cui animo era tutto rivolto al perseguimento della virtù. Egli arguiva l’esistenza di tali nobili nature, dal fatto che esse apprendevano rapidamente tutto ciò cui dirigevano l’attenzione, ricordavano ciò che avevano imparato e nutrivano uno speciale desiderio di tutte quelle conoscenze, grazie alle quali è possibile amministrare in modo eccellente una casa, lo Stato e, insomma, fare buon uso degli uomini e delle faccende umane. Socrate riteneva infatti che tali individui bennati, essendo stati educati alla virtù, fossero non soltanto uomini felici esse stessi, e capaci di amministrare in modo eccellente le loro case, ma di poter anche rendere felici gli altri uomini e gli altri Stati. [IV,I,3] Egli non si avvicinava a tutti gli uomini nello stesso modo. A quanti credevano di essere dei purosangue di nobile natura e che spregiavano ogni apprendimento, egli spiegava che le nature le quali si ritengono superiori a tutte le altre, hanno il massimo bisogno di educazione. Egli mostrava dunque loro che i cavalli purosangue, focosi e pieni di energia come sono, qualora siano stati domati quand’erano puledri, diventano profittevolissimi e splendidi animali; ma che se rimangono non domati, sono difficilissimi da tenere alla briglia e restano intrattabili. Anche nel caso dei cani delle migliori razze, amanti come sono della fatica e cacciatori di animali selvatici, quelli bene addestrati diventano strenui e profittevolissimi cacciatori; ma se rimangono non addestrati, restano pasticcioni, stupidi e disobbedienti. [IV,I,4] Allo stesso modo, anche i più bennati tra gli uomini, essendo d’animo fortissimo e brillanti esecutori di ciò cui mettono mano, se sono stati educati ed hanno imparato quel che si deve effettuare, diventano splendidi e giovevolissimi individui; apportatori di moltissimi e grandissimi beni. Qualora essi invece rimangano privi di educazione ed incolti, diventano persone pessime e dannosissime, giacché non avendo imparato a giudicare quel che si deve effettuare, mettono spesso mano ad imprese malvagie; ed essendo amanti del grandioso ed estremamente energiche, sono difficili da tenere a freno e difficili da dissuadere, e perciò sono apportatrici di moltissimi e grandissimi mali. [IV,I,5] Quanto a coloro che fanno un gran conto della ricchezza di denaro; che ritengono di non avere alcun bisogno di educazione; che ritengono bastar loro il denaro per effettuare qualunque cosa vogliano e per essere tenuti in grande onore dagli uomini; Socrate li faceva rinsavire affermando che è uno stupido chi, senza averlo mai imparato, crede di poter sceverare quali opere siano giovevoli e quali siano dannose; che è uno stupido chi, essendo incapace di sceverare quanto è di giovamento e quanto è di danno, crede di potersi provvedere col denaro di qualunque cosa vorrà e che potrà così fare il proprio comodo; che è uno sciocco chi, essendo incapace di fare il proprio comodo, crede di far bene e di procurarsi, egregiamente ed a sufficienza, quanto gli serve per vivere; che è sciocco chi crederà, nulla sapendo, di essere qualcosa di gran valore, per il denaro che ha; o che avrà buona fama pur apparendo essere un buono a nulla.
[IV,II,1] Narrerò ora in quali termini Socrate usava riferirsi a coloro che ritenevano di avere ricevuto la migliore educazione possibile, e che si vantavano della loro sapienza. Socrate era venuto a conoscenza del fatto che il bell’Eutidemo aveva raccolto un gran numero di opere dei poeti e dei sofisti più famosi; e che riteneva, per questo motivo, di essere ormai ad un livello di sapienza ben diverso da quella dei suoi coetanei. Per di più, Eutidemo nutriva grandi speranze di mostrarsi differente da tutti nella capacità di parlare e di operare. Socrate, essendo venuto a sapere che, a causa della sua giovane età, Eutidemo non entrava mai nella piazza del mercato, e che quando intendeva che qualcuno sbrigasse per lui qualche faccenda, soleva sedere nella bottega di uno dei tanti sellai che si trovavano molto vicino alla piazza del mercato, si recò dunque in tale bottega, in compagnia di alcuni suoi seguaci. [IV,II,2] Sulle prime, uno dei suoi seguaci cercò di sapere da Eutidemo se Temistocle si fosse distinto così tanto da tutti gli altri cittadini, a causa della sua costante frequentazione di uomini sapienti; oppure semplicemente per delle doti sue naturali: giacché era sempre a lui che guardava la città intera, ogni volta che avesse bisogno di una guida industriosa e saggia. Socrate poi, volendo incoraggiare Eutidemo a dare una risposta, con tutta semplicità aggiunse: “È logico credere che se anche opere d’arte di poco valore non sono realizzabili alla perfezione senza l’insegnamento di maestri che ne siano all’altezza, anche il reggimento di uno Stato, che è la più eccellente di tutte le opere umane, non si realizza automaticamente e senza una guida”. [IV,II,3] In un’altra occasione, Socrate incontrò nuovamente Eutidemo, e notò che egli badava a tenersi ben discosto dalla sua compagnia, affinché fosse chiaro che non condivideva alcuna forma di ammirazione per Socrate e la sua sapienza. “Signori miei”, disse allora Socrate, “è manifesto da quel che l’Eutidemo qui presente sta facendo a bella posta, che egli, avendone ormai raggiunta l’età, non si asterrà dal dare i suoi consigli, quando la città abbia messo all’ordine del giorno dell’Assemblea una qualche questione. Io me lo vedo già che prepara un bel proemio, uno di quelli adatti ai discorsi parlamentari, in cui egli bada bene a non sembrare uno che abbia imparato qualcosa da qualcuno. Ed è evidente che egli comincerà il suo discorso con queste parole: [IV,II,4] “Signori Ateniesi, io mai ho imparato qualcosa da qualcuno. E sentendo dire che alcuni uomini erano eccellenti parlatori oppure ottimi artefici, mai io ho cercato di incontrarli, né mai mi sono dato la pena di diventare allievo di qualche dotto maestro. Ho fatto, invece, tutto il contrario; e la mia vita è stata una continua fuga, non soltanto dall’imparare qualcosa da qualcuno, ma anche dal solo sembrarlo. Perciò, qualunque siano i pensieri che mi passeranno automaticamente per la testa, ebbene questi saranno i miei consigli per voi”.
[IV,II,5] “Un proemio di questo genere”, continuò Socrate, “ben si acconcerebbe anche a coloro che volessero ottenere dalla città l’autorizzazione ad aprire uno studio medico. E sarebbe altamente idoneo, per costoro, cominciare il loro discorso con queste parole: ‘Signori Ateniesi, io mai ho imparato l’arte medica da qualcuno, e neppure ho mai cercato di far sì che qualche medico diventasse mio maestro. Ho passato la mia vita badando bene, non soltanto ad evitare di apprendere checchessia dai medici, ma anche ad evitare di sembrare qualcuno che ha imparato quest’arte. Perciò autorizzatemi ad aprire uno studio medico, giacché io farò ogni sforzo per imparare, facendo i miei esperimenti su di voi’. E così, udito questo proemio, tutti i presenti scoppiarono a ridere. [IV,II,6] Era ormai evidente che Eutidemo prestava attenzione alle parole che Socrate pronunciava, e che però badava bene a non aprire mai bocca, ritenendo così di circondarsi, col silenzio, della fama di individuo accorto. Perciò Socrate, volendo fargli smettere una buona volta il suo silenzio, disse: “È davvero stupefacente che quanti vogliono diventare suonatori di cetra o di flauto, oppure cavalieri o qualunque altra cosa del genere, facciano in continuazione ogni sforzo possibile per diventare esperti nell’arte di loro scelta. E ciò essi fanno, non chiudendosi nella solitudine, ma recandosi presso quanti sono considerati i migliori professionisti di quella tale arte; e tutto effettuano, e qualunque fatica sopportano, pur di non fare alcunché di contrario alle istruzioni ricevute, giacché questo è l’unico modo per diventare degni di considerazione. Invece, tra coloro che vogliono diventare capaci oratori ed importanti personaggi politici, certuni ritengono di essere capaci di diventare tali, senza una preparazione adeguata e senza un esercizio costante, bensì automaticamente, dall’oggi al domani. [IV,II,7] Eppure, queste capacità appaiono di tanto più difficile acquisizione rispetto alle altre appena citate, quanto più è grande il numero di coloro che si danno da fare in tal senso, ma piccolissimo quello di coloro che ce la fanno. È dunque manifesto che quanti mirano a questo risultato, hanno bisogno di uno studio ben superiore e ben più profondo di quello necessario a coloro che mirano alle altre mete”. [IV,II,8] Le prime volte, dunque, mentre Socrate parlava, Eutidemo altro non faceva che ascoltare. Ma quando Socrate si rese conto che Eutidemo appariva più disponibile e meno insofferente di sentirlo parlare, ed anzi appariva ascoltarlo più di buon grado, Socrate decise di recarsi da solo nella bottega del sellaio; e mentre gli sedeva accanto, gli disse: “Eutidemo, dimmi. È successo davvero quel che io sento dire, ossia che tu hai messo insieme un gran numero di testi dei cosiddetti uomini sapienti?”
Eutidemo finalmente aprì bocca e gli disse: “Sì, per Zeus, caro Socrate, e ancora ne sto mettendo insieme altri, così da riuscire ad acquisire il maggior numero di scritti che mi sia possibile”.
[IV,II,9] “Sì, per Era”, gli rispose Socrate, “mi compiaccio con te, perché non ti sei prescelto, quali tesori, il possesso di argento o di oro, bensì il possesso della sapienza. Così facendo, è manifesto che tu ritieni che argento ed oro non facciano per nulla gli uomini migliori, e che sono invece le convinzioni degli uomini sapienti ad arricchire di virtù coloro che le posseggono”. Eutidemo assai si compiacque di ascoltare queste parole, ritenendo di apparire così, agli occhi di Socrate, qualcuno che s’era messo rettamente sulla strada della sapienza. [IV,II,10] Allora Socrate, resosi conto del piacere provato da Eutidemo per questa lode, gli chiese: “E tu, Eutidemo, in cos’è che vuoi eccellere, raccogliendo tutti quei libri?” Poiché Eutidemo taceva, riflettendo su quale risposta dare, Socrate gli chiese nuovamente: “Forse diventando un medico? I trattati di medicina sono infatti assai numerosi”.
La risposta di Eutidemo fu: ”Oh, per me no di sicuro”.
“Vuoi forse allora diventare un architetto? Anche questo mestiere abbisogna di un uomo dalle solide conoscenze”.
“No, neppure questo” rispose Eutidemo.
“Forse tu desideri assai”, lo incalzò Socrate, “diventare un ottimo matematico, come Teodoro?”
“No, neppure un matematico” fu la risposta.
“Forse tu vuoi diventare un astronomo?”.
Eutidemo rispose di no anche a questo.
“Forse un rapsodo?”, gli chiese Socrate., “Infatti si dice che tu possegga la raccolta completa di tutta la poesia Omerica”.
“Per Zeus, sicuramente no”, rispose Eutidemo, “io so che i rapsodi recitano esattissimamente la poesia epica, ma so anche che di per se stessi, costoro sono degli sciocchi”.
[IV,II,11] Allora Socrate continuò: “Eutidemo, dunque allora tu miri a quella eccellenza grazie alla quale gli uomini diventano dei personaggi politici e degli economisti, delle persone capaci di presiedere gli Stati, degli individui giovevoli agli altri ed anche a loro stessi?”.
Al che Eutidemo esclamò: “Socrate, è assolutamente a questo che io miro; questa è l’eccellenza di cui io sento il bisogno”.
“Sì, per Zeus”, continuò Socrate, “questa è la virtù in assoluto più bella, e l’arte più grande a cui mirare, giacché essa è quella dei re, e quella che viene chiamata ‘arte regale’. Nondimeno hai tu acclarato se sia impossibile che tutto ciò sia bene, se tu non sei un uomo giusto?”
“L’ho acclarato a fondo, e ne ho concluso che, senza giustizia, è impossibile diventare un buon cittadino”.
[IV,II,12] “E dunque?”, gli chiese Socrate, “tu l’hai messa in opera?”
“Io credo di sì, caro Socrate; e credo anche di essermi mostrato giusto non meno di altri”.
“E dei giusti vi sono opere”, insistette Socrate, “come vi sono opere dei falegnami?”
“Sì, ci sono”.
“E dunque; come i falegnami”, disse Socrate, “possono mostrare le loro opere, così pure i giusti potrebbero dare spiegazioni delle loro opere?”
“E perché no?”, continuò Eutidemo, “Non potrei forse io spiegare le opere della giustizia? Sì, per Zeus; e spiegare pure quelle dell’ingiustizia? Giacché non sono poche le opere, sia dell’una che dell’altra, che ogni giorno ci è dato vedere ed ascoltare”.
[IV,II,13] “Vuoi, allora”, gli propose Socrate, “che disegniamo insieme due colonne: una colonna che chiameremo G ed una che chiameremo I. Ora, tutte le opere che a noi parranno essere opere di Giustizia, le scriveremo nella colonna G; mentre tutte quelle che a noi parranno essere opere di Ingiustizia, le scriveremo nella colonna I”.
“Se a te pare che ciò ci sia di aiuto”, accettò Eutidemo, “facciamo pure così”.
[IV,II,14] Dopo avere disegnato, come detto, le due colonne; Socrate chiese: “Tra gli uomini esiste la pratica di mentire?”
“Sì, esiste” rispose Eutidemo.
“In quale delle due colonne porremo dunque la tua risposta?”
“Manifestamente nella colonna dell’Ingiustizia”
“E l’ingannare, esiste anch’esso?”
“Assolutamente sì”
“E pure questo, in quale delle due colonne lo porremo?”
“Anche questo, è chiaro, nella colonna I”
“E cosa pensi del malaffare?”
“Anche questo va nella colonna I”
“E il ridurre in schiavitù?”
“Anche questo nella I”
“E nessuna di queste opere”, caro Eutidemo, “andrà, secondo noi, mai posta nella colonna G, quella della Giustizia?”
“Fare una cosa del genere sarebbe una mostruosità”, protestò Eutidemo.
[IV,II,15] “E quindi? Se uno che è stato eletto Comandante Generale, riduce in schiavitù uno Stato che gli è nemico e che vive di ingiustizie: diremo noi che egli ha commesso un’ingiustizia?”
“No di certo”, rispose Eutidemo.
“Non diremo forse che egli ha effettuato un’azione giusta?”
“Assolutamente giusta”
“E se egli inganna i nemici, che diremo?”
“Chiameremo giusta anche questa azione”
“E se egli ruberà e saccheggerà i loro beni, non sarà la sua un’azione giusta?”
“Assolutamente giusta. Ma in precedenza io mi ero fatto l’idea”, specificò Eutidemo, “che tu ponessi queste domande in riferimento soltanto a coloro che ci sono amici”.
“Pertanto”, concluse Socrate, “tutte le azioni che noi abbiamo posto nella colonna I, non sono le stesse che andrebbero poste anche nella colonna G?”
“In effetti, pare proprio che sia così!”
[IV,II,16] “Sei dunque d’accordo con me”, propose a questo punto Socrate, “nel riordinare il contenuto delle due colonne, e definire Giusto il comportarsi in un certo modo contro i nemici, ma Ingiusto il comportarsi allo stesso modo con gli amici, giacché verso questi ultimi bisogna essere di una lealtà assoluta?”
“Sono pienamente d’accordo”, rispose Eutidemo.
[IV,II,17] “E che succede, ora?” riprese Socrate. “Se il Comandante Generale, vedendo che il suo esercito è preda dello scoramento, annuncerà, mentendo, che degli alleati sono in arrivo; e se grazie a questa menzogna, farà cessare lo scoramento dei suoi soldati: ebbene, questo inganno, in quale delle due colonne lo porremo?”
“Io direi che vada ascritto alla colonna G, quella della Giustizia”.
“E se un padre vede che suo figlio si rifiuta di prendere una medicina della quale ha però bisogno; e gliela somministra, con l’inganno, come un cibo qualunque; e utilizzando questa menzogna lo fa guarire: ebbene, a quale colonna va ascritto questo inganno?”
“A me pare che vada scritto nella stessa colonna di prima”.
“E che? Se qualcuno, mentre un suo amico è gravemente depresso; temendo che egli si tolga la vita, gli ruberà o sottrarrà con la violenza la spada, oppure qualche altra arma del genere: ebbene, questa rapina in quale colonna la porremo?”
“Anche questa, per Zeus, nella colonna G, quella della Giustizia”.
[IV,II,18] “Tu stai dicendo che non bisogna sempre trattare con piena sincerità neppure gli amici?”
“Per Zeus, non intendo dire questo”, protestò Eutidemo, “e se mi è permesso, ritiro le parole che ho appena detto”.
“Questo ritiro va certamente permesso”, assentì Socrate, “giacché è molto meglio permetterlo, che disporre la risposta nella colonna sbagliata”. [IV,II,19] E di coloro che ingannano gli amici per recare loro un danno, lo dico per non lasciare senza considerazione anche questo caso, chi compie un’ingiustizia maggiore: chi inganna di proposito, oppure chi inganna non di proposito?”
“Socrate, ormai ho perso io stesso fiducia nelle risposte che sto dando alle tue domande; giacché tutte le valutazioni che ho espresso in precedenza, mi appaiono ora avere un significato diverso da quello che credevo prima. Comunque, la mia attuale risposta questa: è più ingiusto chi mente di proposito, rispetto a chi mente non di proposito”.
[IV,II,20] “A te pare che l’apprendimento e la scienza del giusto siano come quelli delle lettere?”
“Io dico di sì”.
“Quale dei due giudichi più letterato: colui che scrivesse e leggesse, di proposito, non correttamente; oppure colui che lo facesse non di proposito?”
“Io dico: chi lo fa di proposito; giacché costui sarebbe anche capace di fare il tutto correttamente, se lo volesse”.
“Dunque colui che di proposito scrivesse scorrettamente, sarebbe un letterato; e chi invece lo facesse non di proposito, sarebbe un illetterato?”
“Come potrebbe non essere così?”
“E quale dei due compie opere giuste? Chi sa di mentire ed ingannare di proposito, oppure chi mente e inganna non di proposito?”
“Manifestamente chi lo fa non di proposito”.
“Dunque tu stai dicendo che colui il quale ha scienza delle lettere, è più letterato di chi non ha scienza delle lettere?”
“Sì”.
“E chi ha scienza della giustizia, è più giusto di chi non ne ha scienza?”
“Apparentemente sì; ma anche qui mi sembra di non sapere come collegare queste proposizioni”.
[IV,II,21] “E cosa diresti di colui che vuole mettere insieme la verità, ma non dice mai la stessa cosa sulle medesime cose; che indica sempre la stessa strada, ma una volta afferma che essa porta verso est e un’altra volta sostiene che va verso ovest; che quando effettua una somma, una volta dice che il totale è di più e un’altra volta di meno del vero: ebbene, chi ti pare che sia una persona simile?”
“Sì, per Zeus; è manifesto che costui non sa quello che crede di sapere”.
[IV,II,22] “Sai tu che certe persone sono chiamate ‘servili’?”
“Sì, lo so bene”.
“E sono chiamate così a causa della loro sapienza o della loro ignoranza?”
“Evidentemente, lo sono a causa della loro ignoranza”.
“Prendono questo nome a causa della loro ignoranza della lavorazione dei metalli?”
“No di certo”.
“A causa della loro ignoranza della falegnameria?”
“Neppure per questo”.
“Allora, per la loro ignoranza in fatto di calzoleria?”
“No, neppure per l’ignoranza di uno di questi lavori”, rispose Eutidemo, “anzi, è tutto il contrario. Infatti, è la maggior parte dei conoscitori di questi mestieri che sono indicati come persone servili”.
“Quindi il ‘servilismo’ è appannaggio di tutti coloro i quali non sanno cosa siano le opere virtuose, ossia le opere belle, buone e giuste?”
“A me sembra che sia proprio così”
[IV,II,23] “Pertanto, noi dobbiamo rifuggire in ogni modo possibile dall’essere delle persone servili”.
“Sì, per gli dei, caro Socrate. Con i miei silenzi, io credevo davvero”, continuò allora Eutidemo, “di stare praticando la filosofia; una filosofia grazie alla quale io ero sicuro di essere stato educato a tutte le conoscenze che si confanno ad un uomo dabbene che desidera diventare virtuoso. Adesso cosa penserai di me, vedendomi così scoraggiato e incapace, nonostante tutti gli sforzi che ho fatto, di rispondere a domande su faccende che bisogna conoscere benissimo, e privo una qualunque altra via d’uscita, procedendo sulla quale potrei diventare un uomo migliore?
[IV,II,24] “Ma, Eutidemo, dimmi”, gli chiese allora Socrate, “ti sei già recato qualche volta a Delfi?”
“Sì, per Zeus, mi ci sono recato già due volte”.
“Ed hai notato che nei pressi del tempio c’è un’iscrizione con su scritto ‘Riconosci te stesso’?”
“Certo che l’ho vista”.
“Non ti sei affatto curato di tale iscrizione, oppure le hai prestato attenzione ed hai cercato di esaminare quale sorta di creatura tu sia?”
“Per Zeus, non proprio”, gli rispose Eutidemo, “giacché credevo di conoscerne già benissimo il significato. Infatti sarebbe stato tempo perso, quello impiegato da me per sapere dall’oracolo qualcos’altro, se io neppure conoscessi me stesso”.
[IV,II,25] “Ma a te pare che riconosca se stesso, chiunque semplicemente sa come si chiama? Oppure a riconoscere chi è, è soltanto colui che ha analizzato a fondo se stesso, e che ha riconosciuto come sua propria facoltà, la facoltà che lo fa capace di spendersi come uomo tra gli uomini? Proprio come fanno i compratori di cavalli, i quali non credono di conoscere il cavallo che vogliono conoscere, prima di avere appurato se esso sia docile o indocile, forte o debole, veloce o lento e, in generale, se possieda quelle doti che ne fanno un animale idoneo oppure non idoneo ad una certa attività”.
“A me sembra”, rispose Eutidemo, “che le cose stiano così: colui che non sa di quale facoltà sia naturalmente dotato, ignora chi è”.
[IV,II,26] “Non è manifesto che gli uomini, grazie alla conoscenza di se stessi”, spiegò Socrate, “sperimentano numerosissimi beni; e che invece sperimentano numerosissimi mali, se si sono ingannati su di se stessi? Infatti, coloro che sanno chi sono, sanno cos’è idoneo per loro, e sanno vagliare ciò che possono e ciò che non possono fare. In questo modo, effettuando le opere che essi sanno di poter compiere, si provvedono di ciò di cui abbisognano, e prosperano; mentre da ciò che non sanno si astengono, tenendosi così al riparo dalle aberrazioni ed evitando di passarsela male. E poiché, grazie al fatto di essersi riconosciuti per quello che davvero sono, hanno anche la capacità di valutare il comportamento degli altri uomini; con essi si provvedono di beni e si tengono lontani dai mali. [IV,II,27] Invece, coloro che non si sono riconosciuti per quello che davvero sono, e che si sono ingannati circa la facoltà della quale sono dotati per natura, si dispongono verso gli altri uomini e le altre faccende umane con puro conformismo. Quindi non sanno chi sono, non sanno di cosa hanno bisogno, non sanno cosa stanno facendo né con chi hanno a che fare; e sbagliando in tutte le loro azioni, falliscono l’ottenimento dei beni, e incappano continuamente nei mali. [IV,II,28] Inoltre, coloro che sanno quel che fanno, poiché centrano le mete che si sono proposte, ne ottengono buona fama e sono onorati. Quanti poi sono simili a loro, si intrattengono piacevolmente con essi: e se hanno qualche insuccesso nella propria attività, desiderano i loro consigli; si rivolgono ad essi per averne sostegno; ripongono in essi le loro speranze di miglioramento; e per tutti questi motivi insieme, li hanno cari al di sopra tutti gli altri uomini. [IV,II,29] Invece, coloro che non sanno quel che fanno, poiché operano scelte cattive e falliscono le mete che avranno preso di mira, non soltanto vengono puniti e castigati nel corso stesso di queste attività; ma perdono credito, diventano persone ridicole, disprezzate e vivranno nel disonore”.
“Tu vedi bene”, concluse quindi Socrate, “che questo vale anche nel caso degli Stati. Infatti di essi, quanti ignorano le proprie forze e combattono contro Stati più potenti, alcuni vengono sterminati, mentre altri, da liberi che erano diventano schiavi”.
[IV,II,30] “Socrate, sta pur certo”, gli rispose Eutidemo, “che il ‘riconoscere se stesso’ a me sembra una cosa della massima importanza. Per sapere da dove bisogna cominciare quest’opera di scrutinio di se stessi, io guardo a te, se tu volessi spiegarmelo”.
[IV,II,31] “Dunque, io do per certo”, gli rispose Socrate, “che tu conosca perfettamente quali siano i beni e quali siano i mali”.
“Certamente, per Zeus! Se non sapessi neppure questo, io sarei più stupido degli schiavi!”
“Procedi, dunque; e spiegami quali cose siano beni e quali siano mali”.
“Non è affatto difficile farlo. In primo luogo io ritengo che lo stare in salute sia un bene, e che l’essere ammalato sia un male. Di poi, che lo siano anche le cause dell’uno e dell’altro stato. E che pure le bevande, i cibi, e le cose idonee a promuovere la salute siano dei beni, mentre quelle idonee a promuovere la malattia siano mali”.
[IV,II,32] “Dunque, secondo te, tanto la salute quanto la malattia”, gli chiese Socrate, “qualora fossero causate da qualcosa di buono, sarebbero beni; e se invece fossero causate da qualcosa di male, sarebbero mali?.
“E quando mai”, si stupì Eutidemo, “la salute potrebbe avere quale causa qualcosa che è male, e la malattia qualcosa che è bene?”
“Per Zeus”, gli rispose Socrate, “coloro che prendono parte ad una campagna militare vergognosa, ad una spedizione navale disastrosa, e a molte altre azioni avventurose di questo genere; e che vi partecipano proprio a causa della loro robustezza fisica, periscono. Mentre invece, coloro che non si sono arruolati e sono stati lasciati indietro a causa della loro debolezza fisica, si salvano”.
“Quella che dici è la verità. Ma lo vedi anche tu che questo è vero anche nel caso delle spedizioni avventurose che hanno successo. Giacché anche in questo caso alcuni vi prendono parte a causa della loro robustezza fisica; mentre altri sono lasciati indietro a causa della loro debolezza fisica”.
“Dunque, queste avventure, che a volte finiscono in un successo e a volte in un disastro, sono più bene che male?
“No di certo. Dal tuo ragionamento, di sicuro esse non appaiono essere più bene che male! [IV,II,33] E tuttavia la sapienza è, senza ambiguità alcuna, un bene. Infatti, quale sorta di azione sarebbe effettuata meglio: da chi è sapiente oppure da chi è stolto?”
“Ma dici sul serio? Non hai sentito raccontare”, gli rispose Socrate, “che Dedalo, a causa della sua sapienza, fu fatto catturare da Minosse, fu costretto a fargli da servo e fu privato così sia della patria che della libertà? Nel tentativo di fuggire dalla sua condizione servile insieme al figlio <Icaro>, intanto perse il figlio, e poi non riuscì lui stesso a salvarsi, in quanto fu trasferito forzosamente presso popoli barbari, e visse nuovamente tra di questi in condizioni di schiavitù?”
“Per Zeus, queste sono le storie che si raccontano di lui”.
“E non hai mai sentito raccontare delle sciagure che dovette sopportare Palamede? Tutti i poeti ne cantano le vicende, e come accadde che sia stato fatto perire da Odisseo, il quale lo invidiava per la sua sapienza?”
“Anche queste sono le storie che di lui si narrano”.
“E quante altre persone credi tu che, a causa della loro sapienza, siano state sequestrate e trasferite con la forza presso corti reali, ed ivi siano vissute in condizione servile?”
[IV,II,34] “Socrate, io credo che valga la pena di dare per assolutamente incontrovertibile il fatto che la felicità sia un bene”.
“Eutidemo, a patto però che non si faccia risultare la felicità come qualcosa di composto da un insieme di beni altamente controversi in quanto tali”.
“E quale dei componenti della felicità, sarebbe altamente controverso?”
“Nessuno lo sarebbe, a patto però di non assommare in essa delle componenti come: l’avvenenza fisica, la potenza muscolare, la ricchezza di denaro, la fama e qualcos’altro di siffatto”.
“Ma per Zeus, e invece le assommeremo! Giacché”, insistette Eutidemo, “come potrebbe essere felice, chi è privo di siffatte componenti?”
[IV,II,35] “Sì, per Zeus, le assommeremo”, sbottò Socrate, “e sono proprio queste le componenti dalle quali derivano agli uomini molte esasperanti contrarietà. Infatti, a causa della loro avvenenza fisica, molti dei pretesi ‘felici’ sono stati rovinati da quanti perdono la testa per i bei giovanotti. Molti altri, a causa della loro potenza muscolare, mettono mano ad imprese più grandi di loro, e così incappano in non piccoli malanni. Molti, a causa della loro ricchezza di denaro, periscono svigoriti e soggetti ad ogni sorta di insidie. Molti ancora, a causa della loro fama e del potere politico di cui godono, hanno sofferto grandissimi mali”.
[IV,II,36] “Invero”, constatò Eutidemo, “se io non parlo rettamente neppur quando tesso la lode dell’essere felici, devo ammettere di non sapere più neppure cosa bisogna augurarsi di ottenere dagli dei”.
“Queste cose tu non le hai analizzate a fondo”, disse Socrate, “forse perché avevi molta fiducia di saperle. Ma poiché tu ti stai preparando a presiedere uno Stato democratico, certamente tu sai cos’è la democrazia”.
“Certo, che lo so: lo so a puntino”.
[IV,II,37] “E ti pare possibile sapere cosa sia democrazia, ossia il governo popolare, senza conoscere il popolo?”
“Per Zeus, no; di sicuro non si può”.
“E dunque sai cosa sia il popolo”.
“Credo proprio di saperlo”.
“Quindi, cosa credi che sia il popolo?”
“Io penso che sia l’insieme di tutta la parte povera dei cittadini di uno Stato”.
“E quindi tu conosci i poveri”.
“Come potrei dire di non conoscerli?”
“Pertanto, tu conosci anche i ricchi”.
“Non certo meno di quel che conosco i poveri”.
“E che sorta di individui sono coloro che tu chiami poveri, e coloro che tu chiami ricchi?”
“Poveri sono coloro che riescono appena a sbarcare il lunario; mentre ricchi sono coloro che hanno mezzi più che sufficienti”.
[IV,II,38] “E quindi risulta anche a te che taluni, i quali hanno davvero pochissimi mezzi, non soltanto se li fanno bastare, ma riescono pure a risparmiarne una parte? Mentre invece a coloro che di mezzi ne hanno davvero moltissimi, tutti quelli che hanno non bastano mai?”
“Sì, per Zeus”, rispose Eutidemo, “lo so; e tu fai bene a ricordarmelo. Io so anche che a causa della carenza di mezzi, taluni tiranni sono costretti a commettere dei delitti, come se fossero i più poveri tra i poveri”.
[IV,II,39] “E quindi, se la faccenda sta in questi termini”, concluse Socrate, “includeremo i tiranni tra il popolo; mentre includeremo tra i ricchi coloro che di mezzi ne possiedono ben pochi, ma che riescono addirittura a risparmiarne?”
“È palese che la mia stupidità”, balbettò a questo punto Eutidemo, “mi costringe ad ammettere anche questo. Penso che la miglior cosa da fare, sia per me quella di tacere; visto che sono ormai sull’orlo della franca ammissione di non sapere alcunché”. In preda ad un profondo scoramento, Eutidemo dunque si allontanò, privo ormai di fiducia in se stesso, e giudicando di essere davvero uno schiavo.
[IV,II,40] Molti di coloro che Socrate riduceva in tale stato d’animo, solevano non avvicinarsi mai più a lui; ed erano coloro che Socrate riteneva essere le persone più codarde. Eutidemo, invece, concepì di non avere alcun altro modo per diventare un uomo di valore, se non quello di frequentare il più possibile la compagnia di Socrate. Perciò non tralasciava occasione, a meno che non si trattasse di una necessità inderogabile; ed a volte imitava anche i gesti abituali di lui. Quando Socrate si rese conto della disposizione di Eutidemo nei suoi confronti, ebbe cura di sconcertarlo il meno possibile; gli spiegò sempre, nel modo più semplice e diretto, le cose che egli riteneva che si dovessero sapere; ed anche quali fossero i modi di comportarsi più eccellenti e più idonei.
[IV,III,1] Socrate era uso non sollecitare mai i suoi sodali a diventare abili parlatori, uomini d’affari o persone ingegnose, giacché riteneva che prima di tutto ciò, bisognava che si ingenerasse in essi la temperanza. Egli riteneva infatti che quanti erano dotati di queste capacità, ma erano privi di temperanza, fossero individui più portati all’ingiustizia e a fare del male.
[IV,III,2] Socrate soleva inoltre fare di tutto per fare dei suoi sodali, innanzitutto degli uomini avveduti nel culto degli dei. Taluni riferivano di essere stati presenti, quando Socrate discorreva con altri su questo argomento; ed io stesso ero presente, quando egli ne discusse una volta con Eutidemo nei termini seguenti.
[IV,III,3] “Eutidemo, dimmi un po’: ti è mai avvenuto di rimuginare circa la sollecitudine con la quale gli dei si sono curati di approntare tutto ciò di cui gli uomini hanno bisogno?”
“Per Zeus, no”, gli rispose Eutidemo, “non l’ho fatto”.
“Ma tu sai sicuramente che la prima cosa di cui noi abbiamo bisogno è la luce, e che sono gli dei a fornircela”.
“Sì, per Zeus. Se non ci fosse la luce, a causa degli occhi che abbiamo, saremmo simili a dei ciechi”.
“E poiché noi abbiamo bisogno di intervalli di riposo, tu sai anche che gli dei ci procurano quella bellissima pausa di riposo che è la notte”.
“Bellissima davvero”, assentì Eutidemo, “ed anch’essa degna di gratitudine da parte nostra”.
[IV,III,4] “Dunque tu sai che, essendo lucente, il sole illumina per noi le ore del giorno, e rende visibili tutte le altre cose. Invece la notte, essendo buia, le rende tutte invisibili. E sai anche che gli dei fecero di notte scintillare le stelle, le quali rischiarano per noi le ore notturne, e grazie ad esse noi possiamo effettuare molte cose che ci sono di bisogno”.
“Sì, è così”.
“Inoltre la luna, non soltanto ci rischiara la notte, ma ci rende anche chiaro quali siano le parti del mese”.
“È proprio così”.
[IV,III,5] “Quanto al nostro bisogno di cibo, sai che gli dei fecero in modo che esso si generasse dalla terra e nelle stagioni acconce. Sicché queste stagioni ci procurano il cibo non soltanto in quantità che soddisfano le nostre esigenze, ma anche con grande varietà di forme, e con sapori che ci deliziano”.
“Anche questi sono doni che devono provenirci da dei veri filantropi”.
[IV,III,6] “Tu sai anche che gli dei ci forniscono quel dono di grande valore che è l’acqua, la quale è capace di far germogliare e di far crescere dalla terra e nelle acconce stagioni, ogni sorta di vegetali, tutti a noi utilissimi, con i quali gli dei alimentiamo noi, e mescolandolo a tutti gli altri cibi che ci nutrono, fanno diventare il cibo di più facile digestione, più nutriente e più gradevole al palato. E poiché noi ne abbiamo bisogno in grande quantità, essi ce lo forniscono in grande abbondanza”.
“Tutto ciò”, esclamò Eutidemo, “mostra preveggenza”.
[IV,III,7] “Tu sai anche che il fuoco rappresenta per noi una importante protezione dal freddo e dall’oscurità, un cooperatore in qualunque arte, e nella costruzione di tutti quegli artefatti che gli uomini apprestano per ottenerne dei giovamenti. Per dirla in breve, gli uomini non possono congegnare alcun artefatto che sia di utilità rimarchevole per la loro vita, senza l’impiego del fuoco”.
“Il fuoco è qualcosa”, affermò Eutidemo,” che va addirittura al di là della filantropia”.
[IV,III,8] Tu sai anche che il sole, una volta allontanatosi dalla terra durante l’inverno, poi le si riavvicina; alcune cose facendole maturare ed alcune altre facendole seccare, quando sia venuto il loro momento. Il sole effettua questo movimento senza tuttavia avvicinarsi troppo a noi, e badando bene a rimanere ad una distanza di sicurezza, per non danneggiarci riscaldandoci più del dovuto. E quando si allontana nuovamente dalla terra, anche in questo caso è palese che se esso si allontanasse troppo, noi rimarremmo congelati dal freddo; e quindi il sole torna di nuovo a muoversi verso la terra e le si riavvicina, chiudendo a questo punto un giro completo della volta celeste e compiendo il percorso che è di massimo giovamento per noi”.
“Sì, per Zeus”, esclamò Eutidemo, “anche questi movimenti somigliano a movimenti che avvengono assolutamente ad esclusivo beneficio degli uomini”.
[IV,III,9] “E tu sai anche, poiché ciò è manifesto, che noi non saremmo in grado di sopportare né la gran calura, né il gran gelo, se essi si producessero repentinamente, da un giorno all’altro. Perciò l’avvicinamento e l’allontanamento del sole dalla terra avvengono così gradualmente, che noi raggiungiamo sia l’uno che l’altro dei due estremi, senza essercene accorti”.
“Per parte mia”, affermò allora Eutidemo, “ormai considero che se gli dei lavorano, il loro lavoro è quello di accudire gli uomini. L’unica considerazione che mi intralcia alquanto in proposito, è che di questo trattamento partecipano anche tutti gli altri animali”.
[IV,III,10] “E non è evidente anche questo fatto”, continuò Socrate, “ossia che tutti questi animali sono generati ed allevati ad esclusivo beneficio degli uomini? Dalle capre, dalle pecore, dai buoi, dai cavalli, dagli asini e da tutti gli altri animali, chi ricava una quantità di beni paragonabile a quella che da essi ricavano gli uomini? Anzi, a me sembra che l’uomo tragga ancor più vantaggi dagli animali che dai vegetali. In effetti, gli uomini si nutrono e si arricchiscono, commerciando non certo meno animali che vegetali. Infatti, gran parte del genere umano non utilizza alimenti di origine vegetale, bensì vive nutrendosi del latte, dei formaggi e delle carni ottenuti dal bestiame. Tutti gli uomini, poi, domano ed addomesticano i più profittevoli tra gli animali, e li utilizzano quali adiutori in guerra e per moltissimi altri scopi”.
“Io sono del tuo stesso parere”, acconsentì Eutidemo, “ed osservo che di simili animali, anche quelli molto più robusti di noi diventano così sottomessi all’uomo, che egli può utilizzarli per qualunque lavoro voglia”.
[IV,III,11] “Tu sai anche che gli dei, poiché esistono moltissime cose belle, vantaggiose, e tutte diverse una dall’altra, hanno fornito gli uomini di vari sensi, i quali sono capaci di adattarsi a ciascuna di esse, così che noi si possa fruire d’ogni sorta di beni. Sai inoltre, che gli dei hanno innaturato in noi la contezza delle cose, contezza grazie alla quale noi ci rendiamo conto delle cose delle quali abbiamo sperimentato la sensazione, le fissiamo nella memoria, ci formiamo la comprensione della utilità di ciascuna, ed escogitiamo svariati modi attraverso i quali fruire dei beni e tenerci lontani dai mali. [IV,III,12] Gli dei ci hanno anche elargito la facoltà di esprimere verbalmente i pensieri che concepiamo mentalmente, e grazie ad essi noi possiamo condividere con gli altri ogni sorta di beni attraverso l’insegnamento e, attraverso la comunicazione, stabilire delle leggi ed amministrare lo Stato”.
“Comunque si guardi la faccenda”, notò Eutidemo, “sembra proprio che gli dei si diano un gran da fare in favore degli uomini.”
“Infatti, anche se noi siamo incapaci di preveggenza circa l’utilità degli avvenimenti futuri, tu sai che gli dei cooperano con noi attraverso la mantica, parlando attraverso oracoli a coloro che li interrogano sugli avvenimenti cui andranno incontro, ed insegnando loro per quale via le cose potrebbero andare nel miglior modo possibile”.
“E gli dei, “disse Eutidemo, “sembrano trattare proprio te, Socrate, assai più amichevolmente di come trattino gli altri uomini; se è vero che senza neppur essere interrogati da te, gli dei ti segnalano in anticipo cosa tu debba fare, e cosa tu debba non fare”.
[IV,III,13] “Tu riconoscerai che io ti sto dicendo la verità sugli dei, se per venerarli ed onorali non aspetterai di vederli in carne ed ossa, ma se ti basterà di vederne in atto le opere. Fissati bene in mente, che sono gli dei stessi a scegliere di presentarsi in questa forma. Infatti, di tutti i diversi dei che ci provvedono dei loro beni, neppur uno di essi viene a consegnarceli mostrandosi a viso scoperto. E tanto più farà così quel dio che coordina e mantiene unito il cosmo intero, cosmo in cui tutto è bene e bontà; quel dio che senza posa lo mantiene a nostra disposizione intatto, sano, sempre giovane, più veloce del pensiero nel servirci impeccabilmente. Ebbene, quel dio che effettua le cose più grandiose, neppure si lascia vedere da noi, e pur amministrando tutto ciò ci rimane occulto. [IV,III,14] Fissati bene in mente, che anche quello che tra gli dei sembra essere chiaramente visibile a tutti, ossia il sole, non si presta a lasciarsi vedere distintamente dagli uomini; e che se qualcuno si sforza spudoratamente di guardarlo, viene privato della vista. Troverai che anche i servitori degli dei sono invisibili. Infatti, è palese che il fulmine viene scagliato dall’alto, e che prende il pieno dominio di tutte le cose sulle quali si abbatte. Eppure esso non si lascia vedere né mentre si avvicina, né mentre colpisce, né mentre si allontana. Anche i venti stessi non si lasciano vedere; eppure i risultati di ciò che essi effettuano ci sono evidenti, e noi ci accorgiamo anche dei loro percorsi. Invero, anche l’animo umano, il quale più di ogni altra parte dell’uomo partecipa del divino, e che manifestamente regna in noi: ebbene, neppure esso è visibile”.
“Bisogna che colui il quale capisce queste verità non spregi l’invisibilità degli dei, ma che evinca dagli eventi che accadono la loro potenza e renda onore al démone”.
[IV,III,15] “Quanto a me, caro Socrate, io so per certo”, sospirò Eutidemo, “che mai trascurerò il mio démone neppure per un attimo. E per i benefici che gli dei ci elargiscono, a scoraggiarmi alquanto mi sembra soltanto il pensiero che nessun uomo riuscirà mai a ricambiarli con ringraziamenti degni di loro”.
[IV,III,16] “Mio caro Eutidemo”, lo consolò Socrate, “non lasciarti scoraggiare da questo pensiero. Tu vedi bene, infatti, che quando il dio di Delfi viene interrogato sul modo in cui sia possibile ringraziare gli dei, egli risponde sempre: ‘Osserva le leggi dello Stato’. Le leggi esistono certamente dappertutto, e dunque è possibile rendersi graditi agli dei con offerte sacrificali secondo la legge, ed adeguate alle disponibilità di ciascuno di noi. Pertanto, quale modo c’è di rendere onore agli dei, che sia più bello e più pio del fare ciò che proprio essi comandano? [IV,III,17] Ma bisogna che l’offerente non rimanga mai al di sotto delle proprie possibilità di spesa, giacché qualora non faccia così, egli mostra chiaramente di non stare onorando gli dei. Bisogna dunque rendere onore agli dei, nulla tralasciando delle nostre possibilità; e poi farsi coraggio e sperare di ottenere da loro i beni più grandi. Infatti, non si mostrerà temperante l’uomo che sperasse di ottenere i beni più grandi da altri, che non sono coloro i quali hanno il potere di essergli del massimo giovamento, né in altro modo che non sia quello di essere loro gradito. E come potrebbe essere gradito agli dei, più che ubbidendo loro in tutto e per tutto?
[IV, III,18] Dicendo queste cose e mettendole lui stesso in opera, Socrate preparava i suoi sodali a diventare più pii e più temperanti”.
[IV,IV,1] Invero, Socrate non nascose mai le sue convinzioni sulla Giustizia, e lo dimostrò nei fatti. In privato, comportandosi secondo la legge e in modo collaborativo con tutti; e in pubblico, ubbidendo alle autorità costituite ed a quanto ordinavano le leggi, tanto nel servizio civile quanto nelle campagne militari: talché egli era più che manifestamente un modello di disciplina per tutti. [IV,IV,2] Mentre era presidente di Assemblea, egli non consentì al popolo di procedere ad una votazione che era illegale, e basandosi sulle leggi, si oppose ad una simile iniziativa popolare, la quale io credo che nessun altro uomo sarebbe stato capace di contrastare. [IV,IV,3] Quando i Trenta gli ingiungevano di fare qualcosa di contrario alla legge, Socrate non ubbidiva loro. Egli quindi disobbedì ai loro ordini di non discutere con i giovani; e quando i Trenta comandarono a lui e ad altri cittadini di procedere all’arresto di un uomo condannato a morte, Socrate fu il solo che si rifiutò di obbedire, poiché l’ordine che aveva ricevuto era illegale. [IV,IV,4] Nei tribunali Ateniesi, gli imputati solevano, contro la legge, implorare la grazia dai giudici, adularli, dichiararsi in stato di grave bisogno, e quando ricorrevano a sotterfugi del genere, spesso molti di loro venivano assolti. Quando si trattò di difendersi dalle accuse di Meleto, Socrate si tenne ben lontano da simili pratiche. Egli non volle usare alcuno dei mezzucci contrari alla legge che venivano solitamente impiegati dai processati, mezzucci grazie ai quali egli, pur utilizzandoli con moderazione, sarebbe stato facilmente assolto dai giudici; e scelse piuttosto di morire conformandosi in tutto e per tutto alla legge, piuttosto che sopravvivere da fuorilegge.
[IV,IV,5] Molte volte capitò che Socrate parlasse in questi termini anche con altre persone. Io so per certo, che in una occasione egli discusse con Ippia di Elide, su questioni concernenti la giustizia. Ippia si era tenuto lontano da Atene a lungo, e quando vi ritornò, si imbatté in Socrate che stava discutendo con certe persone. Socrate faceva notare come sia stupefacente il fatto che chi vuole che a qualcuno sia insegnata l’arte del calzolaio, o quella del falegname, o del fabbro, o del cavalcare, non ha dubbio alcuno sulla persona alla quale rivolgersi per ottenere ciò. [Taluni dicono anche che se qualcuno vuole fare di un cavallo o di un bue, giusto quell’animale che deve essere, egli ha a sua disposizione schiere di maestri] Invece, chi vorrà imparare egli stesso cosa sia giusto, oppure vorrà che il giusto sia insegnato ad un suo figlio o ad un suo domestico, non sa a quale persona rivolgersi per ottenere ciò.
[IV,IV,6] Dunque Ippia, udendo Socrate fare queste affermazioni, lo squadrò ben bene e gli disse: ”Ma tu continui a dire ancora oggi, le stesse cose che io ti ho già sentito dire tanto tempo fa?”
“Caro Ippia”, gli rispose Socrate, “ciò che trovo ancora più straordinario, è il fatto che io non soltanto continui a dire le stesse cose, ma che continui a discutere sempre delle stesse questioni. Tu invece, forse perché sei un tuttologo, sui medesimi argomenti non dici mai le medesime cose”.
“Lascia stare”, gli ribatté Ippia, “il fatto è che io provo a dire ogni volta qualcosa di nuovo”.
[IV,IV,7] “Dunque, circa la tua scienza del tutto”, continuò Socrate, “quale delle due cose è vera? Per esempio: se qualcuno ti interroga su quante e quali siano le lettere che compongono il nome ‘Socrate’, tu un tempo dicevi una cosa, mentre invece adesso cerchi di trovare il modo di dirne un’altra? Oppure, a coloro che ti interrogano circa i numeri, chiedendoti se 2 volte 5 fa 10, tu non confermi adesso la risposta che davi un tempo?”
“Su queste questioni, caro Socrate, anch’io, come te, continuo a dare le stesse risposte che davo una volta. Invece, circa il ‘giusto’ io credo di poter esporre, adesso, delle dimostrazioni che né tu né alcun altro potrebbe contraddire”.
[IV,IV,8] “Per Era”, sobbalzò Socrate, “stai accennando ad una grandissima scoperta. Una scoperta che farà smettere i giudici di votare per l’assoluzione e per la condanna; farà smettere i cittadini di affermare che si perpetrano delle ingiustizie, smettere di inoltrare denunce e di litigare dividendosi in fazioni; farà smettere gli Stati di contrapporsi gli uni agli altri sui propri diritti, e di farsi la guerra. Io non so proprio come potrei abbandonarti, prima di averti sentito parlare di una scoperta di tale valore ed importanza”.
[IV,IV,9] “Ma per Zeus”, gli rispose Ippia, “non mi sentirai dire una sola parola, se prima tu non avrai ben chiarito che cosa intendi per ‘giustizia’. Ormai ne ho abbastanza del tuo modo di mettere in ridicolo gli altri, facendo loro delle domande e contestando le risposte di tutti; mentre non vuoi mai rendere conto di nulla, né chiarire apertamente la tua convinzione su qualcosa”.
[IV,IV,10] “Ma cosa stai dicendo, Ippia? Non ti sei accorto”, protestò Socrate, “che io non smetto un solo istante di mettere in evidenza cosa a me pare essere giusto?”
“E quali sono” chiese Ippia, “le parole che usi per definire il giusto?”
“Se non lo esprimo a parole, di certo lo metto in evidenza con i fatti. Oppure, a te pare che i fatti non siano una testimonianza molto più convincente delle parole?”
“Sì, certo è così, per Zeus! Giacché molti di coloro che parlano di giustizia”, disse Ippia, “sono autori di ingiustizie; mentre neppure uno solo di coloro che fanno cose giuste, potrebbe essere chiamato ingiusto”.
[IV,IV,11] “Ti sei mai accorto, anche per una volta sola, che io abbia reso una falsa testimonianza, o che io sia stato un delatore, o che abbia agito per trascinare degli amici o lo Stato in una lotta di fazioni, o che io sia stato l’autore di un’ingiustizia?”
“No, mai”, rispose Ippia, “ti ho visto fare alcunché del genere”
“Allora, non ritieni anche tu”, insistette Socrate, “che l’astenersi dalle opere ingiuste, coincida con l’essere giusto?”
“Caro Socrate, è manifesto che pure adesso”, sottolineò Ippia, “tu stai mettendo in opera il tuo solito modo di sfuggire alla richiesta di mostrare quale sia la tua convinzione su ciò che legittimi essere giusto. Tu, infatti, stai chiacchierando non di cosa effettuano i giusti, ma di cosa essi non effettuano”.
[IV,IV,12] “Quanto a me”, ribatté Socrate, “io credevo fermamente che il rifiutarsi di commettere un’ingiustizia, fosse una prova sufficiente di giustizia. Se a te pare che non sia così, vedi se ti garba di più quest’altra definizione: io affermo che giusto è ciò che è legale”.
“Dunque, tu stai dicendo che il giusto e il legale sono la stessa cosa?”
[IV,IV,13] “Sì, questa è la mia risposta”
“Non riesco a rendermi conto di quale ‘legale’ e di quale sorta di ‘giusto’ tu stia parlando”.
“Tu conosci”, chiese Socrate”, l’esistenza di leggi dello Stato?”
“Sì, certamente”.
“E quali sono le leggi che tu ritieni essere leggi dello Stato?”
“Quelle che i cittadini”, rispose Ippia, “riuniti in Assemblea, abbiano scritto, riguardo alle azioni che si devono effettuare e alle azioni dalle quali ci si deve astenere”.
“Pertanto, agirebbe legalmente”, precisò Socrate, “il cittadino che si comporta in armonia con queste leggi, e invece agirebbe contro la legalità, chi queste leggi le viola?”
“Proprio così”.
“Dunque, effettuerebbe azioni giuste”, ribadì Socrate. “colui che obbedisce a queste leggi, ed invece azioni ingiuste chi a queste leggi disubbidisce”.
“Certamente, è così”.
“Pertanto”, concluse Socrate, “colui che effettua azioni giuste è giusto, mentre chi effettua azioni ingiuste è ingiusto”.
“E come potrebbe essere diversamente?”
“Ne consegue”, concluse Socrate, “che chi opera secondo i dettami della legge è giusto, e chi opera contro i dettami della legge è ingiusto”.
[IV,IV,14] “Caro Socrate”, replicò Ippia, “ma davvero qualcuno potrebbe ritenere le leggi una cosa seria ed obbedire loro, se spesso gli autori stessi delle leggi, le rigettano e le cambiano?”
“Dici così perché gli Stati che hanno intrapreso una guerra”, gli chiese Socrate, “spesso fanno poi di nuovo la pace?”.
“Sì certamente, questo accade”.
“Dunque tu ritieni vile gentaglia coloro che obbediscono alle leggi, sulla base del fatto che le leggi potrebbero poi essere cambiate o annullate. Ebbene, parlando così, cos’altro credi tu di stare facendo, che sia diverso dal denigrare coloro che hanno valorosamente combattuto nelle guerre, sulla base del fatto che poi ne sarebbe seguita la pace? O diverso dal biasimare coloro che sono coraggiosamente corsi in aiuto della loro patria in guerra?”
[IV,IV,15] “Per Zeus, no! Non è questo il mio pensiero!”
“Ma ti sei reso conto”, gli spiegò allora Socrate, “che lo Spartano Licurgo altro non fece di diverso da ciò che facevano tutti gli altri Stati, se non che mise al primo posto, quale dovere supremo, quello di obbedire alle leggi? Tra coloro che governano gli Stati, non sai che i più capaci di far sì che i cittadini obbediscano alle leggi, sono i migliori governanti; e che lo Stato nel quale i cittadini massimamente obbediscono alle leggi, è quello che primeggia in tempo di pace, e che è invincibile in tempo di guerra? [IV,IV,16] Invero, anche la concordia tra i cittadini appare essere per gli Stati un grandissimo bene. Ed in essi, un numero infinito di volte, le Assemblee degli anziani e i loro uomini migliori, raccomandano ai cittadini la concordia. Dappertutto, in Grecia, esiste poi una legge secondo la quale i Greci giurano che osserveranno la concordia; e dappertutto viene fatto questo giuramento. Io credo che tutto ciò avvenga, non affinché i cittadini scelgano tutti i medesimi cori, lodino i medesimi flautisti, preferiscano gli stessi poeti, si compiacciano delle stesse cose, bensì affinché essi obbediscano alle leggi. Quando i cittadini si mantengono obbedienti alle leggi, gli Stati diventano più potenti e più prosperi. Senza concordia, nessuno Stato potrebbe essere governato bene, né una casa amministrata nel modo migliore. [IV,IV,17] E come potrebbe il privato cittadino essere meno punito dallo Stato, e tenuto in maggiore onore dallo stesso, che obbedendo alle sue leggi?. Nei tribunali, come potrebbe andare incontro al minor numero di condanne e al maggior numero di assoluzioni? In chi si avrebbe la maggiore fiducia nell’affidare in custodia del denaro, dei figli o delle figlie? Lo Stato intero, chi riterrebbe più degno di fiducia del cittadino obbediente alla legge? Genitori, parenti, domestici, amici, cittadini, stranieri, da parte di chi otterrebbero il giusto trattamento? I nemici, in chi riporrebbero maggiore fiducia, in fatto di tregue, di trattati, di accordi di pace? Con chi gli Stati vorrebbero diventare alleati, più che con uno Stato rispettoso delle leggi? A quale Stato, gli alleati affiderebbero con più fiducia il comando supremo, il controllo dei confini e la difesa delle città? E chi ha arrecato grandi benefici, da chi penserebbe di aspettarsi gratitudine, più che da chi è obbediente alle leggi? Chi beneficerebbe volentieri taluni, più di coloro che reputa capaci di essergli grati? Chi, uno vorrebbe avere più amico o meno ostile, di colui che sa essere grato? A chi uno farebbe meno la guerra, che a colui dal quale vorrebbe amicizia, il meno possibile di ostilità, e che ha moltissimi amici, del quale tutti vorrebbero essere alleati, ed al quale pochissimi sono ostili e nemici?
[IV,IV,18] “Pertanto, caro Ippia, io dichiaro che ciò che è secondo la legge e ciò che è giusto sono la stessa e identica cosa. Se poi tu conosci una dimostrazione del contrario, spiegamela”.
“Per Zeus, caro Socrate”, gli rispose Ippia, “circa ciò che è ‘giusto’, a me pare di non conoscere alcuna dimostrazione del contrario”.
[IV,IV,19] “Caro Ippia”, gli chiese allora Socrate, “sai tu che esistono delle ‘leggi non scritte’?
“Si, lo so. Sono le leggi che vigono, identiche, in ogni paese”.
“Potresti tu affermare che sono stati gli uomini a stabilirle?”
“E come sarebbe possibile una cosa del genere”, rispose Ippia, “vista l’impossibilità che si siano riuniti tutti insieme, e il fatto che non parlano tutti la stessa lingua?”
“Dunque, da chi ritieni tu che queste leggi siano state stabilite?”
“Io credo che siano stati gli dei a stabilire per gli uomini queste leggi. Infatti, presso tutti gli uomini la prima legge da osservare è quella di venerare gli dei”.
[IV,IV,20] “E quella di onorare i propri genitori”, gli domandò Socrate. “non è anch’essa una legge universalmente valida?”
“Sì, anche questa lo è”.
“E non lo è anche quella che vieta rapporti incestuosi tra genitori e figli e tra figli e genitori?”
“No, Socrate: questa a me pare non essere una legge divina”.
“E perché?”, chiese Socrate.
“Perché mi accorgo”, rispose Ippia, “che taluni la trasgrediscono”.
[IV,IV,21] “Sì, infatti ci sono numerose altre leggi”, disse Socrate, “che gli uomini violano. E tuttavia coloro che trasgrediscono le leggi stabilite dagli dei, ne pagano il fio; giacché l’uomo non può in alcun modo sfuggire alla punizione divina. Questo accade, invece, nel caso delle leggi stabilite dagli uomini, leggi che taluni trasgrediscono riuscendo a non pagarne il fio, alcuni nascondendosi, altri servendosi della violenza”.
[IV,IV,22] “Socrate, ma che sorta di fio è”, chiese Ippia, “quello che non possono sfuggire di pagare i genitori che hanno rapporti incestuosi con i figli, e i figli che hanno rapporti incestuosi con i genitori?”
“Sì, per Zeus”, rispose Socrate, “il fio più grande e più terribile. Quale punizione subirebbero coloro che generano dei figli, che sia peggiore di quella di far male a fare dei figli?”
[IV,IV,23] “Eppure, com’è possibile che questi genitori facciano male a fare figli”, insistette Ippia, “se nulla impedisce che questi figli siano bambini sani generati da genitori sani?”
“Per Zeus”, ribatté Socrate, “è così, giacché bisogna non soltanto che siano sani i bambini generati dal padre e dalla madre, ma anche che questi genitori siano nella pienezza del loro vigore fisico. Oppure a te pare che il seme di un padre e di una madre sia lo stesso, quando essi sono nel loro pieno vigore fisico, quando essi neppure hanno raggiunto la piena maturità fisica, o quando essi sono ormai persone del tutto fiacche e svigorite?”
“Sì, per Zeus”, assentì Ippia, “non è verosimile che quei semi siano tutti della stessa qualità”.
“E pertanto”, chiese Socrate, “quali sono i semi paterni e materni migliori?”
“È evidente”, rispose Ippia, “che i semi migliori sono quelli di chi è nel suo pieno vigore fisico”.
“E dunque i semi di coloro che non sono nel loro pieno vigore fisico”, chiese ancora Socrate, “sono anche di qualità scadente?”
“Per Zeus”, rispose Ippia, “verosimilmente è così”.
“E dunque bisogna”, continuò Socrate, “che persone simili non abbiano dei bambini?”
“Sì, non devono averne”.
“Pertanto”, disse Socrate, “bisogna che quanti non sono ancora nella pienezza del loro vigore fisico non facciano dei bambini?”.
“Io penso”, gli rispose Ippia, “che non debbano farne”.
“E quali altri individui”, domandò ancora Socrate, “farebbero quindi male a fare dei bambini, se non coloro che non sono nella pienezza del loro vigore fisico?”
“Concordo con te”, disse Ippia, “anche su questo punto”.
[IV,IV,24] “E quindi? Non è forse una legge universalmente valida, quella di ricambiare il beneficio ricevuto?”
“Sì, lo è”, rispose Ippia, “ma anche questa legge è violata”.
“Però, anche coloro che violano questa legge”, rispose Socrate, “ne pagano il fio. Infatti essi si isolano così dagli amici virtuosi, e sono costretti a tener dietro a coloro che li odiano. Infatti, non è forse vero che quanti fanno del bene a coloro che frequentano, sono amici virtuosi; mentre coloro che non ricambiano i benefici ricevuti, a causa della loro ingratitudine, diventano odiosi? E poiché è diventato per costoro più a buon prezzo il frequentare gli ingrati, ecco che essi vanno soprattutto dietro a questi”.
“Sì, per Zeus, mio caro Socrate”, disse Ippia, “tutte queste leggi sono verosimilmente opera degli dei. Il fatto che esse abbiano incorporate in loro stesse le punizioni per coloro che le violano, a me sembra essere certamente l’opera di un legislatore molto migliore dell’uomo”.
[IV,IV,25] “Dunque, caro Ippia, ritieni tu che gli dei stabiliscano per legge il ‘giusto’ oppure qualcosa di diverso dal ‘giusto’?”
“Per Zeus, null’altro che il giusto. Giacché è impossibile”, rispose Ippia, “che a stabilirlo sia qualcun altro diverso da un dio”.
“Pertanto l’affermazione che ciò che è giusto e ciò che è secondo la legge siano la stessa cosa, ha il beneplacito anche degli dei”.
Affermando e mettendo in opera queste conclusioni, Socrate rendeva uomini più giusti coloro che lo avvicinavano.
[IV,V,1] Parlerò ora del fatto che Socrate soleva fare dei suoi sodali, delle persone più pratiche e più intraprendenti di prima. Egli riteneva, infatti, che l’essere padrone di sé sia un bene per colui che in futuro effettuerà qualche bella impresa. Per prima cosa, Socrate rendeva dunque evidente ai sodali che egli stesso si era esercitato nella padronanza di sé più di tutti gli altri uomini. Successivamente ne discuteva, e spronava tutti, e in particolar modo i sodali, alla padronanza di sé. [IV,V,2] Egli usava spesso dilungarsi a ricordare coloro che sanno impiegare la virtù in modo proficuo; e richiamare ciò alla memoria di tutti i suoi sodali. Io l’ho anche visto dialogare con Eutidemo, nel modo che ora dirò, sulla padronanza di sé.
“Dimmi un po’, Eutidemo: ritieni tu”, gli chiese Socrate, “che la libertà sia, tanto per l’uomo quanto per lo Stato, un possesso bellissimo e grandioso?”
“Sì, più di qualunque altro possesso”, rispose Eutidemo.
[IV,V,3] “Pertanto, chiunque si lascia comandare dai piaceri del corpo; a causa di ciò non può effettuare alcunché di nobile. Ebbene, ritieni tu che costui sia un uomo libero?”
“No, niente affatto libero”
“Posso azzardarmi ad affermare che, secondo te, un atto è libero quando con esso si effettuano le imprese più nobili; e che invece è una condizione di schiavitù, quella di chi ha dei padroni che gli impediscono di effettuare tali nobili imprese?”
“Sì, in tutti i sensi”.
[IV,V,4] “Quindi, a te pare che quanti sono non padroni di se stessi, sono a tutti gli effetti degli schiavi?”
“Sì, per Zeus, è ovvio che lo sono”.
“E coloro che sono non padroni di se stessi, secondo te sono soltanto impediti a compiere delle nobili imprese, oppure sono anche costretti ad effettuare le azioni più vergognose?”
“A me sembra”, rispose Eutidemo, “che essi siano impediti tanto quanto sono costretti”.
[IV,V,5] “Che sorta di padroni ritieni tu che siano, coloro che impediscono l’effettuazione di nobili imprese, e che costringono ad effettuare le azioni più vergognose?”
“Per Zeus, sono i padroni peggiori possibili”.
“E quale sorta di schiavitù, ritieni tu che sia la peggiore possibile?”
“Io penso”, rispose Eutidemo, “che sia quella che si patisce stando presso i peggiori padroni”.
“Dunque, coloro che sono non padroni di se stessi, patiscono la peggiore delle schiavitù possibili?”
“Così a me pare che sia”.
[IV,V,6] “Non pare a te che il sommo bene sia la sapienza, quella che tiene gli uomini lontani dalla schiavitù; e che sia proprio la non padronanza di sé a ridurli in schiavitù? E non ti pare anche che sia la non padronanza di sé ad impedirci di prestare attenzione e di capire cosa ci giova davvero, trascinandoci così ai piaceri del corpo; e quella che molte volte, abbattendo la nostra percezione dei beni e dei mali, ci fa scegliere l’effettuazione del peggio e non del meglio?”
[IV,V,7] “ Proprio questo è ciò che accade”, confermò Eutidemo.
“E circa la temperanza, caro Eutidemo, a chi diremmo che essa nulla ha a che fare, e meno che con chiunque altro, proprio con colui che manca di padronanza di sé? Infatti, le azioni di chi è non padrone di sé, sono l’esatto opposto di quelle di chi è temperante”.
“Sono d’accordo con te anche su questo”.
“Credi tu che esista un inibitore delle azioni nobili e virtuose che si confanno all’uomo, più potente della non padronanza di sé?”
“No, penso che non esista”.
“E della facoltà che fa l’uomo capace di prescegliere le azioni che lo danneggiano invece di quelle che gli giovano, che lo persuade a darsi cura delle prime ed a trascurare le seconde; e che costringe invece gli uomini temperanti a fare tutto il contrario: ebbene credi tu che esista qualche male peggiore di questo per l’uomo?”
“Nessun male può essere peggiore di questo”
[IV,V,8] “Pertanto, appare verosimile che la padronanza di sé sia, per gli uomini, la causa di quelle azioni che sono tutto il contrario delle azioni causate dalla non padronanza di sé”.
“È assolutamente così”.
“Dunque, appare anche verosimile ritenere che la facoltà che è causa delle azioni opposte sia la facoltà in assoluto più nobile e migliore di tutte?”
“Sì, è verosimile”.
“Ed è anche verosimile, caro Eutidemo, che ad essere migliore per l’uomo sia la padronanza di sé?”
“Sì, Socrate: è verosimile che così sia”.
[IV,V,9] “Hai mai rimuginato tra te e te, Eutidemo, questo fatto?”
“Quale fatto?”
“Il fatto che alla festosa soddisfazione dei sensi, unicamente verso i quali la non padronanza di sé sembra trascinare gli uomini; questa da sola non è però capace di trascinarli; mentre invece la padronanza di sé permette all’uomo di godere pienamente di tali piaceri”.
“Com’è possibile una cosa del genere?”
“La non padronanza di sé non ci permette di resistere alla fame, né alla sete, né alla smania di piaceri sessuali, né al vigilare vegliando. Queste sono tutte attività, grazie alle quali soltanto è possibile mangiare con vero piacere, bere con piacere, avere con piacere rapporti sessuali; e altrettanto piacevolmente prendersi una pausa da essi, concedersi il tempo di riposare, sopportare senza affanno ed aspettare con pazienza fino al momento in cui tali piaceri diventeranno un piacere unico. La non padronanza di sé è quella che vieta, per intrinseca coerenza, ai suoi più coatti e più irrefragabili seguaci di provare un piacere che sia in armonia con la natura delle cose. Al contrario, la padronanza di sé è la sola virtù che ci fa resistere alle debolezze citate e che ci fa provare piacere in un modo che, su quanto sono venuto dicendo, è degno d’essere ricordato”.
“Socrate, tu stai dicendo l’assoluta verità”.
[IV,V,10] “Inoltre, l’apprendere qualcosa di nobile e di bello, l’applicarsi alla pratica delle virtù grazie alle quali l’uomo riuscirebbe a trattare bene il proprio corpo, a governare bene la propria casa, a giovare ai propri amici e allo Stato, ad avere il sopravvento sui suoi nemici personali: ecco, queste sono tutte opere dall’effettuazione delle quali si traggono non soltanto dei vantaggi, ma anche dei grandi piaceri. Piaceri dei quali, però, possono fruire unicamente coloro che sono padroni di se stessi, mentre coloro che sono non padroni di se stessi, non possono avere parte alcuna in siffatti piaceri. Di chi diremo, quindi, che meno di tutti ha a che fare con tali piaceri; se non colui che è del tutto impossibilitato ad effettuare quelle tali azioni, giacché si tiene ben lontano dall’impegnarsi in altro che non siano i piaceri più triviali?”
[IV,V,11] “Caro Socrate”, concluse allora Eutidemo, “a me sembra che tu stia dicendo questo: l’uomo che si lascia ogni volta sconfiggere dai piaceri del corpo, nulla ha che fare con una qualsiasi virtù”.
“Sì, Eutidemo. Qual è infatti la differenza tra un uomo che non ha padronanza di sé, e la più incolta delle belve? Infatti, chiunque non tiene in considerazione le facoltà superiori che possiede, e cerca invece in tutti i modi di soddisfare il piacere dei sensi, in che cosa differirebbe dal bestiame più infoiato? Invece, è soltanto agli uomini padroni di sé, che è dato di tenere in considerazione le faccende della massima importanza, e distinguendole secondo il genere, tanto nelle parole quanto nei fatti, prescegliere per sé i beni ed astenersi dai mali”.
[IV,V,12] Operando in questo modo, Socrate diceva che si diventa uomini migliori, più felici e più abili nel dialogare. Egli spiegava anche che il termine ‘dialogare’ deriva dal fatto che quanti si riuniscono insieme per deliberare su diverse faccende, le prendono in esame una alla volta, essendo esse già state suddivise in precedenza, faccenda per faccenda. Bisogna dunque sforzarsi al massimo grado per essere pronti ad ottenere questo risultato, e prendersene ogni cura. È da ciò che nascono uomini nobilissimi, capacissimi di comandare e di discutere.
[IV,VI,1] Proverò ora a parlare anche del modo in cui Socrate migliorava l’abilità di discutere dei suoi sodali. Egli riteneva infatti, che quanti sono edotti del “cos’è” di ciascuna cosa, possono anche spiegarlo agli altri. Circa coloro, invece, che non ne sono edotti, egli affermava anche che non c’è nulla di stupefacente nel fatto che essi cadano in errore, e che facciano quindi cadere in errore anche gli altri. Per questo motivo egli non cessava mai di considerare attentamente, insieme ai suoi sodali, il “cos’è” di ciascuna cosa.
Comunque, il dettagliare il modo in cui egli arrivava ad una definizione, sarebbe un’opera improba. Tra le tante, parlerò soltanto di alcune definizioni che, io credo, bastano a chiarire il suo modo di esaminarle.
[IV,VI,2] Quale primo esempio, circa il ‘culto degli dei’, egli così ne esaminava la definizione.
“Dimmi un po’, Eutidemo, cosa ritieni tu che sia il culto degli dei?”
“Per Zeus, che sia una cosa bellissima”, gli rispose Eutidemo.
“Sei in grado di dirmi che sorta di uomo sia colui che pratica il culto degli dei?”
“A me pare che sia colui che rende onore agli dei”.
“E costui ha la potestà di onorare gli dei, qualunque sia il modo in cui egli decide di onorarli?”
“No, perché ci sono delle leggi, in osservanza delle quali bisogna onorare gli dei”.
[IV,VI,3] “Dunque, chi conosce queste leggi, conoscerebbe anche il modo in cui si deve rendere onore agli dei?”
”Io credo di sì”, rispose Eutidemo.
“Quindi, colui che sa come si deve rendere onore agli dei, ritiene anche che lo si debba effettuare non diversamente da quello che è a sua conoscenza?”
“Certo, non diversamente”.
“E c’è qualcuno che rende onore agli dei, diversamente dal modo in cui egli crede che si debba?”
[IV,VI,4] “No, io credo che non ci sia”.
“Dunque, chi conosce le leggi che riguardano gli dei, onorerebbe gli dei in modo conforme alle leggi?”
“Sì, assolutamente sì”.
“Pertanto, chi onora gli dei in modo conforme alla legge, rende loro onore?”
“E come potrebbe essere diversamente?”
“E colui che rende onore agli dei è un uomo pio?”
“Certamente sì”.
“Dunque colui che conosce ciò che è conforme alla legge, secondo noi sarebbe rettamente definito un uomo pio?
“A me pare che sia così”.
[IV,VI,5] “E nelle relazioni che si hanno con gli uomini, uno ha la potestà di trattarli in qualunque modo gli paia?”
“No; giacché anche a questo proposito esistono delle leggi alle quali ci si deve conformare”.
“Dunque, coloro che si conformano vicendevolmente alle leggi stabilite, si comportano come si deve?”
“Sicuramente. Come potrebbe essere altrimenti?”
“Dunque, coloro che si comportano come si deve, si comportano bene?”
“Assolutamente sì”, rispose Eutidemo.
“Quindi, coloro che si comportano bene con gli uomini, sbrigano bene le umane faccende?”
“Verosimilmente sì”.
“Pertanto, coloro che obbediscono alle leggi sono anche coloro che rispettano la giustizia?”
“Certamente sì”, rispose Eutidemo.
[IV,VI,6] “Sai tu”, gli chiese allora Socrate, “quali siano le azioni che sono chiamate ‘giuste’?”
“Sono quelle che le leggi comandano di fare”.
“Quindi coloro che fanno le azioni che le leggi comandano di fare, fanno anche le azioni giuste e dovute?”
“Come potrebbe essere altrimenti?”
“E coloro che fanno azioni giuste, sono anche uomini giusti?”
“Io credo proprio di sì”.
“Credi tu che taluni possano obbedire alle leggi, senza sapere quel che le leggi comandano di fare?”
“No, io credo che ciò sia impossibile”
“E credi tu che tra coloro che sanno cosa la legge dice di fare, ve ne siano alcuni i quali non fanno quel che invece si deve fare?”
“Io non lo credo”.
“E sai tu se ci siano taluni i quali fanno, non ciò che essi credono si debba fare, ma qualcos’altro?”
“Io non lo so”.
“Quindi, coloro che conoscono quali siano le leggi che devono regolare i rapporti tra gli uomini, sono anche coloro che effettuano le giuste azioni?”
“Sì, è proprio così”, rispose Eutidemo.
“Dunque, tutti coloro che effettuano le azioni giuste, sono uomini giusti?”
“Come potrebbe essere altrimenti?”
“Pertanto, definendo uomini ‘giusti’ coloro che conoscono le leggi che regolano le relazioni tra gli uomini, noi daremmo di loro la retta definizione?”
“A me sembra di sì”
[IV,VI,7] “E la sapienza? Cosa potremmo dire che essa è? Dimmi, Eutidemo: i sapienti pare a te che siano sapienti per le conoscenze certe che hanno, oppure ci sono taluni che sono sapienti di cose delle quali non hanno conoscenza certa?”
“Manifestamente di cose delle quali hanno conoscenza certa”, rispose Eutidemo. “Come si potrebbe mai essere sapienti di cose di cui non si ha conoscenza certa?”
“Pertanto i sapienti sono sapienti per le conoscenze certe che hanno?”
“Per cos’altro uno potrebbe essere sapiente, se non per la sua conoscenza certa?”
“Credi tu che la sapienza sia altro da ciò per cui gli uomini sono sapienti?”
“No, io non credo”.
“Dunque la conoscenza certa è la sapienza?”
“A me pare di sì”.
“E a te sembra che per l’uomo sia possibile avere conoscenza certa di tutte le cose esistenti?”
“No, per Zeus. Secondo me soltanto di un limitato numero di esse”.
“Quindi l’uomo non è all’altezza di essere sapiente di tutte le cose?”
“Per Zeus, certo che non ne è all’altezza”.
“Pertanto, ciascuno è sapiente soltanto di ciò di cui ha conoscenza certa?”
“A me pare che sia così”.
[IV,VI,8] “Dunque, caro Eutidemo, anche la ricerca su cosa sia il ‘bene’ va effettuata in questo modo?”
“Cosa intendi dire?”
“Ti sembra che la medesima cosa possa essere giovevole a tutti?”
“Io penso di no”.
“E dunque. Non ti pare che quanto è di giovamento ad una persona, a volte possa essere dannoso ad un’altra?
“Certamente”.
“Tu diresti che il ‘bene’ è qualcosa di diverso da ciò che è giovevole?”
“Io proprio non lo direi”, rispose Eutidemo.
“Dunque ciò che è giovevole è anche un ‘bene’ per colui al quale esso è giovevole?”
“Così mi sembra”.
[IV,VI,9] “E circa il ‘bello’, potremmo noi parlarne in un modo diverso dal modo in cui se ne parla quando denomini ‘bello’ un corpo, una suppellettile, o qualunque altra cosa che sai essere, a tutti gli effetti ‘bella’?”
“Per Zeus, certo che no”, raspose Eutidemo.
“Quindi, data una qualunque cosa che sia proficuo usare, è bello che ciascuno questa cosa la utilizzi?”
“A me pare proprio di sì”.
“Ed è bello che ciascuno utilizzi una certa cosa, per un qualche uso diverso da quello per cui è bello che essa sia utilizzata?”
“Non certo per qualche uso diverso”, rispose Eutidemo.
“Pertanto, ciò che è proficuo è bello per ciò per cui esso sia proficuo?”
“Sì, per nessun altro uso”.
[IV,VI,10] “Quanto alla ‘virilità’, caro Eutidemo, ritieni tu che essa sia una cosa bella?”
“Ritengo, anzi, che essa sia il più bello dei beni”.
“Ritieni che essa sia proficua, e non soltanto per le cose di poco conto?”
“Per Zeus, ritengo che essa, anzi, lo sia per le cose della massima importanza”.
“E ti pare che dinanzi ad eventi terribili e pericolosi, sia proficuo l’ignorarli?”
“Per nulla proficuo”.
“E coloro che dinanzi ad eventi siffatti non hanno paura, perché non sanno di che cosa si tratti, sono individui privi di virilità?”
“Sì, per Zeus, ne sono privi”, rispose Eutidemo, “Giacché in tal caso anche schiere di pazzi e di vigliacchi, sarebbero individui virili”.
“E cosa diresti di coloro che hanno timore anche di ciò che non è affatto terribile?”
“Direi che si tratta di individui ancora meno virili”.
“Dunque, tu ritieni che davanti ad eventi terribili e pericolosi, gli uomini dabbene si comportano virilmente; e che gli uomini malvagi si comportano invece da vigliacchi?”
“Assolutamente sì”.
[IV,VI,11] “Tu ritieni che davanti a siffatti eventi siano dabbene anche altri uomini, oltre coloro che sono capaci di comportarsi bene dinanzi ad essi?”
“Altri uomini, no; ma soltanto questi”, rispose Eutidemo.
“E coloro i quali si comportano male dinanzi a siffatti eventi, sono uomini malvagi?”
“Quali altri sono uomini malvagi, se non costoro?”, rispose Eutidemo.
“E ciascuno di costoro si comporta come crede che si debba fare?”
“E come potrebbe comportarsi in modo diverso?”, rispose Eutidemo
“Dunque, coloro che sono incapaci di comportarsi bene, sanno come bisogna comportarsi?”
“Di sicuro non lo sanno”, rispose Eutidemo.
“E coloro che sanno come bisogna comportarsi, sono anche quelli che hanno la capacità di farlo?”
“Sono i soli a poterlo fare”, rispose Eutidemo.
“E coloro che non si sono sbagliati, si comportano forse male dinanzi siffatti eventi?”
“Credo di no”, rispose Eutidemo.
“Dunque sono coloro che si sono sbagliati a comportarsi male dinanzi a siffatti eventi?”
“Verosimilmente è così”, rispose Eutidemo.
“Dunque, coloro che sanno comportarsi bene dinanzi agli eventi terribili e pericolosi, sono uomini virili; mentre coloro che sbagliano il modo di comportarsi, sono dei vigliacchi?”
“A me pare che sia così”, concluse Eutidemo.
[IV,VI,12] Socrate riteneva che il governo di un sovrano e il governo di un tiranno, fossero entrambe forme di governo, che però egli valutava ben differenti una dall’altra. Infatti, egli considerava governo ‘sovrano’, quel governo che aveva il consenso di tutti i cittadini e che obbediva alle leggi dello Stato. Invece, il governo che mancava del consenso di tutti i cittadini e che non obbediva alle leggi dello Stato, bensì alle sole decisioni di chi comandava, egli lo chiamava ‘tirannide’. Inoltre, laddove le cariche di governo erano ricoperte dagli ottimati, Socrate riteneva che questa forma di governo fosse ‘aristocratica’. Che laddove le cariche di governo fossero assegnate in base al censo, egli chiamava questa forma di governo ‘plutocratica’. E laddove tali cariche fossero invece aperte a tutti, egli chiamava questa forma di governo ‘democratica’. [IV,VI,13] Quando poi qualcuno faceva a Socrate delle obiezioni, senza avere nulla di chiaro da dire; ed asseriva, senza dimostrazione alcuna, che un certo tale è più sapiente di altri, oppure che è un politico più fine, oppure che è più virile o qualcos’altro del genere; Socrate riportava indietro tutto il discorso all’ipotesi iniziale, più o meno nel modo seguente.
[IV,VI,14] “Tu stai affermando che il cittadino che tu lodi è migliore del cittadino che lodo io?”
“Si, lo affermo”
“Come mai non abbiamo in precedenza preso in esame quale sia l’operato di un cittadino dabbene?”
“Facciamolo adesso”.
“Nella gestione del denaro pubblico, non prevarrebbe colui che rende lo Stato più prospero?
“Certamente sì”, rispose quel tale.
“E in una guerra, colui che fa prevalere il suo Stato sugli avversari?”
“E come no”.
“E in una ambasceria, colui che fa in modo di trasformare i nemici in amici?”
“Verosimilmente sì”.
“Quindi, anche nel caso di un discorso al popolo, colui che fa cessare la guerra civile e ingenera concordia tra i cittadini?”
“A me sembra proprio di sì”.
In questo modo, riportando indietro tutto il discorso all’ipotesi iniziale, la verità diventava evidente anche a coloro che avevano mosso a Socrate delle obiezioni.
[IV,VI,15] Ogni qualvolta Socrate esponeva un ragionamento, seguiva un percorso a tappe, segnate dalla generale condivisione delle sue affermazioni; ritenendo che questa fosse una garanzia della correttezza del proprio ragionamento. Ne conseguiva, che nei tantissimi discorsi che io l’ho sentito fare; qualunque cosa dicesse, egli riusciva a rendere i suoi ascoltatori disposti all’assenso. Egli soleva anche dire che Omero concede ad Odisseo la palma di oratore più convincente di tutti, in quanto capace di condurre per mano chi ascolta attraverso percorsi ben noti e condivisi dagli uomini di qualche valore.
[IV,VII,1] Da quanto sono venuto dicendo, a me pare evidente che Socrate, con coloro coi quali conversava, metteva sempre in evidenza il proprio punto di vista con grande semplicità e chiarezza. Accennerò, adesso, anche al fatto che egli usava prendersi ogni cura affinché che ciascuno di coloro coi quali discuteva, si sentisse autonomo ed a proprio agio nell’attività pratica che gli si confaceva. Di tutti coloro che io ho conosciuto, Socrate era colui che massimamente ci teneva a sapere di che cosa ciascuno dei suoi sodali avesse una specifica ed approfondita competenza. Quanto a ciò che all’uomo dabbene conviene conoscere, e che Socrate sapeva, egli lo insegnava con sommo zelo; mentre su ciò di cui si sentiva inesperto, egli conduceva i suoi interlocutori presso coloro che ne erano esperti. [IV,VII,2] Socrate insegnava anche fino a quale livello di esperienza di ciascuna faccenda pratica, debba pervenire l’uomo correttamente educato. Per esempio, diceva che della geometria bisogna imparare quanto basta affinché lo studioso di essa diventi capace, quando ne fosse il caso, di misurare esattamente l’area di un pezzo di terra, per acquisirla, per cederla, per suddividerla o per comprovarne la misurazione. Ed aggiungeva che ciò era assai facile da imparare; sicché colui che faceva la misurazione con la dovuta attenzione, poteva poi allontanarsi sapendo quale fosse l’area del pezzo di terra, e conoscendo come si opera una misurazione. [IV,VII,3] Socrate valutava invece negativamente, l’apprendimento della misurazione di forme geometriche desuete; e spiegava di non vedere l’utilità di simili conoscenze, pur non essendone del tutto inesperto. Aggiungeva poi, che l’acquisizione di conoscenze di questo genere, era in grado di consumare la vita intera di un uomo, a scapito di molte altre conoscenze di ben maggiore utilità. [IV,VII,4] Socrate soleva poi esortare a familiarizzarsi con l’astronomia; ma anche in questo caso, solamente quel tanto che basta a poter riconoscere l’arrivo della notte, la stagione, il mese e l’anno, in vista di un viaggio per terra o per mare, o per dei turni di guardia; e in vista di tutte quelle operazioni che si fanno di notte, o in certi mesi oppure in certi anni, così da conoscere esattamente il tempo propizio per ciascuna di esse. Secondo Socrate, anche queste nozioni potevano essere facilmente imparare dai cacciatori notturni, dai piloti di navi, e da molte altre persone, le quali tutte erano interessate ad avere queste conoscenze. [IV,VII,5] Egli deprecava invece fortemente lo studio dell’astronomia, se spinto fino alla conoscenza del percorso dei diversi corpi celesti, delle orbite dei pianeti, della traiettoria delle comete, delle loro distanze dalla terra e delle loro rivoluzioni, logorandosi nella ricerca delle loro cause. Diceva, infatti, di non vedere alcun vantaggio in queste conoscenze, quantunque neppure di queste egli fosse del tutto all’oscuro; e ribadiva che esse erano capaci di logorare la vita di un uomo, a scapito di molte altre utili conoscenze. [IV,VII,6] Quanto ai corpi celesti, e quanto al modo in cui la divinità organizza i movimenti di ciascuno di essi, Socrate, in generale, deprecava che qualcuno se ne preoccupasse, giacché riteneva che tali ragioni non potessero essere scoperte dagli uomini. Pensava, anzi, che chi faceva ricerche su ciò che gli dei avevano deciso che rimanesse ignoto, non rendeva affatto onore agli dei. Affermava anche, che chi investigava questi fenomeni, stava vaneggiando; non meno di quanto vaneggiasse Anassagora, ossia il più grande investigatore di spiegazioni possibili delle meccaniche divine. [IV,VII,7] Anassagora, infatti, sostenendo che il fuoco e il sole erano fatti della stessa materia, non teneva conto del fatto che gli uomini possono facilmente sostenere la vista del fuoco, e che invece non possono guardare il sole; e, inoltre, che quando siano illuminati dalla luce solare, gli uomini si abbronzano, mentre ciò non accade ad opera della luce del semplice fuoco. Anassagora, inoltre, non teneva conto del fatto che tutti i vegetali che germogliano dalla terra, se sono privati della luce solare, non possono crescere bene; e che quando siano riscaldati dal fuoco, tutti i vegetali appassiscono e muoiono. Quando poi Anassagora insisteva sul fatto che il sole fosse una pietra infuocata; oltre al resto, egli ignorava l’evidenza del fatto che una pietra, stando nel fuoco, non getta luce, né essa resiste a lungo nel fuoco, mentre invece il sole è la stella più brillante di tutte, e tale rimane in eterno. [IV,VII,8] Socrate raccomandava, poi, l’apprendimento dell’aritmetica, ma anche in questo caso, ed in modo simile all’apprendimento di altre conoscenze, egli consigliava di evitarne lo studio matto e disperatissimo, e di impararne solo quel tanto che era utile per l’uso pratico; e lui stesso considerava e discuteva con i suoi sodali quanta aritmetica fosse utile per l’uso pratico. [IV,VII,9] Egli incitava quindi i suoi a sodali ad avere ogni cura della propria salute; informandosi, da coloro che ne sono esperti, sulla quantità di cibo da consumare; ed a badare per tutta la vita a quali alimenti, quali bevande e quali esercizi fisici si addicano loro meglio, così da poter vivere in buona salute il più a lungo possibile. Ed assicurava anche, che chi si prendeva una simile cura di se stesso, avrebbe fatto fatica a scovare un medico che meglio di lui conoscesse quali erano le cure più utili ed adatte alla sua salute. [IV,VII,10] Nel caso, poi, che qualcuno decidesse di giovarsi di una sapienza che è al di sopra di quella umana, Socrate gli consigliava di rivolgersi alla mantica. Infatti, chi sa riconoscere i segnali che gli dei mandano agli uomini, e che concernono le faccende umane, sa anche, ripeteva Socrate, che a lui non mancheranno mai i consigli degli dei.
[IV,VIII,1] Socrate soleva ripetere che il suo démone gli segnalava in anticipo ciò che dovesse e non dovesse fare. Ora, se qualcuno crede, a causa della sua condanna a morte, che Socrate sia colpevole di essersi ingannato a proposito di tale démone; ebbene costui rifletta in primo luogo sul fatto che egli era allora già tanto avanti negli anni che, se pur non subito, sarebbe di certo morto non molto tempo dopo. In secondo luogo, rifletta sul fatto che in questo modo Socrate si lasciò alle spalle la parte più penosa e molesta della vita, quella nel cui corso in tutti diminuisce la capacità intellettiva; e invece di questo declino, continuando a sfoggiare tutto il vigore dell’animo suo, egli si guadagnò la gloria parlando al processo con il massimo di verità, di libertà e di giustizia di tutti gli uomini; e sopportando la condanna a morte con il massimo di mitezza e di virilità; [IV,VIII,2] giacché è ammesso che nessuno mai degli uomini di cui v’è memoria abbia sopportato la morte in modo più nobile. Dopo il verdetto, gli toccarono comunque di necessità altri trenta giorni di vita, poiché quello era il mese delle Delie, feste nel corso le quali la legge non permetteva l’esecuzione di alcuna condanna a morte, fino a che la sacra ambasceria non fosse tornata da Delo. Durante questo tempo, tutti i suoi amici intimi ebbero modo di vedere che Socrate continuava a vivere le giornate in modo per nulla differente dal suo solito; seppure già in precedenza Socrate era tra tutti gli uomini oggetto di speciale meraviglia per il suo modo di vivere sempre di buon umore e con semplicità. [IV,VIII,3] Come si potrebbe morire più nobilmente di così? Quale morte potrebbe essere più nobile di quella di morire il più nobilmente possibile? Quale morte potrebbe essere più felice di quella più nobile possibile? E quale morte potrebbe essere più cara agli dei della morte più felice possibile?
[IV,VIII,4] Riferirò ora quello che di Socrate sentii dire da Ermogene, figlio di Ipponico. Raccontava dunque Ermogene di avere udito Socrate, quando ormai Meleto aveva scritto e presentato l’accusa, impegnarsi in ogni sorta di discussioni invece di parlare del processo, e di avergli detto che sarebbe stato il caso che egli considerare cosa dire in sua difesa. A questa domanda, Socrate dapprima rispose: “Non ti sembra che la mia vita intera sia stata una preparazione alla mia difesa?”. E quando Ermogene gli chiese: “In che senso?”, Socrate gli spiegò di non essere mai addivenuto a far altro che esaminare a fondo ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, effettuando le cose giuste ed astenendosi dalle ingiustizie, attività che egli legittimava come in assoluto la miglior preparazione possibile per la propria difesa. [IV,VIII,5] Allora Ermogene riprese dicendogli: “Non vedi, caro Socrate, che i giudici Ateniesi, fuorviati dai discorsi, hanno mandato a morte molti innocenti, e hanno invece assolto molti colpevoli?” “Sì, per Zeus, caro Ermogene” gli rispose Socrate, “ma quando io ho messo mano a considerare la faccenda della mia difesa davanti ai giudici, il mio démone vi si è opposto”. [IV,VIII,6] Udendo ciò, Ermogene espresse la sua sorpresa dicendogli: “Stai pronunciando parole davvero sorprendenti”. “Tu stai affermando”, gli rispose Socrate, “di stupirti del fatto che alla divinità sia apparso meglio che io, giunto a questo punto della mia vita, la finisca qui? Non sei al corrente del fatto che finora io non mi sono mai sottomesso ad alcun uomo, e che finora nessuno ha mai vissuto una vita migliore e più piacevole della mia? Infatti, io credo che vivano nel miglior modo possibile, coloro i quali hanno la maggior cura possibile di diventare gli uomini migliori possibili; e che vivano il più piacevolmente possibile coloro i quali si rendono conto, in sommo grado, di stare diventando davvero i migliori uomini possibile. [IV,VIII,7] Questi sono fatti, del cui accadere io mi sono reso conto, finora, giorno per giorno. Ed incontrando altri uomini e mettendomi a paragone con loro, questa è stata la conclusione alla quale sono giunto circa me stesso. E non soltanto io, ma anche i miei amici, continuano ad avere questa convinzione su di me, e non certo perché essi mi vogliano bene; – giacché anche coloro che vogliono bene ad altri, avrebbero allora questa stessa disposizione d’animo verso i loro amici, – bensì perché anche i miei sodali sono convinti di poter diventare gli uomini migliori possibili. [IV,VIII,8] Se io vivrò ancora a lungo, forse sarà per me inevitabile avere a che fare con gli acciacchi della vecchiaia: e quindi vedere ed udire di meno, avere difficoltà ad organizzare il pensiero, un indebolimento della capacità di apprendere, un aumento della smemoratezza, e diventare più ottusi di coloro dei quali in precedenza si era più vigili. Per colui che non si rende conto di questi acciacchi, la vita non diventerebbe invivibile? E per colui che invece se ne rende conto, il suo vivere non sarebbe necessariamente di qualità peggiore e più spiacevole? [IV,VIII,9] Se io, adesso, morirò a seguito di una condanna ingiusta, la vergogna per la mia condanna ricadrà tutta quanta su coloro che mi fanno uccidere ingiustamente. Infatti, se il commettere una ingiustizia è cosa di cui vergognarsi, come può non essere vergognoso il far uccidere un incolpevole? E che motivo ho io di vergognarmi, se certi individui sono incapaci di riconoscere e di applicare la giustizia nei miei confronti? [IV,VIII,10] Io osservo anche che, per vicende anteriori, l’opinione dei posteri su coloro che sono stati ingiusti e su coloro che hanno subito un’ingiustizia, non rimane sempre la stessa. Inoltre, io so che il mio caso sarà oggetto di attento studio da parte degli uomini, e che qualora io muoia adesso, tale attenzione non sarà la stessa per me e per i miei uccisori. Io so anche che sarà riconosciuta valida per sempre la mia testimonianza sul fatto che io mai commisi una ingiustizia contro chicchessia, e che non feci mai diventare i miei sodali uomini peggiori, ma che sempre mi sforzai di renderli migliori”.
[IV,VIII,11] Questo era il tenore delle discussioni che Socrate ebbe con Ermogene e con altri. E di quanti sanno di cosa fosse capace Socrate, tutti coloro che hanno di mira la virtù continuano ancora oggi a desiderarne ardentemente, a preferenza di tutti gli altri uomini, la presenza; in quanto il più utile di tutti nel perseguimento della virtù. Essendo quindi Socrate stato un uomo del genere, io l’ho descritto tal quale era. Un uomo pio, che nulla effettuò mai senza avere prima consultato il responso degli dei; un uomo giusto, che mai danneggiò qualcuno, neppur di poco, e che giovò sommamente a quanti ebbero a che fare con lui; un uomo padrone di sé, il quale mai prescelse ciò che è più piacevole invece di ciò che è più nobile; un uomo saggio, che non sbagliò mai la decisione su ciò che è meglio e su ciò che è peggio; un uomo che mai ebbe bisogno dei suggerimenti altrui, un uomo che confidò in se stesso invece che nelle conoscenze altrui; un uomo capace di parlare a ragion veduta e di definire il proprio punto di vista; un uomo capace, nel contempo, di confutare coloro che erano in errore, spingendoli alla virtù e spronandoli alla nobiltà d’animo. A me, insomma, egli appariva essere un uomo modello, di superiore nobiltà d’animo e completamente felice. Se poi a qualcuno non piace la mia descrizione di Socrate, si faccia la propria opinione dopo avere paragonato il carattere di Socrate a quello degli altri uomini.