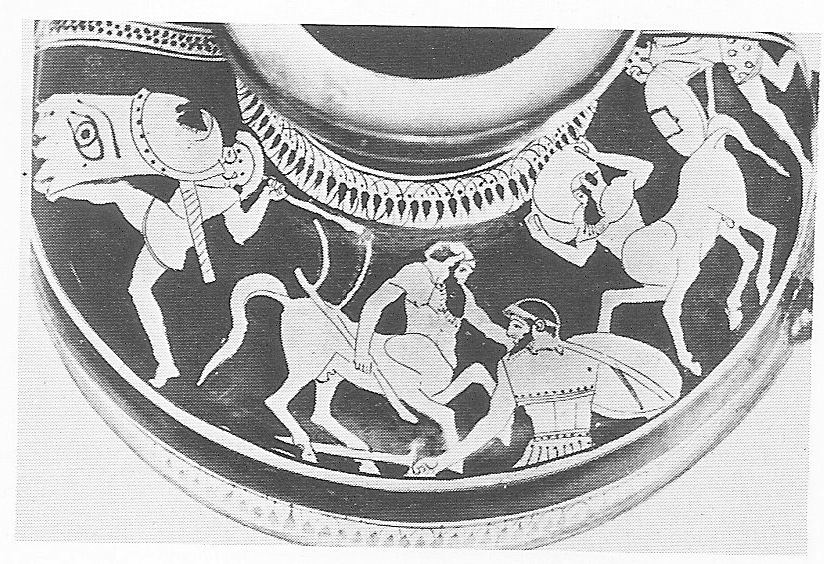COMMENTO A MARCO AURELIO
[ I,1 ] La famiglia di Marco Annio Vero, nonno paterno di Marco Aurelio, era originaria di Succubi, nei dintorni di Cordova, in Spagna. M. Annio Vero era nato probabilmente intorno al 65 d.C., apparteneva al rango senatoriale e fu per ben tre volte console: console sostituto nel 97 d.C. sotto l’impero di Nerva; nel 121 e nel 126 d.C. console ordinario sotto quello di Adriano. Fece inoltre stabilmente parte, per parecchi decenni, del circolo dei consiglieri più intimi dell’imperatore.
Sposò Rupilia Faustina e ne ebbe tre figli: Marco Annio Vero, del quale Marco Aurelio sarà figlio nel 121 d.C.; Marco Annio Libone e Annia Galeria Faustina. Quest’ultima, dunque zia di Marco Aurelio, sposerà il futuro imperatore Antonino Pio ed è comunemente indicata come ‘Faustina maggiore’.
M. Annio Vero era una persona economicamente ricchissima e politicamente molto influente. All’origine della sua potenza economica stavano le numerose fabbriche di laterizi delle quali era proprietario, ed è certamente questa potenza che portò poi la famiglia degli Antonini al potere imperiale nel 138 d.C. Se si ragiona comunemente e si considera che M. Annio Vero fu suocero di un imperatore -Antonino Pio-, e nonno di un altro -Marco Aurelio-, non si può non ammettere che la sua carriera sia stata uno straordinario successo politico.
Oltre che abilissimo nel gioco della politica, sappiamo che M. Annio Vero era un fuoriclasse anche nel gioco della palla (gioco in cui si dilettò volentieri anche Marco Aurelio da giovane), tanto da essere considerato uno dei migliori giocatori del suo tempo.
Quando il padre di Marco Aurelio morì, questi fu adottato proprio da M. Annio Vero, suo nonno, e con lui convisse a lungo nel suo palazzo di Roma, nei pressi del Laterano.
M. Annio Vero morì quasi certamente nel 138 d.C.
[ I,2 ] Il padre di Marco Aurelio si chiamava, esattamente come il nonno, Marco Annio Vero. A differenza del nonno, del padre di Marco Aurelio si sa pochissimo. Non l’anno della nascita e neppure l’anno della morte, poiché alcuni datano quest’ultima al 124 d.C., anno in cui egli ricoprì la carica di Pretore, mentre altri la datano intorno al 129 d.C. Sappiamo che sposò Domizia Lucilla e che da lei ebbe due figli: nel 121 d.C. Marco Aurelio e poco dopo una bambina, cui fu dato il nome di Annia Cornificia Faustina.
Le parole di questo frammento sono in ogni caso una testimonianza inequivocabile del fatto che Marco Aurelio non ha un ricordo cosciente, diretto, di suo padre.
[ I,3 ] Domizia Lucilla, la madre di Marco Aurelio, apparteneva ad una famiglia la cui fortuna economica, come quella di M. Annio Vero, era legata alle fabbriche di laterizi.
Tutto era cominciato circa un secolo prima con Cneo Domizio Afro, oratore assai noto ed originario della città di Nimes, nella Gallia. Quando egli morì, nel 59 d.C., ad ereditarne tutte le proprietà furono i suoi due figli adottivi: Cneo Domizio Lucano e Cneo Domizio Tullo. Nessuno poteva allora immaginare che le fabbriche di laterizi rappresentassero una vera e propria miniera d’oro e invece, a partire dal 64 d.C., col famoso incendio di Roma sotto Nerone e poi, nei decenni successivi, fino a Traiano e ad Adriano, tutte le attività di costruzione e di ricostruzione di Roma, e non soltanto di essa, conobbero un periodo di espansione permanente e prodigiosa. Ma andiamo con ordine.
C. Domizio Lucano sposò una figlia di Curtilio Mancia, uomo di grande ricchezza economica e di rango consolare, e da questo matrimonio nacque una bambina, Domizia Lucilla, futura nonna materna di Marco Aurelio. Accadde poi che per motivi ignoti, anche se immaginabili, il suocero Curtilio Mancia prese a detestare il genero C. Domizio Lucano ed entrò con lui in un dissidio tanto grave da legare tutta la sua fortuna in eredità alla nipote Domizia Lucilla a patto che essa fosse emancipata e dunque uscisse dalla potestà del padre, l’odiato C. Domizio Lucano.
Domizia Lucilla fu effettivamente emancipata, ma fu allora adottata da C. Domizio Tullo, fratello, come abbiamo detto, di C. Domizio Lucano. E così rimase frustrato il proposito di Curtilio Mancia poiché i due fratelli, mantenendo indivise le loro proprietà, attraverso l’adozione riportarono Domizia Lucilla e la sua larga fortuna sotto il controllo del padre. Insomma, questi due fratelli sembravano destinati ad essere coperti d’oro da coloro che invece avevano scopi del tutto contrari.
C. Domizio Lucano morì intorno al 94 d.C., lasciando unico erede il fratello C. Domizio Tullo. Questi, a sua volta, morì intorno al 108 d.C., e lasciò unica erede la figlia adottiva Domizia Lucilla, la quale venne così a trovarsi in possesso di una fortuna immensa. Quando a Roma succedevano queste cose, come ci informa dettagliatamente in una sua lettera Plinio il giovane, a lungo non si pettegolò d’altro.
Questa ricchissima ereditiera, Domizia Lucilla (indicata anche come ‘maggiore’ e nonna materna di Marco Aurelio) sposò in seconde nozze Calvisio Tullo, anch’egli persona di rango consolare. Dal loro matrimonio nacque una figlia che prese lo stesso nome della madre, Domizia Lucilla, e che sarà appunto la madre di Marco Aurelio. Sarebbe difficile immaginare un matrimonio d’interesse meglio assortito di quello tra M. Annio Vero e Domizia Lucilla ‘minore’. Alla coppia non dovevano certo fare difetto né le proprietà né i mezzi finanziari.
Quando M. Annio Vero morì, Domizia Lucilla non si risposò e rimase sempre vicina al figlio Marco Aurelio. Ella morì tra il 155 e il 161 d.C., senza vedere suo figlio diventare imperatore.
[ I,4 ] Si ammette comunemente che il bisnonno del quale parla qui Marco Aurelio sia il bisnonno materno Catilio Severo. Ma esattamente per via di quale parentela Catilio Severo possa esserlo stato è un problema che gli storici e gli eruditi non hanno ancora risolto, e che probabilmente rimarrà per sempre un mistero. In ogni caso, è lo stesso Marco Aurelio ad assicurarci che questo bisnonno ha giocato un ruolo decisivo nella sua educazione.
Catilio Severo apparteneva ad una famiglia originaria della Bitinia. Prima del 110 d.C. ricoprì varie cariche di modesto prestigio ma poi, a partire da quell’anno, la sua figura emerse in primissimo piano. Fu console sostituto nel 110 d.C., legato di Traiano in Armenia e Cappadocia, governatore della Siria nel 117 d.C., console ordinario con Antonino Pio nel 120 d.C., prefetto di Roma tra il 134 e il 138 d.C. e, quest’anno, addirittura possibile successore di Adriano.
Lo speciale interesse che Adriano manifestò per il giovane Marco Aurelio, da lui soprannominato ‘Verissimus’, si spiega verosimilmente anche con il fatto che Marco Aurelio aveva come nonno M. Annio Vero e come bisnonno Catilio Severo, due figure di assoluto rilievo nel circolo degli intimi dell’imperatore.
[ I,5 ] Nulla ci è noto di questo precettore di cui non conosciamo neppure il nome, e che doveva vegliare sulla salute fisica e morale di Marco Aurelio bambino.
Verde ed Azzurro erano i colori di due delle principali scuderie che si contendevano la vittoria nelle corse dei cavalli. Palmulari e Scutari erano due delle categorie in cui erano suddivisi i gladiatori del Circo.
[ I,6 ] L’educazione elementare di Marco Aurelio fanciullo continuò sotto la guida di Diogneto, dal quale sappiamo che imparò a dipingere. Anche di questo suo primo maestro poco o nulla è noto, salvo che egli non è identificabile con il destinatario di un’operetta apologetica cristiana intitolata ‘Lettera a Diogneto’.
Pochissimo sappiamo anche dei tre personaggi dei quali a Roma Marco Aurelio, per suggerimento di Diogneto, frequentò le conferenze pubbliche. Bacchio è con ogni probabilità un filosofo di scuola platonica originario della città di Pafo, nell’isola di Cipro. Tantaside e Marciano, se si tratta di nomi esatti, sono personaggi o sconosciuti o non identificabili.
[ I,7 ] Giunio Rustico era uno dei massimi eredi e depositari della grande tradizione stoica in onore presso una parte dell’aristocrazia romana. Ad esempio suo nonno, Giunio Aruleno Rustico, era stato addirittura condannato a morte e fatto uccidere da Domiziano nel 93 d.C. per avere osato difendere la memoria di Trasea Peto scrivendo la verità sulle vicende che lo portarono al suicidio.
Nato probabilmente intorno al 100 d.C., sappiamo che Giunio Rustico fu console sostituto nel 133 d.C., prefetto di Roma dal 160 al 168 d.C. e console ordinario nel 162 d.C.
Grazie alle notizie contenute nella corrispondenza di Marco Aurelio con Frontone, è verosimile supporre che Giunio Rustico abbia iniziato ad esercitare un’influenza significativa su Marco Aurelio nel 146 d.C. Da quell’anno in poi -essendo Marco Aurelio già ‘Cesare’, marito di sua cugina Annia Galeria Faustina, padre, diretto collaboratore dell’imperatore Antonino Pio- i loro rapporti si fecero molto stretti e continui, anche se essi furono a volte assai burrascosi. È sicuramente grazie a Giunio Rustico che Marco Aurelio ebbe il fondamentale incontro con l’insegnamento di Epitteto, ossia la rivelazione di cosa sia davvero la filosofia. Ed è addirittura possibile, benché non provato, che Giunio Rustico fosse stato uno dei tanti giovani allievi romani di Epitteto a Nicopoli, e che le ‘Memorie’ che Marco Aurelio qui cita siano in realtà gli appunti che Giunio Rustico aveva preso personalmente a quelle lezioni.
[ I,8 ] La reputazione di Apollonio doveva essere notevole se fu scelto da Antonino Pio per dare una formazione filosofica a Marco Aurelio. Apollonio era molto probabilmente originario di Calcedonia, città della Bitinia non lontana dall’attuale Costantinopoli. Filosofo stoico di professione e non uomo di Stato, pare che il suo insegnamento a Marco Aurelio, insegnamento del quale nulla conosciamo nei dettagli, sia da situare negli anni intorno al 150 d.C.
Nel corso del suo viaggio verso l’Italia, sappiamo che Apollonio sostò ad Atene e che, una volta giunto a Roma, si rifiutò però di recarsi a tenere le sue lezioni nel palazzo di Tiberio sul Palatino, dove Marco Aurelio abitava, affermando: ‘Il maestro non deve andare dal discepolo, ma è il discepolo che deve andare dal maestro’. Al che si racconta che l’imperatore Antonino Pio abbia argutamente fatto notare: ‘Per Apollonio è stato più facile venire da Calcedonia a Roma che venire da casa al palazzo di Tiberio’.
[ I,9 ] Sesto era un greco originario di Cheronea, città della Beozia non molto lontana da Delfi. Sappiamo anche con certezza che uno dei suoi zii era il famoso poligrafo Plutarco, scrittore di tendenze platoneggianti ed acerrimo nemico degli Stoici, autore delle notissime ‘Vite parallele’.
Filosofo e non uomo di Stato, Sesto fu maestro di Marco Aurelio intorno al 161 d.C., ossia subito prima e subito dopo l’ascesa di quest’ultimo al potere imperiale. Marco Aurelio, allora quarantenne, parla di sé in quegli anni come di un uomo che comincia ad invecchiare, ed un aneddoto ci racconta la risposta che egli diede ad un altro filosofo, di nome Lucio, al quale era capitato di incontrarlo mentre si recava, con al collo le tavolette di cera degli studenti, a lezione da Sesto. Alla richiesta di dove si recasse e per quale scopo, Marco Aurelio rispose: ‘Vado da Sesto per imparare quello che ancora non so’.
Sullo stoicismo di Sesto, sul suo stampo derivato da Epitteto e sul rilievo che il suo insegnamento ebbe per Marco Aurelio abbiamo molte testimonianze. Quando un personaggio notissimo, che aveva visto la morte della figlia Panatenaide e della moglie Regilla, perse anche la figlia Elpinice e piangendo disperatamente chiedeva quali offerte potesse ormai consacrarle e cosa potesse seppellire con lei, si racconta che Sesto dicesse: ‘Le farai una grande offerta se, nel lutto, manterrai la padronanza di te stesso’.
[ I,10 ] Si ritiene che l’attuale città turca di Kütahya sia situata là dove sorgeva un tempo l’antica Cozieo, nella Frigia Ellespontica. Questa è, se non quella d’origine, sicuramente la città nella quale Alessandro aveva la sua scuola di grammatica greca, di esegesi dei testi e di critica letteraria. Conosciamo anche il nome, e sono giunte fino a noi alcune delle opere, di almeno uno dei suoi più celebri allievi. La fama della scuola era dunque tale che non è sorprendente se essa giunse fino a Roma. Alessandro ‘il grammatico’ fu così scelto da Antonino Pio per insegnare la lingua e la letteratura greca a Marco Aurelio allora quattordicenne, intorno al 135 d.C.
Alessandro ‘il grammatico’ morì probabilmente intorno al 150 d.C.
[ I,11 ] Marco Cornelio Frontone era di almeno vent’anni più anziano di Marco Aurelio. Era nato a Cirta, l’odierna città algerina di Costantina e allora colonia romana, poco prima del 100 d.C. Dopo gli studi ad Alessandria d’Egitto venne a Roma, dove seppe farsi largo acquistando presto rinomanza come avvocato ed oratore. Raggiunto il rango senatoriale, ricoprì alcuni incarichi pubblici, ma soprattutto si acquistò il favore di Adriano e di Antonino Pio tanto che intorno al 135 d.C. gli fu affidata l’educazione letteraria e retorica in lingua latina di Marco Aurelio, allora quattordicenne. Certamente fu questo suo ruolo ad aprirgli più tardi le porte di un breve consolato, nell’estate del 143 d.C.
Frontone godette presso i contemporanei la fama di sommo oratore e gli fu assegnato, nella storia dell’eloquenza latina, un posto secondo, forse, soltanto a quello di Cicerone. Nonostante ciò, delle sue opere si era da millenni completamente persa ogni traccia fino alla fortunata scoperta da parte di Angelo Mai, agli inizi del 1800, di alcuni libri della sua corrispondenza privata con Marco Aurelio ed altri personaggi politici di primo piano. Questa corrispondenza copre gli anni che vanno dal 139 al 167 d.C. ed è stata di grande importanza per svelarcene un po’ meglio le qualità professionali ed umane. Frontone morì intorno al 170 d.C.
[ I,12 ] L’Alessandro che qui Marco Aurelio chiama “il Platonico” era in realtà meglio conosciuto con il soprannome di “Platone d’argilla”, ed era originario di Seleucia della Cilicia, l’attuale città turca di Silifke. Sappiamo che Alessandro era individuo di un fascino certamente non comune: gradevolissimo d’aspetto, curato nella persona fino ai minimi particolari e di grandissima abilità oratoria. Era un perfetto esemplare dei sofisti allora alla moda: viaggiatore indefesso, conversatore brillantissimo, capace di tenere conferenze di città in città sugli argomenti più disparati e spesso scelti all’ultimo momenti dagli stessi uditori.
Anche se alieno a questo genere di declamazioni, Marco Aurelio non dovette essere insensibile alle qualità di Alessandro, tanto che lo nominò suo segretario personale ‘ab epistulis graecis’, ossia incaricato di tutta la corrispondenza imperiale in lingua greca. Questo ufficio fu con ogni probabilità ricoperto da Alessandro tra il 170 e il 175 d.C., che viene anche comunemente ritenuto l’anno della sua morte.
[ I,13 ] Di Cinna Catulo non conosciamo altro che la citazione che qui ne fa Marco Aurelio, ed una seconda che lo indica puramente e semplicemente come filosofo stoico.
Domizio potrebbe essere, ma al riguardo non vi è alcuna certezza, Cneo Domizio Afro, il famoso oratore e lontano progenitore della madre di Marco Aurelio.
Atenodoto è invece sicuramente una persona di cui Frontone parla nelle sue lettere e di cui si sa che fu, come Epitteto, discepolo di Musonio Rufo.
[ I,14 ] Claudio Severo Arabiano era nato molto probabilmente nel 113 d.C., mentre il padre era Governatore romano della Provincia d’Arabia. La famiglia, di rango senatoriale, era originaria di Pompeiopoli di Paflagonia, città dell’entroterra turco non lontana dalla moderna Sinop. Sappiamo che egli fu console ordinario sotto Antonino Pio nel 146 d.C. e, forse, Prefetto della città di Roma.
Claudio Severo era un filosofo di scuola aristotelica e quando Marco Aurelio decise di familiarizzarsi con la filosofia peripatetica, che allora significava essenzialmente familiarizzarsi con gli studi che oggi si chiamerebbero di ‘Scienze Naturali’ (Botanica, Zoologia, Anatomia Comparata, ecc.), prese lezioni da lui. D’altra parte il celebre Galeno, che fu medico personale di Marco Aurelio, ci conferma che anche il figlio di questo Claudio Severo assisteva alle sue lezioni di anatomia. Proprio questo figlio di Claudio Severo sposò, intorno al 163 d.C., la figlia primogenita di Marco Aurelio, figlia che portava anch’essa il nome di sua madre e di sua nonna ossia quello di Annia Galeria Faustina. Questo matrimonio fece dunque sì che i legami tra le due famiglie, com’è verosimile, diventassero assai stretti.
[ I,15 ] Claudio Massimo è un personaggio storicamente assai ben conosciuto. Nato probabilmente intorno al 100 d.C., filosofo stoico, senatore, tra il 132 e il 155 d.C. ricoprì molte e diverse cariche pubbliche, essendo console sostituto nel 141-142 d.C. e proconsole d’Africa nel 158-159 d.C. In quanto proconsole d’Africa fu lui a giudicare nel famoso processo ‘per magia’ intentato contro Apuleio di Madaura.
Nel corso degli anni in cui visse a Roma, Claudio Massimo sembra essere stato intimamente legato alla famiglia imperiale, e la sua morte avere rappresentato un avvenimento intensamente vissuto da Marco Aurelio.
[ I,16 ] Successore di Adriano, l’imperatore Antonino Pio era nato nell’86 d.C. a Lanuvio, poco a sud di Roma, ai piedi dei Colli Albani. Fu, tra molti altri incarichi, console nel 120 d.C. e proconsole d’Asia nel 135-136 d.C. Adriano lo adottò pochi mesi prima di morire, nel 138 d.C., ed Antonino Pio resse l’impero per 23 anni, fino al 161 d.C.
Era sposato con Faustina ‘maggiore’, zia di Marco Aurelio, il quale fu da lui adottato nel 138 d.C. per espressa volontà di Adriano. Da allora Marco Aurelio, che era rimasto orfano di padre in tenerissima età, lo considerò e lo onorò a tutti gli effetti come il proprio padre.
[ I,17 ] Cos’è immortale nel cosmo? Null’altro che il cosmo stesso ossia la Materia della quale esso è costituito. E nell’uomo? Il suo corpo, in quanto Materia Immortale del cosmo eternamente destinata a continue trasformazioni e combinazioni. Se usata rettamente, la ragione umana è allora in grado di concepire di sé e del cosmo quelle rappresentazioni felicitanti, generose, liberatorie ed aderenti alla natura delle cose che si possono anche chiamare ‘dei’.
*****
[ II,1 ] La giornata di un imperatore, sembra dirci Marco Aurelio, non è molto diversa da quella di uno qualunque di voi.
Tutti i vizi degli esseri umani, infatti, sono forme del giudizio che bene e male sono entità esterne ed aproairetiche, così come tutte le loro virtù sono forme del sapere che bene e male sono unicamente giudizi ossia entità proairetiche. Questa è la natura delle cose: inviolabile, eterna, invariante; e pertanto l’uomo non può fare del bene o del male ad altri che a se stesso.
Da stoico, Marco Aurelio ha chiara coscienza del fatto che tutti gli esseri umani sono partecipi di una medesima ragione, che sono tutti congeneri e destinati alla cooperazione, non all’odio reciproco.
Pur vivendo tutti secondo natura, la differenza tra saggi ed insipienti consiste allora in ciò: che il virtuoso vive secondo natura e in armonia con la natura delle cose, mentre il vizioso vive secondo natura ma in contrasto con la natura delle cose.
[ II,2 ] ‘Proairesi’ nella prevalente terminologia di Epitteto, ed ‘egemonico’ nella prevalente terminologia di Marco Aurelio, sono sostantivi del tutto equivalenti e intercambiabili.
Cos’è la proairesi? La proairesi, o egemonico, è la facoltà logica degli esseri umani in quanto facoltà autoteoretica capace di atteggiarsi in armonia con la natura delle cose ossia ‘diaireticamente’, oppure in contrasto con la natura delle cose ossia ‘controdiaireticamente’. Essa è la causa basilare di tutte le azioni responsabili dell’uomo ed è, in un certo senso, l’uomo stesso. Tra tutti gli esseri viventi, finora l’unico animale ad essere ‘proairetico’ è proprio l’uomo.
Marco Aurelio lo afferma con decisione e riafferma qui che la proairesi, o egemonico, è l’unica facoltà umana capace di parlare a se stessa, di esaminarsi e di decidere se essere serva ed infelice oppure libera e felice.
[ II,3 ] Cos’è la Prònoia? Molti sono i modi in cui la Prònoia può essere definita: come mente della Materia Immortale; come la proairesi, o egemonico, del cosmo; come il ‘logos’ che lo pervade; come le leggi inviolabili, eterne, invarianti che manifesta; come la razionalità che gli inerisce e che da esso è inseparabile come sono inseparabili i poli positivo e negativo di un magnete.
Nel solco della tradizione fissata da Aristotele e condivisa dagli stoici, in questo frammento anche Marco Aurelio sottoscrive il giudizio che quattro sono le cause basilari degli eventi cosmici e le presenta nella loro sequenza tradizionale: Proairesi umana e Prònoia cosmica, Natura, Necessità, Fortuna.
Queste quattro cause basilari e le loro relazioni reciproche potrebbero forse essere illustrate con un esempio di questo genere: che un seme sia un seme è Prònoia; che un seme di grano generi una pianticella di grano è Natura; che una pianticella di grano sia distrutta da una furiosa grandinata è Necessità; che la grandine cada proprio su quella pianticella è Fortuna.
[ II,4 ] L’uomo che rimanda di fare questi conti e non li fa in questa vita, non avrà più una seconda possibilità. Quali conti?
Se le parole del frammento non fossero ancora abbastanza eloquenti, basta riflettere su parole come queste di Epitteto: ‘Voi vi mettete in viaggio per Olimpia per vedere lo Zeus di Fidia e ciascuno di voi crede una sfortuna morire senza averlo visto. E laddove non c’è neppure bisogno di mettersi in viaggio, ma dove Zeus è già e presenzia con le opere, queste non smanierete di osservarle e di capirle? Quindi non vi accorgerete né di chi siete, né del per che cosa siete nati, né di cos’è quest’opera alla cui visione siete stati invitati?’
[ II,5 ] L’uomo può essere in vita, ma può affermare in senso proprio di ‘vivere’ unicamente ‘da quando a quando’ la sua proairesi si afferma per quello che è per natura: libera, infinita, inasservibile, insubordinabile. Per affermarsi ‘vivente’ alla proairesi basta dunque fare una operazione sola: quella di atteggiarsi diaireticamente, ossia operare la diairesi.
Cos’è la diairesi? Basterà dire, come Epitteto ha insegnato anche a Marco Aurelio, che la diairesi è un supergiudizio e precisamente il giudizio che sa distinguere quanto è in nostro esclusivo potere e quanto invece non è in nostro esclusivo potere.
Dobbiamo allora usare gli oggetti esterni, quanto non è in nostro esclusivo potere, insomma i normali materiali dell’esistenza, casualmente e con trascuratezza o addirittura rifiutare di usarli? Nient’affatto! Anzi, dobbiamo imparare ad usarli con estrema solerzia, poiché il loro uso non è indifferente, e insieme con stabilità di giudizio e dominio sullo sconcerto, poiché il materiale non fa differenza.
Siccome una e medesima è la ragione del cosmo e la ragione dell’uomo, la diairesi innalza pertanto l’uomo al livello di un dio e ‘vivere’ non può che diventare sinonimo di ‘vivere da dio’.
[ II,6 ] È noto che per gli Stoici l’animo umano può essere distinto in otto parti: i cinque sensi (vista, udito, olfatto, gusto, tatto), la parte legata alla fonazione, la parte legata alla sessualità e la proairesi o egemonico.
Con caratteristico procedimento retorico, Marco Aurelio impiega in questo frammento, e userà più volte in seguito, una sineddoche, e indica il tutto (l’animo) per indicare la parte (la proairesi). È infatti incontrovertibile che la sola facoltà autoteoretica dell’animo umano è la proairesi e che soltanto essa è in grado di scegliere di oltraggiarsi.
Quando la proairesi oltraggia se stessa? Quando si afferma per quello che per natura non è, ossia quando si atteggia controdiaireticamente.
E cos’è la controdiairesi? Basterà anche qui dire che è il supergiudizio, esattamente contrario alla diairesi, che afferma in nostro esclusivo potere quanto non è in nostro esclusivo potere oppure non essere in nostro esclusivo potere quanto invece è in nostro esclusivo potere.
Porre nelle proairesi altrui la propria buona sorte, ossia far dipendere la propria felicità dagli altri è caratteristico di una proairesi che si atteggia controdiaireticamente e questo, appunto, non può che renderci schiavi.
[ II,7 ] La vita in senso proprio dell’uomo è strettamente legata allo stato della sua proairesi. Egli, infatti, ‘vive’ quando la sua proairesi è atteggiata diaireticamente, mentre è ‘in vita’ quando la sua proairesi è fisiologicamente spenta, come nel sonno, oppure ‘da quando a quando’ essa si nega per quello che è, e si atteggia controdiaireticamente. Marco Aurelio ci offre qui la rappresentazione di due modi a lui ben noti, da imperatore, in cui la proairesi si atteggia controdiaireticamente, ossia di due modi di essere ‘in vita’ senza ‘vivere’.
Il primo è quello di lasciarci talmente distrarre dagli avvenimenti esteriori da immedesimarci in essi, giudicandoli in nostro esclusivo potere. Il secondo è quello di estraniarcene al punto tale da decidere di perdere ogni contatto con essi. Chi legge attentamente il frammento si accorgerà che Marco Aurelio suggerisce nel contempo anche i corrispondenti rimedi.
[ II,8 ] L’uomo, finora unico tra tutti gli animali, non soltanto usa le rappresentazioni ma ha anche la comprensione del loro uso, giacché è stato dotato dalla natura di ragione, è ‘Homo proaireticus’. Questo lo pone nella condizione di conoscere bene e male, felicità e infelicità, a seconda dell’uso che la sua proairesi fa di se stessa.
Se i vegetali non hanno rappresentazioni, gli altri animali hanno invece certamente rappresentazioni e le usano ma, pur facendo di esse un uso anche raffinatissimo, non hanno la comprensione dell’uso che ne fanno. Essi sono pertanto creature aproairetiche, esseri non dotati di ragione. Questo esclude che si possa parlare a loro riguardo di bene e di male, di felicità e infelicità.
[ II,9 ] La natura esiste ed essa fu, è, sarà eternamente onnicomprensiva. Con l’uomo viene all’esistenza anche la ‘natura delle cose’, che consiste nella essenziale bipartizione di quel tutto eternamente onnicomprensivo che è la natura o cosmo, in entità aproairetiche ed in entità proairetiche. La peculiare natura dell’uomo è tutt’uno con la conoscenza e la pratica delle conseguenze di questa fondamentale diairesi.
Marco Aurelio poi afferma, in verità più da imperatore che da filosofo, che nessuno può impedirci di fare o dire ciò che consegue alla nostra natura di uomini. Dovrebbe invece dire, con Epitteto, che non soggetto ad impedimento è soltanto il desiderio, o l’impulso, o l’assenso a fare e dire ciò che consegue alla nostra natura di uomini, giacché laddove vi è bisogno del corpo e della sua collaborazione noi possiamo sempre esserne impediti dalle più svariate e imprevedibili circostanze.
[ II,10 ] È noto che secondo gli Stoici tutte le aberrazioni degli uomini sono ugualmente gravi. Se, infatti, non c’è una verità che sia più vera di un’altra, non ci sarà neppure una falsità che sia più falsa di un’altra, e lo stesso vale per le aberrazioni. E così non si trova a Nicopoli tanto chi ne dista un miglio quanto chi ne dista cento, ed è destinato ad annegare tanto chi resta un metro quanto chi resta cinque metri sott’acqua.
Marco Aurelio invece, più da seguace di Aristotele che di Crisippo, mostra qui di concordare con Teofrasto, il quale vede una differenza tra l’aberrazione di una proairesi come quella di Medea, che aberra per rancore, ed una, come quella di Fedra, che aberra per smania.
Teofrasto è il noto filosofo di Ereso, nell’isola di Lesbo, nato intono al 372 a.C. e morto intorno al 286 a.C., che successe ad Aristotele nella direzione della scuola Peripatetica.
[ II,11 ] La natura è immortale. L’uomo è mortale. Al perenne flusso della divina natura, di cui l’uomo è parte, inerisce una razionalità, la Prònoia o Logos, della quale la ragione dell’uomo partecipa con la Proairesi. L’armonia dell’uomo con la natura non può pertanto stabilirsi che quando la proairesi sia in armonia con la Prònoia.
È possibile questa armonia? Questa armonia è possibile quando la proairesi dell’uomo si atteggia diaireticamente, ossia quando riconosce la differenza tra ciò che è aproairetico e ciò che è proairetico: nel presente caso, tra natura e Prònoia (entità aproairetiche) ed i giudizi che essa ha su natura e Prònoia (entità proairetiche). Se la proairesi giudicasse che natura e Prònoia sono ‘male’, in quanto la destinano alla morte, implicherebbe per sé il progetto di contrastare qualcosa che essa stessa invece ha già definito incontrastabile. Se giudicasse che esse sono ‘bene’, in quanto l’hanno chiamata alla vita, implicherebbe l’esistenza al di fuori di sé di un bene da lei stessa già definito irraggiungibile, così come la parte non può essere il tutto. Dunque la retta proairesi deve giudicare che natura e Prònoia non sono né bene né male, ma ‘indifferenti’ per la propria felicità o infelicità, e comportarsi di conseguenza.
Ed è possibile la disarmonia? La disarmonia dell’uomo con la natura delle cose, ossia della proairesi con la Prònoia, è facilissima da ottenere. Basta giudicare che natura e Prònoia siano ‘male’ o siano ‘bene’. E dunque anche, ancora più semplicemente, che vita, gloria, piacere fisico, ricchezza di denaro siano ‘bene’, con le inevitabili disillusioni conseguenti; e che i loro contrari: morte, discredito, dolore fisico, povertà di denaro, siano ‘male’, con l’inevitabile infelicità che li accompagna.
[ II,12 ] Epitteto afferma che tutte le cose aproairetiche sono deboli, serve, soggette ad impedimenti, periture e, soprattutto, che non sono né beni né mali, ma materiali indifferenti dai quali la proairesi può trarre il proprio bene o il proprio male a seconda dell’uso che ne fa.
Tra le cose aproairetiche rientra anche la morte, la paura della quale è tutt’uno con il giudizio che essa sia un male. La morte, invece, non soltanto è un’opera della divina natura ma è anche utile ad essa. L’uomo la cui proairesi è atteggiata diaireticamente e che quindi non ha paura della morte sarà anche, per conseguenza, divinamente atteggiato.
[ II,13 ] Per vivere bene, in modo eticamente adeguato, non basta imparare la sostanza del bene e del male, le misure di desideri ed avversioni, di impulsi e repulsioni, di assensi e dissensi e, usando queste come canoni, governare quotidianamente i fatti della vita? Non sono, in un certo senso, da commiserare coloro che giudicano indispensabile conoscere se esiste il bosone di Higgs per vivere bene?
Nessuna scoperta può dare alla proairesi, al demone che è dentro di noi, la felicità che le viene dal sapere di nutrire retti giudizi e di essere per natura libera, infinita, inasservibile e insubordinabile.
La citazione poetica viene da un frammento di Pindaro (V° secolo a.C.).
[ II,14 ] Siccome né il passato né il futuro ci appartengono e noi viviamo in un eterno presente, non si può essere felici che nella vita che si vive. E si può esserlo anche nel corso di una vita brevissima, così come si può non esserlo anche nel corso di una vita lunghissima.
[ II,15 ] Monimo il cinico era nato a Siracusa e visse nel IV° secolo a.C. Fu allievo di Diogene e seguì molto da vicino anche Cratete, avendone gli stessi propositi. Conquistò tale reputazione che il poeta comico Menandro ne fece menzione in una commedia della quale Marco Aurelio cita qui un frammento. Monimo, si racconta, si sentì superiore alla gloria ed ebbe il gusto di dire e di sentir dire soltanto la verità.
[ II,16 ] Poiché il cosmo è natura onnicomprensiva, nessuna particolare natura in esso compresa può essergli estranea o contraria. Pertanto nulla di ciò che accade nel cosmo può avvenire e dirsi ‘contro natura’. La vita è ‘secondo natura’ tanto quanto lo è la morte, e sono secondo natura tanto la salute quanto la malattia, tanto un ascesso quanto un tumore.
Questo vale pienamente anche nel caso dell’uomo. Inveire contro gli avvenimenti, cercare di danneggiare un altro, lasciarsi vincere dal piacere o dal dolore, fingere, mentire, agire a casaccio, ma anche uccidere per piacere, torturare per lucro, inquinare l’ambiente, e così via non sono affatto atteggiamenti ‘contro natura’ ma pienamente ‘secondo natura’ ed ai quali il cosmo assiste con sovrana, eterna indifferenza, senza esserne minimamente scalfito.
Ma esiste, allora, una peculiare natura dell’uomo? E se essa esiste qual è?
Se l’uomo è, come in effetti è, ‘Homo proaireticus’, la sua peculiare natura sarà da ricercarsi in ciò che lo differenzia da tutti gli altri animali: e questa differenza è la proairesi. Natura della proairesi è quella di essere libera, infinita, inasservibile e insubordinabile, ed essa salvaguarda questa sua peculiare natura soltanto mantenendosi in tale stato. Per mantenersi in tale stato la proairesi deve scegliere di atteggiarsi diaireticamente, ossia deve scegliere di riconoscere pienamente la differenza tra ciò che è in suo esclusivo potere e ciò che non lo è, e dunque rispettare la ‘natura delle cose’.
È in esclusivo potere della proairesi anche atteggiarsi controdiaireticamente, negare la propria natura, aberrare, oltraggiarsi. Oltraggiarsi è ‘contro natura’? Assolutamente no. Oltraggiarsi è ‘secondo natura’. Ma la proairesi che si oltraggia è esattamente la proairesi che fallisce la diairesi tra ciò che è in suo esclusivo potere e ciò che non lo è, che fallisce il rispetto della ‘natura delle cose’, che aberra. E la ‘natura delle cose’ non è stata scritta né dall’uomo né dalla sua proairesi, ma è la legge inviolabile scritta da quella che qui Marco Aurelio chiama ‘ragione e statuto della città e del regime primigenio’, ossia la Prònoia del cosmo, ovvero dalla mente della Materia Immortale, e che può essere letta e interpretata soltanto dall’uomo.
[ II,17 ] Questo frammento finale del secondo libro è con tutta evidenza strutturato in due parti ben distinte, corrispondenti ai due possibili atteggiamenti del demone interiore dell’uomo, ossia della sua proairesi; parti che ruotano intorno ad un asse rappresentato dalla domanda che ne sta al centro.
Nella prima parte la proairesi confessa, con tono accorato e dolente, come essa vede se stessa e il mondo quando è atteggiata controdiaireticamente. In questo stato si potrebbe dire che essa non ha altra certezza che quella di non avere certezze: tutto è instabile, degradato, incomprensibile, vano. In tre parole: male e infelicità.
Ora, siccome ogni proairesi cerca per sua inviolabile natura il proprio bene e non il proprio male, essa è necessitata a porsi la domanda centrale: esiste la scienza della felicità?
La seconda parte del frammento è la risposta a questa domanda. La scienza della felicità non soltanto esiste, ma è addirittura l’unica vera scienza concessa all’uomo. Basta che la proairesi muti i propri giudizi aberranti e pervertiti in retti giudizi e riconosca di essere per natura libera, infinita, inasservibile, insubordinabile, atteggiandosi diaireticamente.
Se nella prima parte la proairesi era schiacciata sull’infelicità in quanto atteggiata secondo natura ma contro la natura delle cose, la felicità della seconda parte consegue al suo atteggiamento secondo natura e secondo la natura delle cose.
*****
[ III,1 ] Appare esservi una sostanziale differenza tra il ‘vivere’ e l’essere ‘in vita’. Affinché l’uomo ‘viva’, la sua proairesi deve essere pienamente funzionante ed atteggiata diaireticamente. L’uomo è invece semplicemente ‘in vita’ quando la sua proairesi è fisiologicamente spenta, come nel sonno; quando è pienamente funzionante ma è atteggiata controdiaireticamente; e quando un trauma o una qualunque malattia degenerativa alteri radicalmente o impedisca il funzionamento della proairesi in quanto facoltà, pur assistendosi alla permanenza di tutte o molte delle altre facoltà vegetative ed animali. Già per Marco Aurelio, il quale parla qui non in astratto ma di se stesso, il deperimento e la morte della proairesi dell’uomo possono precedere la morte del corpo.
[ III,2 ] La natura si mostra maestra inarrivabile anche in particolari del tutto accessori delle proprie opere.
Con sovrana imparzialità essa dona a Marco Aurelio una disastrosa inondazione del Tevere che distrugge molte case di Roma, fa annegare un gran numero di animali, causa una severa carestia e il vezzoso sorriso dei fanciulli; gli orrori di una guerra contro i Quadi e i Marcomanni e i colori dell’autunno; i raccapriccianti spettacoli di una epidemia di peste e le screpolature del pane fragrante; la schiuma e il sangue che gorgogliano da gole strozzate e le spighe di grano mature e incurvate fino al suolo.
Con eguale sovrana indifferenza, la natura dà a ciascuno di noi le risorse necessarie per odiarla, maledirla ed esecrarla oppure giudicare in ogni circostanza dove stiano il bene ed il male.
[ III,3 ] Ti sei imbarcato, hai navigato, sei approdato: è ora di sbarcare. Quello che adesso tocca a Marco Aurelio è toccato e toccherà a tutti gli uomini, sapienti e insipienti, virtuosi e viziosi. Come sappiamo, per lo stoico la morte non è né un bene né un male, in quanto fatto aproairetico che si disegna nel quadro di eventi necessari e naturali da non temere.
Di fronte alla morte non è dunque la proairesi, qui chiamata ‘mente e demone’, del sapiente Marco Aurelio ma piuttosto la proairesi del Marco Aurelio che dorme intruppato fra le turbe degli insipienti quella che può parlare con sufficienza e con disprezzo del corpo umano, ossia della Materia Immortale che esprime la proairesi stessa, come di un sozzo e spregevole recipiente.
Tutti i personaggi citati nel frammento sono notissimi e non richiedono precisazioni.
[ III,4 ] ‘Un desiderio che non fallisce e un’avversione che non incappa in quanto intende evitare. Un impulso conveniente, che sa accordarsi abilmente con ciò che è doveroso e una repulsione secondo la natura delle cose, libera dall’errore. Un assenso non precipitoso né sconsiderato e un dissenso meditato e fermo’.
Ecco il ritratto dell’uomo virtuoso, di colui che ha imparato ad usare quotidianamente la diairesi.
[ III,5 ] Dentro di me una proairesi raggiante, atteggiata diaireticamente e dunque dotata delle risorse per accettare qualunque sfida.
[ III,6 ] Chi giudica che i delinquenti, i ladri, i politicanti, i ricchi di denaro siano uomini giusti, veritieri, temperanti, virili, ha l’obbligo di fare di tutto per diventare come loro ed essere il primo dei delinquenti, il primo dei ladri, il primo dei politicanti e un Creso.
Chi, invece, giudica che le virtù proprie dell’uomo stiano in una proairesi rettamente operante, capace di disciplinarne gli assensi, i desideri e gli impulsi e che in questo consistano giustizia, verità, temperanza e virilità, fa inevitabilmente altre scelte.
Dove cercare il canone che permette di portare a termine questa indagine con sicurezza e scegliere la strada giusta? Da nessun’altra parte che nella natura delle cose, laddove la ragione umana sa leggere quello che la Prònoia vi ha scritto e riconoscere la differenza fra ciò che è utile all’uomo in quanto semplice animale e ciò che gli è utile in quanto creatura razionale.
[ III,7 ] La natura concede all’uomo di far assumere alla sua acropoli interiore, la proairesi, uno schieramento controdiairetico ossia contrario alla natura delle cose, oppure diairetico cioè in armonia con la natura delle cose. Le armi della controdiairesi sono slealtà, odio, sospetti, ipocrisia. Quelle della diairesi sono franchezza, libertà, serenità, felicità.
[ III,8 ] Nell’acropoli dei retti giudizi nulla è purulento, sudicio o fradicio. La retta proairesi, che Marco Aurelio designa qui con il semplice termine ‘intelletto’ è ‘natura viva’, e soltanto colui che ha atteggiato la sua proairesi diaireticamente, anche una sola volta nel corso dell’esistenza, può dire di avere conosciuto la vita.
[ III,9 ] A fare retta la proairesi è la concezione di retti giudizi. Retti sono i giudizi in armonia con la natura delle cose, senza precipitazione nell’assentire, senza avversione per gli uomini, senza repulsione per ciò che è immortale.
[ III,10 ] Se non si getta alle spalle tutti i giudizi errati, la proairesi che rimanda a domani, poi a dopodomani, quindi a postdopodomani l’uso della diairesi non conquista un terreno neutro ma rimane saldamente in terreno controdiairetico. Sappiamo che l’assillo della fama presente e postuma, dell’opinione che gli altri hanno e avranno di noi era fortissimo in Marco Aurelio. Ed esso è caratteristico di una proairesi atteggiata controdiaireticamente, giacché fa dipendere il proprio bene e il proprio male da cose per noi aproairetiche come i giudizi altrui.
[ III,11 ] È noto che gli stoici hanno abbandonato al loro destino numerosi capisaldi della filosofia classica facendo svanire, ad esempio, l’autonomia del concetto e la trascendenza delle idee, la distanza tra l’essenza dei fenomeni e la loro conoscenza sensibile. Per gli stoici, la definizione di un oggetto o di un evento è tutt’uno con la sua descrizione e raggiunge l’essenza di esso, che risiede nel nesso causale tra il singolo evento e la totalità degli eventi cosmici. Per gli stoici, dunque, la corretta descrizione di un oggetto o di un evento di cui abbiamo la rappresentazione non afferra soltanto i suoi aspetti esteriori (dimensioni, modalità, tempi, ecc.) ma coglie insieme l’ordine causale, ossia la trama universale in cui il singolo oggetto o evento è inscritto e nel quale si definisce.
Essenziale affinché la proairesi dell’uomo operi secondo la natura delle cose è pertanto il suo saper riconoscere dinanzi ad ogni oggetto od evento da quale delle quattro cause basilari esso provenga: dalla divinità o natura, dalla necessità, dalla fortuna, dalla proairesi; così da potersi atteggiare correttamente di fronte ad esso. Qualora, un evento provenga a noi da un’altrui proairesi atteggiata controdiaireticamente e dunque ignorante della natura delle cose -ad esempio un insulto che ci viene rivolto da un’altra persona-, la retta proairesi descrive a se stessa che qualcuno ci sta insultando ma non da il suo assenso alla rappresentazione che qualcuno ci stia facendo del male. Perciò non se ne lascia sconvolgere e non si sposta a sua volta in terreno controdiairetico ribattendo all’insulto con l’insulto, ma si mantiene saldamente in terreno diairetico e tratta ciò che è aproairetico, ossia tanto l’autore dell’insulto quanto l’insulto, secondo il suo valore.
[ III,12 ] Chi vive bene? Se il falegname diventa falegname imparando certe cose e il pilota diventa pilota imparando certe cose, vivrà bene colui che impara le cose necessarie per vivere bene. Per vivere bene l’uomo deve conoscere la natura delle cose ed essere in armonia con essa. La natura delle cose è la inviolabile, maschia, ‘romana’, come la chiama qui da imperatore Marco Aurelio, verità. Essa è verità con la quale è essenziale che la nostra proairesi sia in armonia eseguendo qualunque attività. E siccome la proairesi è per natura libera, infinita, inasservibile, insubordinabile, nulla e nessuno può impedirle di atteggiarsi come essa dispone: tant’è vero che turbe sterminate di esseri umani rifiutano di riconoscere la natura delle cose e vivono il male.
[ III,13 ] Occorre tenere sempre ben presente che delle quattro cause basilari degli eventi cosmici, tre sono divine ossia non in nostro esclusivo potere: natura, fortuna, necessità; e una è in nostro esclusivo potere: la proairesi.
[ III,14 ] Forse è il caso di abbandonare tutte le vuote speranze e di soccorrere se stessi.
[ III,15 ] Vedere con gli occhi della testa e vedere con gli occhi della proairesi.
[ III,16 ] Il caldo e il freddo, il dolce e l’amaro sono sensazioni percepite da qualunque animale. Gli stimoli a bere, a mangiare, a dormire, ad accoppiarsi sono propri di tutti gli animali. Propria ed esclusiva dell’essere umano è invece quella facoltà autoteoretica, la proairesi, che lo fa capace di comprendere l’uso delle rappresentazioni ed alla quale tutte le altre facoltà sono subordinate. Pertanto il peggior delinquente e l’uomo virtuoso hanno entrambi come signora e duce la loro proairesi. La differenza tra di loro consiste unicamente nel modo in cui la usano.
*****
[ IV,1 ] L’insipiente va a fare un bagno e s’infuria e si consuma in frivole altercazioni con coloro che sulla spiaggia spruzzano, spintonano, ingiuriano. Il saggio va a fare un bagno dicendo prima a se stesso: ‘Dispongo di fare un bagno ma anche di serbare la mia proairesi in accordo con la natura delle cose: e tale non la serberò se m’infurio e mi consumo in frivole altercazioni con coloro che spruzzano, spintonano, ingiuriano’.
Questa è la ‘riserva’ che contraddistingue la diairesi, ed è per questo che la proairesi del saggio, atteggiata secondo diairesi, è puro fuoco interiore capace di trarre dagli avvenimenti luce, felicità e bellezza; laddove la proairesi dell’insipiente, atteggiata secondo controdiairesi, è invece una lucerna destinata a languire ed essere spenta dal trambusto e dal fracasso degli eventi aproairetici che le si accumulano sopra.
[ IV,2 ] Chi dispone di apprendere l’arte di vivere bene non deve imparare altro che l’uso quotidiano e sistematico della diairesi.
[ IV,3 ] Dove stanno felicità ed infelicità? Le turbe di insipienti microimperatori che vanno sotto il nome di cittadini credono fermamente che l’infelicità stia dentro l’uomo e sia causata da eventi a lui esterni ed aproairetici e che la felicità stia fuori dell’uomo e si trovi nel possesso di cose anch’esse esterne ed aproairetiche da ricercarsi in campagna, ai monti, al mare oppure nel diventare imperatore.
La natura delle cose è invece diversa e vieta inviolabilmente che felicità e infelicità stiano altrove che nella proairesi degli esseri umani. Questo è il motivo per cui il mero fatto di essere imperatore non equivale ad essere felice e per cui anche un imperatore, puramente e semplicemente come tale può, e forse deve, essere insipiente tanto quanto quei suoi concittadini.
Marco Aurelio non potrebbe fare e non fa eccezione. E però egli ammette di aver sentito dire da Epitteto che, per un imperatore cui manca il coraggio di dire pubblicamente come stanno le cose, l’unico modo per trovare qualche momento di felicità è quello di avere retti giudizi sull’impero e quindi di ritirarsi il più spesso possibile da uomo libero, da cittadino del mondo, nel campicello della propria proairesi; dove potrà riscoprire continuamente che a fare infelice l’uomo non sono né l’insipienza di quei microimperatori, né gli accidenti assegnatigli dalla fortuna, né le passioni del corpo né la scarsità delle lodi altrui bensì il giudizio che queste cose esterne ed aproairetiche possano essere bene o male.
Soltanto chi ha imparato ad atteggiare la propria proairesi in modo diairetico, ossia secondo quei retti giudizi che soli definiscono e rispettano la natura delle cose, trova le brevi e semplici massime indispensabili per vivere bene in questo mondo di microimperatori e di imperatori, anche se dovesse passare gli anni abbandonato e occulto tra uno stuolo di malevoli.
[ IV,4 ] Se, come l’uomo continuamente sperimenta, nulla viene dal nulla e neppure ritorna nel nulla, allora ciò che esiste ha perenne sussistenza e dunque il cosmo è Materia Immortale le cui trasformazioni non comportano né creazione né annullamento. Il movimento incausato, eterno, inarrestabile, generativo di queste continue trasformazioni è appunto quella dimensione della Materia Immortale che può essere correttamente chiamata logos o mente o Prònoia o egemonico o proairesi del cosmo e della quale la proairesi ragionante dell’uomo è come un’immagine, avendone la medesima natura.
Una volta assodata la mente come una delle facoltà della Materia, che poi la cosmologia di Marco Aurelio si fondi sull’esistenza di soli quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco; invece che di circa un centinaio di specie atomiche presenti nell’universo in percentuali quantitativamente variabili, fa assai poca differenza.
[ IV,5 ] La nascita e la morte di qualunque cosa sono eventi opposti ma non contraddittori, e rappresentano l’eterna aggregazione e dissoluzione dei medesimi elementi e della medesima energia senza la scomparsa di neppure un solo quanto di essi.
[ IV,6 ] Il cosmo è tale per cui ogni cosa che in esso vi nasce è necessariamente destinata a morire, e da ogni cosa che vi muore un’altra è necessariamente destinata a nascerne.
[ IV,7 ] Il danno è, per l’uomo, il giudizio di essere stato danneggiato.
[ IV,8 ] Ciò che è aproairetico può uccidere la proairesi umana ma non farle danno, e dunque nulla di aproairetico ha il potere di rendere un individuo peggiore o migliore.
[ IV,9 ] La proairesi sceglie sempre ed inviolabilmente ciò che ad essa appare essere il proprio utile.
[ IV,10 ] Il solo retto giudizio che la proairesi umana può e deve pronunciare dinanzi a qualunque evento aproairetico in quanto tale è che esso è indifferente, che esso non è né bene né male. Pertanto, ad esempio, l’eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei circa un secolo prima che Marco Aurelio scrivesse questo frammento può certamente essere concepita come ‘conseguenza’ di leggi naturali, ma certamente né a queste né all’eruzione del Vesuvio si attaglia l’attribuzione di essere ‘giusta’ o ingiusta, secondo ‘giustizia’ o in contrasto con la giustizia.
Laddove invece tutto ciò che accade come ‘conseguenza’ accade anche secondo ‘giustizia’ e mai secondo ingiustizia, è nell’ambito degli eventi proairetici. Qui, nella proairesi dell’essere umano e soltanto in essa, tutto ciò che accade accade giustamente, in quanto premio e punizione, virtù e vizio, felicità e infelicità sono tutt’uno con l’atteggiamento, diairetico o controdiairetico, che essa assume. Pertanto la proairesi che rifiuta di riconoscersi per natura delle cose libera, infinita, inasservibile, insubordinabile e si atteggia in modo controdiairetico ha con ciò stesso già snaturato e punito se stessa.
[ IV,11 ] Che differenza c’è tra chi oltraggia e chi è oltraggiato se le loro proairesi sono entrambe mosse dalla controdiairesi?
[ IV,12 ] Giulio Capitolino racconta nella ‘Storia Augusta’ che nel 138 d.C., quando l’allora diciassettenne Marco Aurelio seppe di essere stato adottato da Adriano fu atterrito e non allietato dalla notizia; e che quando gli fu intimato di recarsi ad abitare nella casa privata di Adriano lasciò la casa materna con estrema riluttanza. Ed a chi gli chiedeva perché egli fosse triste per l’adozione imperiale, Marco Aurelio enumerò le disgrazie e i mali che può contenere in sé il potere imperiale. È dunque certo, grazie anche altre evidenze, che Marco Aurelio non ambì all’impero ma che fu scelto dalla sorte per quella carica.
Ora, chi giudica che diventare imperatore sia un bene in quanto intrinsecamente produttivo di felicità propria e altrui, come giudicano le turbe di microimperatori insipienti che non sanno di cosa parlano e vanno sotto il nome di cittadini, smanierà e bramerà, benché invano, una simile carica e toccherebbe il cielo con un dito se gli toccasse di ricoprirla.
Chi giudica che diventare imperatore sia un male, in quanto intrinsecamente ostativo alla felicità propria e altrui, farà di tutto per evitare tale carica per sé e soprattutto, senza avere coscienza della terribile contraddizione in cui si dibatte, riterrà giusto che la aborrano gli altri e tenderà ad istituirsi come minoranza fanaticamente regicida fino all’esilio o alla morte.
Chi giudica invece che l’impero, come qualunque altra cosa esterna e aproairetica, non sia di per sè né un bene né un male, accetterà eventualmente la decisione della sorte e dimostrerà, se ne è capace, come si conduce in simili circostanze un uomo educato ad usare la diairesi e capace di vivere da libero in questo mondo.
Questo è il rischio che Marco Aurelio, a diciassette anni e con il batticuore, ha accettato di correre. Pur non essendo dotato, come egli stesso ammette, di un intelletto particolarmente brillante, vivendo a corte egli deve avere nel corso del tempo capito che la sorte lo aveva immerso in una fogna maleodorante, mefitica e che gli aveva affidato un lavoro più sporco di quello del pulitore dei più sudici cessi. Sul fatto che egli sia riuscito o meno a rendere decorosamente pulite le chiaviche che la sorte gli aveva affidato in custodia ognuno ha il diritto di avere la propria opinione. In ogni caso Marco Aurelio non ha rifiutato il lavoro, e le testimonianze storiche sono prevalentemente concordi nel valutare positivamente il suo operato, dandogli atto che egli, con le capacità che aveva, nelle condizioni e nei tempi che gli erano concessi, primo e forse unico nella storia si è sforzato di interpretare il proprio ruolo di augusto custode del merdaio, come quello di colui che può giovare agli uomini principalmente creando loro il minor numero di difficoltà e di complicazioni possibili in vista di un retto uso della proairesi e che è pronto ad accogliere qualunque suggerimento si dimostri il migliore a questo scopo.
[ IV,13 ] Per essere liberi, ossia felici, è sufficiente avere una retta proairesi.
[ IV,14 ] Tu sei un refolo di vento nell’aria di primavera. C’è qualcosa di strano in questo?
[ IV,15 ] Tu sei una fiammella nel caminetto. C’è qualcosa di strano in questo?
[ IV,16 ] Tu sarai venerato come un dio dagli insipienti se userai, come loro e più di loro, la controdiairesi. C’è qualcosa di strano in questo?
[ IV,17 ] La virtù, come il vizio, è soltanto nel presente.
[ IV,18 ] Il virtuoso è apportatore di luce, di vitalità, di semplicità, di chiarezza, di calore.
[ IV,19 ] La fama presso i posteri è qualcosa di proairetico o di aproairetico? È essa in mio esclusivo potere o non è in mio esclusivo potere? A queste domande chiunque risponderebbe correttamente che la fama presso i posteri è qualcosa di aproairetico, qualcosa che non è in mio esclusivo potere. È dunque da sapienti o da insipienti trascurare lo stato della propria proairesi per preoccuparsi della propria fama presso i posteri?
[ IV,20 ] Questa preziosa testimonianza di Marco Aurelio certifica che ormai da migliaia di anni è invalso comunemente in Occidente l’uso di chiamare ‘belli’ oggetti esterni ed aproairetici, invece di riservare l’aggettivo ‘bello’, com’è corretto fare, esclusivamente alla virtù e alle sue opere, ossia alla proairesi atteggiata diaireticamente. Questo accade perché e quando è spezzato nelle turbe degli esseri umani il collegamento tra virtù ed atti di giudizio. Essi credono che l’infelicità sia causata dagli oggetti esterni e rechi l’impronta della loro inevitabilità, giacché hanno perso il senso della verità seguente: non la morte mi fa infelice, bensì l’errato giudizio che la morte sia un male.
L’uso di massa scorretto e improprio dell’aggettivo ‘bello’ segnala inoltre drammaticamente la devastante contraddizione nella quale si dibatte la proairesi umana atteggiata controdiaireticamente, giacché essa tradisce in questo modo la sua perdita di contatto con la natura delle cose, la quale stabilisce invariabilmente ed inviolabilmente per chiunque che il giudizio di lode o di biasimo di un evento o di un oggetto qualunque non può mai diventare una sua qualità.
[ IV,21 ] Marco Aurelio mostra spesso, nelle sue riflessioni, un’acuta attenzione alle questioni cosmologiche e di tipo fisico-naturalistico, indubbiamente derivata anche dal suo interesse per la filosofia peripatetica e dagli studi condotti sotto la guida di Claudio Severo Arabiano. Per esempio, egli si chiede qui cosa accadrebbe se gli animi di tutte le creature viventi sopravvivessero dopo la morte. Potrebbe l’elemento aria esserne ad un certo punto saturato e non avere più spazio per il loro numero continuamente crescente? Senza bisogno di discostarsi dalla cosmologia del suo tempo, gli basta l’osservazione empirica del destino degli alimenti e dei cadaveri a convincerlo delle possibili reciproche trasformazioni dei quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco; e a permettergli di dare in questo modo risposta alla domanda.
Notevole è l’uso che Marco Aurelio fa qui per la prima volta del sostantivo ‘diairesi’, sostantivo che egli impiega soltanto tre volte in tutta l’opera. Esso significa, in questo caso, ‘distinzione’ concettuale, proairetica, tra la componente materiale, ossia i quattro elementi suddetti, e la componente causale, ossia il logos, i quali sappiamo però essere entità inseparabili in quanto aventi tra di esse lo stesso rapporto che esiste tra i due poli di un magnete.
[ IV,22 ] Per meritare l’assenso di una retta proairesi una rappresentazione deve essere catalettica, essere cioè dotata di perfetta evidenza e certezza. Se vediamo qualcuno fare un bagno frettolosamente dobbiamo assentire alla rappresentazione che qualcuno fa un bagno frettolosamente, non alla rappresentazione che qualcuno fa male il bagno. Se vediamo qualcuno bere molto vino dobbiamo assentire alla rappresentazione che qualcuno beve molto vino, non alla rappresentazione che qualcuno beve male. Prima di averne vagliato i giudizi, infatti, come possiamo sapere se sta facendo bene o male? In questo modo non ci avverrà di avere rappresentazioni catalettiche di certe cose e di assentire ad altre. Non ‘divagare’ significa appunto, in questo frammento, non perdere il contatto con la natura delle cose; il che si sostanza, nell’ambito degli impulsi e delle repulsioni, con l’esplicare ciò che Epitteto chiama in modo filosoficamente rigoroso il ‘doveroso’ e che Marco Aurelio indica qui come il ‘giusto’ e, nell’ambito degli assensi e dei dissensi, il ‘catalettico’.
[ IV,23 ] Diceva Epitteto: “Che altro posso io, vecchio zoppo, se non inneggiare a Zeus? Se fossi un usignolo farei quel che fa un usignolo; se fossi un cigno, quel che fa un cigno. Ora, sono una creatura logica: bisogna che inneggi alla Materia Immortale. Questa è l’opera mia“.
Il frammento poetico citato è di Aristofane e la città di Cecrope è Atene.
[ IV,24 ] La proairesi atteggiata controdiaireticamente vede il proprio bene e il proprio male fuori di sé, nelle cose esterne ed aproairetiche, e questo la costringe ad una prodigiosa moltiplicazione dell’inutile e del superfluo. Il che fa tutt’uno con la nostra incapacità di usare la diairesi e di distinguere quel poco che ci è davvero utile e necessario per vivere bene.
Il detto proverbiale che apre il frammento è attribuito a Democrito.
[ IV,25 ] Dopo avere fatto tanta esperienza della tragica catena di controdiairesi, vizio e infelicità, prova una buona volta ad usare la diairesi; prova a seguire le orme di un uomo virtuoso e felice!
[ IV,26 ] Gli esseri umani usano la proairesi ogni giorno e ogni ora del giorno, sia nel bene che nel male. Dunque dipende esclusivamente da me sconcertarmi o non sconcertarmi di fronte ad un avvenimento, comprenderne o fraintenderne l’origine e il significato, essere giusto o ingiusto con qualcuno.
[ IV,27 ] Un ordine immutabile, razionale, perfetto e necessario che governa e sorregge infallibilmente tutte le cose e le fa essere e conservarsi quelle che sono. Questa è, secondo Marco Aurelio, la rappresentazione del cosmo cui conducono il rigoroso materialismo e il rigoroso monismo degli Stoici. Egli la condivide e guarda al cosmo come ad un’unità organizzata e indivisibile dotata di un logos o Prònoia o egemonico del quale la proairesi o egemonico dell’uomo è come un’immagine, un riflesso del quale il virtuoso ha esperienza empirica quando, usando la diairesi, si sente ordinato e bello dentro.
Nel contempo, Marco Aurelio mostra di intendere l’ipotesi atomistica di Democrito e di Epicuro, che pure poggia anch’essa su basi rigorosamente materialistiche, come radicalmente alternativa a quella stoica, come un’ipotesi negatrice del cosmo e che prospetta l’esistente come un guazzabuglio intrinsecamente disordinato, casuale e privo di unità.
[ IV,28 ] Non c’è uno solo, fra di voi che leggete, che non sappia di chi si parla: dunque è inutile fare nomi.
[ IV,29 ] Un individuo risiede da tanto tempo in una città me ne ignora le leggi e le abitudini. Non sa di cosa qui si ha potestà e di cosa non si ha potestà. Usa desiderio ed avversione, impulso e repulsione, assenso e dissenso a casaccio, come capita e senza tener conto della natura delle cose. Vuole quanto non è dato avere e non vuole quanto è necessario. Crede di potere impunemente trasgredire il confine che separa quanto è suo peculiare e quanto è allotrio. Chi, dunque, è straniero nel cosmo?
[ IV,30 ] Il frammento evidenzia in modo esplicito e drammatico la terribile differenza che intercorre tra il vivere filosoficamente e il chiacchierare di tesi filosofiche dall’alto di una cattedra o di un trono.
Epitteto soleva ripetere che vergognoso non è non avere una tunica, un libro, di che mangiare, bensì avere una ragione incapace di liberarci dall’afflizione e dalla paura di non avere una tunica, un libro, di che mangiare.
Io invece, pare confessare Marco Aurelio, ho tuniche, libri, pane eppure sento serrarmi il cuore, sento di non riuscire a consolarmi del tutto del mio destino quando ripenso al giorno in cui fui chiamato a scegliere tra l’accettare o il rifiutare l’adozione imperiale e la mia proairesi scelse, avevo diciassette anni e forse fu per paura e per viltà, di accettare.
[ IV,31 ] Se la mia proairesi scelse allora come scelse, parrebbe continuare Marco Aurelio, essa ha però imparato poi a coltivare l’albero della diairesi, albero dai cui rami pende anche un frutto che contiene la piccola arte di governare quanto si può e come si deve. A questa coltura essa rimarrà ormai fedele a qualunque prezzo, anche se nessuno capisce di cosa io stia parlando ed anche se nessuno mi crede.
[ IV,32 ] Tutto, infatti, è nella sua essenza sempre uguale dappertutto e noi siamo venuti al mondo non per cambiarlo ma per farvi vivere l’albero della diairesi, che cresce egualmente bene in qualunque uomo, ed esservi felici.
[ IV,33 ] Se la fama presso i posteri è puro vuoto, ecco a cosa dobbiamo rivolgere la nostra industria nell’ambito degli assensi, degli impulsi e dei desideri.
[ IV,34 ] L’offerta di sé a Cloto, la filatrice dello stame della vita umana.
[ IV,35 ] Come qualunque altra creatura, anche noi siamo esseri inevitabilmente precari.
[ IV,36 ] Tutto è in continua trasformazione.
[ IV,37 ] Tra poco sarai morto e devi riconoscere di non essere ancora al riparo da tante aberrazioni.
[ IV,38 ] Mostrami i giudizi della tua proairesi e ti dirò chi sei.
[ IV,39 ] Nulla di ciò che avviene nel cosmo può essere contro natura. Soltanto la proairesi dell’uomo può atteggiarsi non contro natura bensì contro la natura delle cose, generando così il proprio male; oppure secondo la natura delle cose, generando così il proprio bene.
[ IV,40 ] Il cosmo è un’unità, una sola creatura vivente.
[ IV,41 ] Chi può dire del corpo umano vivente, il quale è una macchina naturale meravigliosa, straordinariamente sofisticata e complessa, che è null’altro che ‘cadavere’?
Chi può dire della proairesi che il corpo umano è capace di esprimere, la quale è per natura libera, infinita, inasservibile, insubordinabile, che è ‘animuzza’ da nulla?
Pare di sentire queste parole uscire dalla bocca dei generali francesi i quali, vedendosi sconfitti militarmente dalle armate tedesche nel giugno del 1940, per spingere il governo del loro paese alla capitolazione e staccarlo dalla decisione britannica di continuare la resistenza contro la Germania nazista fino alla fine e a qualunque costo, assicuravano il loro Primo Ministro che nel giro di tre settimane Hitler avrebbe tirato il collo all’Inghilterra come ad un pollo. Assicurazione che il capo del Governo inglese Winston Churchill, parlando al Parlamento Canadese un anno e mezzo dopo, il 30 Dicembre 1941, poteva commentare con queste due semplici battute riferite al proprio paese: “Che pollo! che collo!” ; come se qui Epitteto dicesse: “Che animuzza! che cadavere!”
Queste sono dunque parole che si possono intendere messe da Epitteto in bocca agli insipienti, ma non sarà mai esclusa la possibilità di intenderle compuntamente come una penetrante meditazione nella quale, con immagine icastica, si raffigura il vivere come una fragile animuncola che trasporta un cadavere. Quel cadavere che sarebbe, ovviamente, l’uomo.
[ IV,42 ] Nulla di aproairetico è male o è bene.
[ IV,43 ] Lo spettacolo che abbiamo davanti è quello di un incessante e tumultuoso scorrere di eventi, nel quale la nostra proairesi può scoprire il modo di trovarsi perfettamente a proprio agio.
[ IV,44 ] Come le rose a primavera e la frutta d’estate, gli insipienti si allieteranno o si affliggeranno sempre di ciò che è esterno ed aproairetico: del pane e della morte, dei porci e della maldicenza.
[ IV,45 ] Il tema di questo frammento è certamente la generale connessione logica esistente tra premesse e conseguenze, tra antecedenti e conseguenti, ma l’indeterminatezza in cui è lasciato il soggetto ne rende ardua una comprensione univoca, lasciandolo aperto a varie interpretazioni possibili. La più semplice potrebbe essere rappresentata dall’interpretarlo come diretta continuazione del pensiero precedente e dunque come una presa d’atto del fatto, secondo Marco Aurelio inspiegabile nei termini dell’ipotesi puramente atomistica e meccanicistica di Democrito e di Epicuro, che una rosa genera sempre delle rose, un melo delle mele, e gli stupidi generano sempre infelicità.
L’osservazione e la relativa domanda paiono ovvie e banali, ma così non è; giacché se è vero che già Marco Aurelio era in grado di rispondere scientificamente alla domanda sul perché gli stupidi sono sempre generatori di infelicità, sarebbero dovuti passare migliaia di anni prima che si riuscisse a rispondere con altrettanto rigore alla domanda sul come una rosa generi sempre delle rose e un melo dei meli.
[ IV,46 ] I vari detti di Eraclito qui ricordati da Marco Aurelio si prestano bene a condensare due tesi fondamentali degli Stoici. Il primo detto richiama l’unitarietà e la continua trasformazione del cosmo. Il filo conduttore che lega i restanti cinque è rappresentato dal corretto uso che la proairesi deve fare della ragione e richiama la tesi stoica per cui la proairesi grazie alla quale siamo felici è la stessa grazie alla quale siamo infelici.
[ IV,47 ] Le folle che fanno da sfondo in questo frammento sono quelle di coloro che non hanno mai sperimentato in vita loro cosa sia un giudizio virtuoso né cosa siano libertà e felicità, e che proiettano costantemente nel futuro l’accadere di tali ‘miracoli’ oppure li rimandano infingardamente ad un’altra vita che essi fantasticano di vivere dopo la morte. Virtù e vizio, felicità e infelicità, libertà e schiavitù sono invece nel presente, non sono questioni di tempo ma di atteggiamento della nostra proairesi.
[ IV,48 ] Molti credono che la vita umana non abbia un frutto e sia un’inutile miseria. La vita dell’uomo, invece, ha un frutto, non è un’inutile miseria. Inutile miseria è l’ignoranza che ci spinge al vizio e l’infelicità che ci fa credere di essere nulla o di essere immortali. Il frutto della vita dell’uomo è la sua libertà, la sua felicità, la sua virtù.
Se un’oliva diventata matura potesse parlare, cadrebbe elogiando la natura che l’ha apportata e rendendo grazie all’albero che l’ha generata. All’ombra dell’albero della diairesi, anche la vita dell’uomo è un tempo irripetibile e fruttuoso che merita di essere attraversato mantenendo la nostra proairesi in armonia con la natura delle cose.
[ IV,49 ] Esclusi soltanto il primo e l’ultimo paragrafo, per convincenti ragioni principalmente lessicografiche questo frammento è da molti studiosi ritenuto una citazione autentica e diretta di parole di Epitteto, tratta da qualche opera che non ci è pervenuta. E non vi si può non ammirare lo straordinario vigore e l’incisività mozzafiato con la quale vi si rappresentano la natura delle cose e dell’uomo, e si evidenzia la proairesi nei suoi due atteggiamenti possibili di fronte a ciò che è esterno e aproairetico.
Di Marco Aurelio sono invece la potente immagine della retta proairesi come roccioso e saldo promontorio contro il quale i flutti del mare infine si calmano e l’ammonimento finale a non credere sfortuna ciò che invece è una fortuna saper sopportare nobilmente.
[ IV,50 ] Un aiuto semplice ed efficace per non avere paura della morte è quello di comprendere fino in fondo che, tra fatiche e difficoltà di ogni genere, il fine della vita umana è quello di conoscere la natura delle cose e quindi vivere in modo ammissibile con essa, virtuosamente e felicemente. Quando questo fine sia raggiunto, non vi è differenza tra chi lascia la vita essendovi pervenuto dopo un dato numero di anni e chi lascia la vita essendovi pervenuto dopo il triplo di anni. E neppure vi è differenza tra chi muore dopo un dato numero di anni senza avere mai raggiunto quel fine e chi muore, senza averlo mai raggiunto, dopo un numero triplo di anni. Anni che sono comunque ben poca cosa rispetto all’eternità.
Cecidiano, Fabio, Giuliano e Lepido sono nomi qualunque di persone verosimilmente longeve. Nestore è il personaggio omerico, re di Pilo, cui il mito attribuisce una vita lunghissima.
[ IV,51 ] Un pressante invito di Marco Aurelio ad usare la diairesi e gli ovvi vantaggi che quest’uso comporta.
*****
[ V,1 ] Il silenzioso colloquio con se stesso di un essere umano nel quale si fronteggiano due principi in contrasto: uno, che lo spinge a badare unicamente al proprio ‘piacere’; e un altro, che si appella alla ‘realtà’ e cerca giudiziosamente di convincerlo ad assolvere il compito per il quale è al mondo. Alla fine, le ragioni della realtà prevalgono su quelle del piacere ed inizia così una nuova giornata di ordinario lavoro. Questa interpretazione, comunemente proposta per la comprensione del frammento, è la sola possibile? Le cose stanno davvero così?
Chi è intimamente convinto dell’utilità e della bontà del lavoro che gli tocca fare, come una madre la quale non si lamenta mai di dover vegliare o di doversi svegliare a qualunque ora della notte per allattare al seno il suo bimbo appena nato, vivrebbe l’intimo contrasto che qui ci è testimoniato? La risposta certa ed univoca è: no! La natura delle cose, infatti, vieta inviolabilmente di ritenere una cosa giusta e di farne un’altra, di vedere un bene e di non desiderarlo, di vedere un male e di non fuggirlo.
Se dunque Marco Aurelio è drammaticamente riluttante ad iniziare la sua giornata di ordinario lavoro è perché in realtà giudica che si tratti di un’ennesima giornata di ordinaria follia, la cui unica giustificazione risiederebbe nel fare, da imperatore, ‘azioni socievoli’ e volte al ‘bene comune’.
Qual è, invece, la menzogna del ‘bene comune’? Qual è la menzogna insita necessariamente nel ‘potere’ e nelle ‘istituzioni’, che Marco Aurelio incarna e qui ci testimonia?
La menzogna del ‘potere’ e delle ‘istituzioni’ è né più né meno la menzogna della controdiairesi, laddove essa proclama in suo esclusivo potere ciò che invece, per inviolabile natura delle cose, non è in suo esclusivo potere; e dunque laddove il potere e l’istituzione propongono se stessi come portatori di bene comune, di libertà e di felicità per il genere umano. La proairesi di Marco Aurelio, quando e in quanto stoicamente orientata, non può che ribellarsi continuamente all’uso della controdiairesi alla quale si costringe accettando di sedere sul trono di un grande impero, e pertanto vive la maggior parte del suo tempo in drammatica contraddizione con se stessa.
[ V,2 ] La proairesi è per natura capace, ed è fatta per avere il dominio delle rappresentazioni, non per esserne dominata.
[ V,3 ] Conoscere la natura delle cose significa saperne riconoscere la essenziale bipartizione e la sua inviolabilità, dunque praticare la diairesi, giudicandoci degni di dire e fare tutto ciò che è in accordo con essa. E quando tu, vagliato che una cosa è da fare, la faccia; non fuggire mai dall’essere visto effettuarla anche se il gregge che hai intorno concepirà qualcosa di diverso al riguardo. Giacché se non operi rettamente, fuggi l’opera stessa. Se operi rettamente, perché hai paura di coloro che censureranno non rettamente?
[ V,4 ] È noto che nella cosmologia stoica il fuoco è il principio generativo, origine e fine degli altri tre elementi (aria, acqua, terra) che da esso si generano e che in esso sono destinati a riconfluire nella conflagrazione finale che segna la fine di un ciclo cosmico e l’inizio di uno nuovo.
Ed è altrettanto noto che il principale rito funebre del tempo era la cremazione. Grazie ad essa Marco Aurelio, con intensa commozione, descrive qui i primi passi del suo ritorno al fuoco primordiale.
[ V,5 ] Un uomo corre più velocemente di un altro. Diremo che il primo è un uomo e che il secondo non lo è? L’uomo è definito dalla capacità della sua proairesi di atteggiarsi diaireticamente o controdiaireticamente e non dalla velocità della sua corsa o dalla brillantezza del suo intelletto; velocità o brillantezza che, come il colore degli occhi o l’altezza, non sono proairetiche ma legate a fattori esterni ed aproairetici.
Chi prende atto del suo scarso acume, se davvero è così, come prenderebbe atto di correre meno velocemente di un altro e non si affligge quando riconosce che altri sono più veloci di lui o hanno un intelletto più brillante del suo, mostra di usare la diairesi, di saper mantenere la propria proairesi libera, infinita, inasservibile, insubordinabile e dunque felice.
Chi invece si affligge del suo scarso acume, come Marco Aurelio qui confessa apertamente di se stesso, lo fa perché vuole che sia in suo esclusivo potere una brillantezza di intelletto che non è in suo esclusivo potere avere. Egli tradisce così, da imperatore e non da stoico, la sua quotidiana pratica della controdiairesi, che rende la sua proairesi serva, preda di giudizi scorretti, che lo fa vivere in contraddizione con se stesso. Ulteriore esempio di come, se non ci si corregge, si possa sedere su un trono imperiale, fraintendere il proprio ruolo ed essere schiavi e infelici.
[ V,6 ] Quando si identifica con lo stoico che è in lui, Marco Aurelio dice: “Se è vero che bene e male sono entità proairetiche, giudizi della proairesi, allora virtù e vizio, premio e punizione sono insiti nelle nostre deliberazioni e nelle conseguenti azioni che compiamo, e non vanno attesi come contraccambio dall’esterno”. Ma subito l’imperatore che è in lui risponde: “Voglio che le deliberazioni che quotidianamente prendo siano riconosciute come beni, e il mio virtuoso operato al servizio della comunità sia lodato”. Come se non bastasse, Giulio Capitolino riferisce che Marco Aurelio era sempre preoccupatissimo della propria reputazione e che chiedeva continuamente ai suoi collaboratori cosa si dicesse in giro di lui, giustificandosi col desiderio di emendare i propri difetti laddove riconoscesse fondate alcune critiche.
[ V,7 ] Come si deve auspicare?
È impossibile dire da dove Marco Aurelio abbia preso il testo qui riferito.
[ V,8 ] Tutto ciò che non è in nostro esclusivo potere, ossia tutto ciò che è aproairetico, va riconosciuto e trattato come tale grazie all’uso sistematico della diairesi.
La malattia, la perdita di un figlio, la morte sono entità aproairetiche. E come vanno trattate? Come le lettere dell’alfabeto di una lingua che non siamo stati noi ad inventare ma che impariamo stando al mondo. Scriviamo forse la parola “Dione” a casaccio, secondo l’impulso del momento? No, ma impariamo a disporre le lettere affinché sia scritta come si deve. Cosa facciamo con le note musicali? Allo stesso modo. Cosa facciamo, in generale, laddove è in gioco un’arte od una scienza? Altrimenti, di nessun valore sarebbe l’avere scienza di qualcosa, se ciò si acconciasse alle decisioni di ciascuno. Qui dunque, soltanto su quanto è massimo e sommamente dominante, sulla libertà e sulla felicità, ci è stato accordato di volere come capita? Nient’affatto! Ma educarsi a diairesizzare è appunto questo imparare a disporre ciascuna cosa così come accade. E come accade? Come da sempre la costituisce quell’insieme di tutte le cause che si può chiamare natura o necessità o destino o Zeus. Ed esso costituì che vi fossero estate ed inverno, profusione e penuria, virtù e vizio, diairesi e controdiairesi, e tutte le opposizioni siffatte per l’armonia dell’intero e che ognuno di noi, imparandone la lingua, potesse scrivere correttamente, se così dispone, la parola “Felicità”.
Asclepio è il dio greco della medicina, figlio di Apollo e di Coronide, che il mito vuole sia stato ucciso da Zeus con un fulmine perché aveva resuscitato dalla morte alcuni uomini.
[ V,9 ] La filosofia stoica è la sola filosofia esistente la cui essenza non sia normativa. Come una buona madre, essa non ci insegna a riconoscere altro che ciò che ineluttabilmente dispone la nostra natura di uomini, ed educa alla diairesi quella sola facoltà che in noi è comprensione e scienza di noi stessi e delle cose che accadono, ossia la proairesi.
[ V,10 ] Di fronte all’enigmaticità della realtà, alla pochezza e caducità di tutti gli oggetti materiali, ai violenti contrasti e alle guerre mortali che gli uomini conducono gli uni contro gli altri, alla volubilità delle loro idee e al sudiciume dei loro costumi, la maggioranza dei filosofi ha decretato la incomprensibilità del tutto e le ideologie hanno fatto bancarotta.
Gli unici a non spaventarsi di questa situazione e ad avere trovato la chiave per capire la realtà e portare la libertà in questo mondo sono stati, e sono ancora oggi, gli stoici i quali si sono chiesti se, in tale flusso e in tali tenebre, tutto ciò che esiste sia in nostro esclusivo potere, oppure nulla di ciò che esiste sia in nostro esclusivo potere, oppure se di ciò che esiste alcune cose siano in nostro esclusivo potere ed altre non lo siano. Essi hanno così potuto dimostrare definitivamente che delle cose che sono, alcune sono in nostro esclusivo potere mentre altre non sono in nostro esclusivo potere. In nostro esclusivo potere sono, ad esempio, giudizi, valutazioni, progetti, desideri, impulsi ed hanno chiamato queste entità ‘proairetiche’. Non sono invece in nostro esclusivo potere cose come il corpo, il denaro, la reputazione, il lavoro, che vanno definite entità ‘aproairetiche’. Ed hanno altrettanto definitivamente dimostrato che questa è sempre stata, è, e sempre sarà la ‘natura delle cose’, la quale è universalmente valida, invariante e inviolabile.
Se la diairesi è il giudizio che ci fa capaci di distinguere in qualunque circostanza quanto è in nostro esclusivo potere e quanto invece non lo è, allora l’uomo conosce il segreto per trovare il giusto comportamento in ogni situazione, giacché non ci potrà avvenire nulla che non sia in armonia con la natura, ed è in esclusivo potere della nostra proairesi fare sì che noi non facciamo nulla che sia in contrasto con la natura delle cose.
[ V,11 ] È la proairesi o egemonico la parte costitutiva capace di comandare all’animo. E, a seconda dei giudizi retti o scorretti presenti nella proairesi, del suo atteggiarsi diaireticamente o controdiaireticamente, l’animo dell’uomo sarà libero dalle passioni o preda delle passioni, sarà quello di un sapiente o quello di un insipiente.
[ V,12 ] Anche quella contenuta in questo frammento è una preziosa testimonianza del fatto che da migliaia di anni si chiamano comunemente ‘beni’ gli oggetti esterni ed aproairetici, invece di riservare il temine, com’è corretto fare, esclusivamente alla virtù e alle sue opere, ossia alla proairesi atteggiata diaireticamente.
La constatazione che per le turbe umane ‘beni’ e ‘mali’ sono oggetti esterni e aproairetici non sposta di una virgola la verità che felicità e infelicità non sono qualità di ciò che è aproairetico e che ‘beni’ e ‘mali’ sono per invariante, eterna, inviolabile natura delle cose entità proairetiche. Questo null’altro segnala che la assenza di contatto delle turbe, se mai contatto vi fu, dalla natura delle cose, la quale comunque rimane quella che fu, è, e sarà sempre, senza che spetti ad essa di darsi la minima cura di dove gli uomini cacano o non cacano.
Il frammento poetico citato è tratto da una commedia di Menandro.
[ V,13 ] La componente causale è la proairesi o egemonico, la componente materiale è rappresentata dagli elementi naturali (aria o pneuma, acqua, terra e fuoco) che compongono l’uomo.
Bisogna stare in guardia dal compiere l’errore di intendere la componente causale, la proairesi, come ‘res cogitans’ e la componente materiale come ‘res extensa’, secondo un dualismo che ha avuto ed ha ancora grande successo di massa, ma che è del tutto infondato, come dimostra a iosa la moderna neurobiologia molecolare, e completamente alieno allo stoicismo antico ed a Marco Aurelio. Componente causale e componente materiale sono come il magnete con i suoi due poli, sono entrambe ‘corpo’, Materia Immortale dalle cui trasformazioni eternamente nasce, muore e rinasce tutto l’esistente.
[ V,14 ] Siccome quanto articola le altre conoscenze è la logica ed essa non può né essere né rimanere disarticolata, da che cosa sarà articolata? E’ manifesto che lo sarà o da se stessa o da qualcos’altro. Questo o è una seconda logica o qualcos’altro migliore della logica, il che però è impossibile. Se, pertanto, è una seconda logica chi, di nuovo, articolerà questa? Giacché se questa si autoarticola, anche la prima lo può. Se, infatti, ci fosse bisogno di una seconda logica, ci sarebbe poi bisogno di una terza a poi di una quarta logica, e il processo diventerebbe infinito. La ragione, pertanto, è la sola facoltà umana autoteoretica in quanto la logica, muovendosi con metodi e principi che le consentono di distinguere formalmente i ragionamenti corretti da quelli scorretti, è autonoma dalla materia alla quale è applicata.
[ V,15 ] Le turbe considerano che la ricchezza di denaro, i colpi di fortuna che portano lusso e fama oppure, al contrario, la povertà di denaro e la malattia, siano un bene o un male. Se fosse vero che gli oggetti esterni ed aproairetici sono bene o male, tutti gli uomini dovrebbero concordare nel ritenere bene e male le stesse cose, così come concordano nel ritenere luminoso il sole e che i cani abbaiano. Essendo invece gli uomini in continuo e feroce contrasto tra di loro riguardo a ciò che considerano bene o male, è impossibile sostenere che bene e male siano qualità oggettive di ciò che è esterno e aproairetico.
Se è così, ciò che spetta all’uomo in quanto uomo, ciò che ne definisce la natura, va ricercato non fuori dell’uomo ma dentro l’uomo stesso. E si può trovare? Sì. E dov’è? Nella proairesi. Infatti, è dimostrato che spettano all’uomo in quanto uomo unicamente i suoi giudizi su di sé e su ciò che è aproairetico. Soltanto questi giudizi, che sono proairetici, opera della sua proairesi, possono a buon diritto essere considerati propri dell’uomo in quanto uomo e sono soltanto essi ad essere il suo bene o il suo male.
[ V,16 ] Si può, si deve ed è inevitabile che l’uomo abbia a che fare con le cose esterne e aproairetiche. Ma quando egli si dà da fare intorno ad esse senza riserva, come se fossero in suo esclusivo potere mentre invece, per inviolabile natura delle cose, esse non lo sono; ecco che l’uomo perde se stesso.
Chi, dunque, può affermare che essendoci dato di vivere a corte ci è anche dato, per ciò stesso e senza ulteriori precisazioni, di vivere bene a corte; tacendo il fatto che non si può vivere laddove e quando c’è troppo fumo e dunque che vivere bene a corte può anche essere impossibile?
La creatura razionale ha come fine cardinale quello di mantenere la propria proairesi in accordo con la natura delle cose. Chi dunque può affermare, senza ulteriori distinzioni, che la creatura razionale è nata per la vita in società e per operare il bene comune, se non chi vede il bene principalmente fuori di sé, nel dominio di ciò che è esterno e aproairetico?
Certamente le creature razionali hanno facoltà che altre creature non hanno. Ma chi può ritenersi superiore a tutti gli altri esseri quando anche i lupi, nel loro linguaggio, ringraziano certamente la Prònoia di avere fatto gli uomini così stupidi da massacrarsi l’un l’altro a milioni per offrire loro, in questo modo, dei lauti banchetti?
Se il frammento è anche soltanto parzialmente autobiografico, è difficile sfuggire alla sensazione che Marco Aurelio lo sprema dalla falsa coscienza di un insipiente che ha il problema di giustificare ex post le proprie scelte di vita, e che la sua autocritica sia rappresentata, né più né meno, dalle parole del frammento immediatamente successivo.
[ V,17 ] Il fine cardinale della vita degli insipienti è quello di far volare gli asini e di cavare sangue dalle rape.
[ V,18 ] Come mai la controdiairesi è una pratica di massa? È certamente difficile convincere qualcuno ad abbracciare la saggezza quando il suo guadagnarsi da mangiare dipende dal rimanere insipiente. La saggezza, pertanto, sarà sempre merce rarissima dovunque e finché la stabilità di un lavoro o di un incarico a corte, è fatto strettamente dipendere dalla stabilità della propria ignoranza della natura delle cose e della propria piaggeria.
[ V,19 ] Dei nostri giudizi è padrona la proairesi, non le cose esterne ed aproairetiche.
[ V,20 ] I giudizi, così come i desideri, gli impulsi, gli assensi della mia proairesi sono entità proairetiche. Anche i giudizi della proairesi di un altro uomo sono entità proairetiche. Proairetiche per lui, ma per me sono entità aproairetiche tanto quanto lo sono i miei giudizi per lui, giacché la natura delle cose vieta inviolabilmente che qualcuno sia padrone della proairesi di un altro. Questo significa anche che nessuna proairesi può essere intralciata da un’altra proairesi e tanto meno da ciò che è esterno e aproairetico.
Ora: quando vi è bisogno della collaborazione di qualcosa di esterno ed aproairetico per la realizzazione pratica di un’entità proairetica, questa realizzazione pratica è proairetica o aproairetica?
Sentiamo la risposta di Epitteto: “E dunque se mentre io desidero camminare, un altro me lo impedirà? -Cosa impedirà di te? Forse il desiderio?- No, ma il corpo. E però io non cammino più. -E chi ti ha mai detto che camminare è opera tua non soggetta ad impedimenti? Giacché io dicevo non soggetto ad impedimenti, ossia proairetico, soltanto il desiderio. Dove invece c’è bisogno del corpo e della sua cooperazione, sai bene da tempo che nulla è tuo”.
Così come un altro uomo è per me un oggetto esterno e aproairetico, anche la realizzazione di un progetto proairetico è qualcosa di aproairetico, in quanto non è in mio esclusivo potere. La retta proairesi, pertanto, è retta in quanto tiene conto della natura delle cose e subordina sempre i propri comandi ad una clausola di riserva laddove per la loro realizzazione ci sia bisogno della collaborazione di qualcosa di aproairetico come il corpo.
[ V,21 ] Delle quattro cause basilari operanti nel cosmo, quella cui Marco Aurelio qui allude più direttamente è la Prònoia, cui la Proairesi umana è omogenea, in quanto espressione entrambe del medesimo ‘logos’, e della quale è come un’immagine.
[ V,22 ] Morte, malattia, disastri naturali sono eventi del tutto fisiologici per quella città che è il cosmo e non lo danneggiano affatto, ma rappresentano semplici momenti delle sue incessanti trasformazioni. Perché dunque la proairesi dell’uomo dovrebbe giudicarli come mali dai quali ritenersi danneggiata?
Se il cosmo è indenne da qualunque danneggiamento, la proairesi dell’uomo può invece danneggiare se stessa, qualora trascuri di attenersi alla natura delle cose e di rispettarla attraverso l’uso della diairesi.
[ V,23 ] Il movimento incausato, perpetuo, inarrestabile della Materia immortale che tutto trasforma in rapidissima sequenza.
[ V,24 ] L’uomo è piccolissima parte della sostanza del cosmo e un istante appena della sua immortalità; ma egli, grazie alla proairesi, ha un ruolo decisivo nel proprio destino.
[ V,25 ] Se un altro agisce per offendere me, quella disposizione offensiva è proairetica o aproairetica? Ovviamente essa è aproairetica per me e proairetica per l’altro. Se è per me aproairetica, secondo saggezza io non devo vedere in essa né un bene né un male per me. Bene e male rimangono affare dell’altro, in quanto quella disposizione a offendere è propria della sua proairesi, non della mia.
C’è qualcosa di proairetico, di mio proprio, in questa situazione? Certamente. La mia proairesi entra in gioco nel giudizio che ho della disposizione della proairesi e delle azioni dell’altro. E qui la mia proairesi può assumere due diversi atteggiamenti. Se prende l’atteggiamento diairetico non mi sentirò offeso e cercherò anzi di far capire all’altro l’aberrazione che sta commettendo contro se stesso. Se invece prende l’atteggiamento controdiairetico mi sentirò offeso e quindi reagirò all’offesa con l’offesa.
Vi è una operazione matematica che è aberrante: quella di dividere per zero. Ecco, in molti casi l’uso della controdiairesi può essere paragonato all’esecuzione dell’operazione suddetta.
[ V,26 ] Le sensazioni fisiche che l’uomo prova (il dolce e l’amaro, il caldo e il freddo, il piacere sessuale, il dolore fisico) sorgono indipendentemente dalla nostra proairesi e sono, dunque, entità aproairetiche. Proairetico è invece il giudizio che la nostra proairesi dà di esse quando ne sia stata raggiunta, non in quanto piacevoli o dolorose ma in quanto bene o male.
Siccome bene e male sono per natura delle cose unicamente giudizi della nostra proairesi, la proairesi che si atteggia controdiaireticamente giudica le sensazioni fisiche essere bene o male, mentre la retta proairesi che si atteggia diaireticamente le riconoscerà ugualmente piacevoli o dolorose ma le giudicherà essere né bene né male.
[ V,27 ] Il demone che ci portiamo dentro e che è capace di farci convivere con gli dei, è la nostra proairesi.
[ V,28 ] Ecco la diairesi all’opera.
Al contrario, due personaggi emblematici che non mettono mai in opera la diairesi bensì si ostinano sistematicamente a dividere per zero quello che loro capita, sono quelli indicati da Marco Aurelio nell’ultimo paragrafo: i protagonisti delle tragedie e chi prostituisce il proprio corpo, simboli entrambi della proairesi che prostituisce se stessa attraverso l’uso della controdiairesi.
[ V,29 ] Queste sono le parole di Epitteto: “Uno ha fatto fumo nella stanza? Se il fumo è in quantità moderata, rimarrò; se è troppo, esco. Giacché si deve ricordare e tenere ben fermo che la porta è sempre aperta. Mi si ordina: ‘Non abitare a Nicopoli’. Non ci abito. ‘Neppure ad Atene’. Non abito ad Atene. ‘Neppure a Roma’. Non abito a Roma. ‘Abita a Giaro!’ Ci abito. Ma abitare a Giaro mi appare come abitare dove c’è troppo fumo. Mi ritiro laddove nessuno mi impedirà di abitare, giacché quella dimora è aperta a tutti”.
In questo frammento Marco Aurelio riprende esattamente il tema di un frammento precedente ma, questa volta, in accordo con la prospettiva correttamente stoica secondo la quale il fine cardinale della proairesi è quello di mantenere se stessa in armonia con la natura delle cose: libera, infinita, inasservibile, insubordinabile; e per cui il saggio, pertanto, per vivere può scegliere di morire. Paradosso soltanto apparente, ed eterno scandalo per le turbe insipienti e stolte che hanno paura di morire perché hanno paura di vivere e che vivono la morte credendo di vivere la vita.
[ V,30 ] Ovviamente non tutti gli esseri viventi si prestavano ad essere inseriti con facilità nel finalismo e nell’antropocentrismo di tradizione stoica. Ma l’acutezza di Crisippo, che echeggia nello sguardo di Marco Aurelio quando si incanta a guardare il cosmo, trovò sempre una via d’uscita: leoni, orsi, leopardi, cinghiali esistono per allenare i germi di coraggio presenti nell’uomo; i denti velenosi dei serpenti per fornire medicamenti; i topi ci abituano a stare attenti nel riporre le provviste di cibo; le cimici provvedono a che non dormiamo troppo e il pavone è stato generato in ragione della sua coda, perché noi possiamo ammirare lo splendore della sua coda.
Anche i Parti, i Quadi e i Marcomanni dovevano essere stati creati dalla Prònoia per qualcosa su cui però Marco Aurelio preferisce non soffermarsi.
[ V,31 ] Il frammento può certo sembrare il bilancio di una vita. Ma può anche essere inteso come l’invito ad un continuo riesame dello stato della propria proairesi e ad individuare e correggere l’eventuale ‘anomalia’ rappresentata da quell’atteggiamento della proairesi contrario alla natura delle cose che si chiama controdiairesi, ed a rallegrarsi di avere saputo usare la diairesi in tante occasioni.
Il verso citato è tratto dall’Odissea, libro IV°. Sono parole che Omero fa pronunciare a Penelope in riferimento ad Odisseo, quando Mentore sta per avvertirla che i Proci tramano un agguato mortale contro Telemaco.
[ V,32 ] Queste sono le parole di Epitteto sulle quali Marco Aurelio sembra riflettere: “Perché dunque quelli sono più potenti di voi? Perché quelli enunciano i loro schifosi discorsi da giudizi, mentre voi proferite i vostri raffinati discorsi dalle labbra. Per questo essi sono atoni e cadaverici; ed è possibile che a chi ascolta le vostre esortazioni e sente parlare di quella disgraziata virtù della quale blaterate su e giù, venga il ribrezzo. Così le persone comuni vi vincono: giacché ovunque il giudizio è potente, il giudizio è invincibile. […] Finché avrete le concezioni di cera, statevene dunque da qualche parte lontano dal sole”.
Si può avere arte e scienza soltanto di due cose: di ciò che è proairetico e di ciò che è aproairetico.
Proairetiche sono unicamente la proairesi e le opere della proairesi: desideri e avversioni, impulsi e repulsioni, assensi e dissensi, giudizi, progetti, concezioni. Insomma quell’unico gruppo di cose che è in esclusivo potere dell’uomo e che può diventare virtù, libertà, felicità. L’arte e la scienza di questo gruppo di cose si chiama scienza della felicità o Cultura. Sui poveri stracci che la Cultura sventola sta scritta la inviolabilità della natura delle cose, ossia l’ordine cosmico legato al governo del logos e l’ordine interiore, legato al governo della diairesi, che regna nella proairesi dell’uomo.
Ciò che è aproairetico si frammenta invece in miriadi di competenze diverse, giacché miriadi sono gli oggetti e i gruppi di oggetti esterni e aproairetici dei quali l’uomo può avere arte e scienza. L’arte e la scienza di tutto ciò che è aproairetico si chiama Pseudocultura. Essa ha come unico scopo il dominio dell’uomo su tutto ciò che è esterno e aproairetico (altri uomini compresi), obiettivo che essa persegue celandosi in vario modo dietro i veli di Maia rappresentati da ‘politica’, da ‘religione’, da ‘economia’, da ‘scienza’ e così via. Ma un simile scopo, come qualunque altro scopo, è e non può che essere proairetico, e dunque la Pseudocultura si adagia e coincide necessariamente, per inviolabile natura delle cose, con quell’atteggiamento della proairesi che va sotto il nome di controdiairesi. Sulle bandiere della Pseudocultura si proclama non essere in esclusivo potere dell’uomo ciò che invece è in suo esclusivo potere (ossia la virtù, la libertà, la felicità) ed essere in esclusivo potere dell’uomo ciò che invece non è in suo esclusivo potere (ossia tutto ciò che è esterno e aproairetico).
Coloro che in questo frammento Marco Aurelio chiama animi imperiti e incolti -e s’intende che sono turbe immense- sono imperiti e incolti di diairesi ma sono peritissimi e coltissimi di controdiairesi. E siccome la forza delle persone sta nella saldezza dei loro giudizi, davanti alla Pseudocultura di gente con una controdiairesi d’acciaio non c’è scampo per la presunta Cultura di filosofi con una diairesi di cera.
[ V,33 ] Lavorare per ottenere riconoscimenti e fama da una turba di individui viziosi, disonesti, turpi, che praticano sistematicamente la controdiairesi? Oltre che contraddittorio non sarebbe neppure un affare, perché il guadagno non coprirebbe le spese. Se gli esseri umani hanno scelto per se stessi questa misera sorte, è vizioso anche imprecare o scandalizzarsene. Bisogna lasciarli al loro destino badando, giacché questo è in nostro esclusivo potere, ad astenerci dal desiderare o avversare ciò che non è in nostro esclusivo potere, ossia essere temperanti; ed a sopportare l’intemperanza altrui giacché da essa, per inviolabile natura delle cose, in ogni caso non può venirci alcun male.
Il verso citato è tratto da “Le Opere e i Giorni” di Esiodo. Esiodo lo riferisce, esattamente come Marco Aurelio, al Rispetto di sé e degli altri e alla Nemesi che abbandonano gli esseri umani dell’odierna età del ferro al misero destino che essi hanno forgiato per sé.
[ V,34 ] La felicità è cosa proairetica, è il giudizio di essere felici. A disporlo in modo inviolabile e invariante per tutti gli uomini è la natura delle cose, la quale dispone anche in modo altrettanto inviolabile e invariante che è il logos o Prònoia a stabilire le leggi cui ubbidisce tutto ciò che è aproairetico.
Mentre la Prònoia non si mette mai in armi contro la Proairesi, la Proairesi dell’uomo, atteggiandosi controdiaireticamente, può mettersi in armi contro la Prònoia. Ma siccome la proairesi umana è parte del cosmo e non può violarne le leggi, la sua ribellione è destinata a quella sconfitta che prende appunto il nome di ‘infelicità’.
Due sono dunque le caratteristiche principali della Prònoia e della Proairesi: entrambe non possono essere intralciate altro che da se stesse, per entrambe il bene consiste nel rispetto della natura delle cose.
[ V,35 ] I retti giudizi sono i giudizi della proairesi che pratica la diairesi. Essi non portano danno.
[ V,36 ] Ubbidire alla natura delle cose è un conto, ma l’ubbidienza o la disubbidienza ad un’autorità qualunque diversa dalla natura delle cose non deve essere pronta, cieca e assoluta, bensì commisurata alle proprie capacità e al valore di quel che è richiesto. Allo stesso modo l’aiuto che altri richiedono non va concesso o negato sempre, comunque e a tutti i costi, ma commisurato anch’esso ai dati delle situazioni concrete, che sono sempre diverse una dall’altra. Se infatti si ubbidisce o disubbidisce a qualcuno oppure si aiuta o non si aiuta qualcuno lasciandosi semplicemente rapire dalla rappresentazione che ‘ubbidire’ e ‘aiutare’ sono ‘bene’ o sono ‘male’ noi stiamo ponendo il bene e il male fuori di noi stessi, stiamo subordinando il proairetico all’aproairetico, stiamo operando viziosamente.
*****
[ VI,1 ] Non esiste il male nel cosmo. Il male esiste soltanto nella proairesi degli esseri umani viziosi. La Prònoia che governa il cosmo, infatti, è legge razionale e verità, ossia natura delle cose, universalmente valida, invariante, inviolabile e tale legge non può essere contemporaneamente una ed il proprio opposto. Questo significa anche non esiste il bene nel cosmo. Il bene esiste soltanto nella proairesi degli uomini virtuosi.
[ VI,2 ] Siccome vivere significa atteggiare la proairesi diaireticamente, le circostanze esteriore non fanno al riguardo alcuna differenza, dato che questa operazione è in nostro esclusivo potere. Anche morire diventa così, per l’uomo virtuoso, un momento di vita.
[ VI,3 ] Chi guarda come si deve dentro un qualunque oggetto esterno vedrà che si tratta di qualcosa di aproairetico che è, per natura delle cose, debole, servo, soggetto ad impedimenti, finito.
Chi guarda dentro di sé come si deve, vi troverai una proairesi che è, per natura delle cose, libera, infinita, inasservibile, insubordinabile.
Il frammento invita a riconoscere proprio questa differenza.
[ VI,4 ] Nella cosmologia stoica, il destino di tutti gli elementi che compongono il cosmo è, da ultimo, quello di trasformarsi in fuoco primordiale, dal quale prenderà nuovamente inizio un nuovo ciclo cosmico. Se la sostanza del cosmo, invece, non fosse una ma fosse plurima, allora i suoi elementi potrebbero andare incontro a dispersione.
[ VI,5 ] Poiché la proairesi umana è facoltà autoteoretica, è legittimo chiedersi se anche la Prònoia del cosmo sia autoteoretica. Marco Aurelio, in questo frammento, da una risposta positiva a simile domanda, in accordo con una tradizione che non è soltanto stoica ma risale almeno al V° secolo a.C. Tale tradizione si basa su un ragionamento di questo genere: “Se nel cosmo non ci fosse l’elemento terreste, in te non vi sarebbe traccia di terra; e se non ci fosse l’elemento umido, in te non ci sarebbe traccia di acqua; e lo stesso vale per l’aria e per il fuoco. E dunque, se nel mondo non vi fosse intelletto, neppure in te ci sarebbe; ma c’è, e dunque c’è anche nel cosmo. Pertanto il cosmo è intelligente, e se è intelligente è anche dio”.
[ VI,6 ] Queste sono le parole con le quali Epitteto bolla a fuoco l’insipienza di rispondere all’offesa con l’offesa: “E dunque? Non danneggerò chi mi danneggia? Innanzitutto vedi cos’è danno e ricordati di quanto hai sentito dire dai filosofi. Infatti, se il bene è nella proairesi ed il male allo stesso modo nella proairesi, scruta se quel che stai dicendo non è qualcosa del genere: ‘E dunque? Siccome quello ha danneggiato se stesso commettendo un’ingiustizia contro di me, io non danneggerò me stesso commettendo un’ingiustizia contro di lui?’ ”
[ VI,7 ] L’azione più socievole che l’uomo possa fare è quella di atteggiare diaireticamente la propria proairesi e di invitare anche gli altri a fare lo stesso. Infatti, chi si appropria di colui che l’uomo davvero è per natura delle cose, ha fatto anche l’azione più socialmente utile e dunque anche divina che si possa fare.
[ VI,8 ] La proairesi dell’uomo è la sua unica facoltà autoteoretica e fa di lui un saggio o in insipiente, un vizioso o un virtuoso, a seconda di come si atteggia nei confronti di ciò che proairetico e di ciò che è aproairetico.
[ VI,9 ] Tutto ciò che avviene, avviene in armonia con la natura, la quale è una e onnicomprensiva.
[ VI,10 ] Se il cosmo è un guazzabuglio senza legge, l’intrattenermi in esso non può avere altro scopo che quello di intrattenermici il più a lungo possibile, cercando di piegarlo il più rudemente possibile alla mia volontà di potenza, qualunque forma essa prenda. Infatti, non avrei da perdere altro se non quello che perderò comunque, mentre tutto il resto è per me un guadagno.
Marco Aurelio intende così, come assenza di ordine e di finalità, ossia di Prònoia o Logos quale legge immanente e razionale del divenire cosmico, l’ipotesi atomistica e meccanicistica di Epicuro anche se una simile interpretazione ne fraintende sostanzialmente il pensiero. Egli comunque può considerare seria questa prospettiva, giacché sarebbero dovuti ancora passare circa millecinquecento anni prima che Galileo, definendo le leggi di alcuni moti, dimostrasse per primo, empiricamente e inconfutabilmente, che il cosmo non è un guazzabuglio senza legge e ponesse così la Fisica su basi del tutto nuove.
[ VI,11 ] Il passaggio dalla diairesi alla controdiairesi può essere fisiologicamente causato da rappresentazioni alle quali la proairesi dell’uomo si trova momentaneamente impreparata. Non bisogna avere timore di questi sbandamenti in quanto la proairesi bene allenata può operare il passaggio inverso, dalla controdiairesi alla diairesi, con estrema rapidità.
[ VI,12 ] La filosofia è il luogo della diairesi ossia della generazione della vita. La corte imperiale è il luogo della controdiairesi. Quali parole più esplicite avrebbe potuto trovare Marco Aurelio?
[ VI,13 ] Per gli stoici la rappresentazione catalettica è, com’è noto, la rappresentazione che ha caratteri tali da meritare il nostro assenso come quella che non potrebbe venire da un oggetto diverso. Chi vede unicamente del fumo deve assentire alla rappresentazione che c’è del fumo e non a quella che c’è un incendio, potendo il fumo avere molte altre origini diverse da un incendio. Chi ha la rappresentazione di certi organi sessuali in azione, non ha la rappresentazione di persone che provano piacere e tanto meno di persone felici. Così, sembra dirci Marco Aurelio, chi incontra qualcuno che siede sul trono imperiale di Roma deve assentire alla rappresentazione che ha visto l’imperatore, non che ha visto un filosofo intelligente e tanto meno uno stoico. Spessissimo, poi, l’unica vera differenza tra una rappresentazione catalettica e una rappresentazione non catalettica è la nostra vanità.
Il significato dell’ultimo paragrafo non è decifrabile, in quanto ne rimane ignoto l’oggetto. Il Cratete qui citato è probabilmente il cinico allievo del famoso Diogene di Sinope, vissuto nel III° secolo a.C. Senocrate dovrebbe essere allora il suo coetaneo, originario di Calcedonia, che fu secondo successore di Platone alla guida dell’Accademia.
[ VI,14 ] A cosa volgono gli occhi gli esseri umani per trovare ciò che è più degno di ammirazione? Alcuni li fissano sull’oro, su turbe di cavalieri, altri sui vegetali, altri sugli animali, altri sulla persona che si ama o su persone capaci di opere ingegnose. Tutti, comunque, lo cercano fuori di sé, in ciò che è esterno e aproairetico.
Chi invece conosce la natura delle cose sa che la cosa più degna, la ricchezza più grande e più degna di ammirazione sta dentro l’uomo, nella sua proairesi atteggiata secondo diairesi.
[ VI,15 ] Flussi e cambiamenti continui di tutto ciò che è esterno e aproairetico rinnovano incessantemente non soltanto il cosmo ma il nostro stesso organismo.
[ VI,16 ] L’uomo traspira, respira, usa le rappresentazioni, ha impulsi e repulsioni. Ma tutto ciò non è peculiare dell’uomo. Qual è, dunque, l’opera propriamente umana? Affinché l’uomo risulti idoneo all’opera per la quale è stato strutturato dalla natura, la sua unica, vera e fondamentale educazione è quella al rispetto della natura delle cose e all’onore per la propria proairesi, ossia alla comprensione e all’uso della diairesi.
[ VI,17 ] I movimenti e le reciproche trasformazioni dei quattro elementi naturali (fuoco, aria, acqua, terra) sono già stati ricordati più volte da Marco Aurelio. Il movimento dalla diairesi alla controdiairesi e viceversa, e la trasformazione della proairesi umana da virtù a vizio e viceversa, non segue invece regole semplici ed è impossibile da prevedere.
[ VI,18 ] Aproairetico per aproairetico: come mai l’insipiente è in ansia soltanto per la sua immortalità futura e non anche per quella pregressa?
[ VI,19 ] L’uso sistematico della diairesi non soltanto è possibile ma è anche facilmente accessibile.
[ VI,20 ] Siccome l’avversione è qualcosa di proairetico, in mio esclusivo potere, Epitteto soleva dire che il malvagio è cattivo per se stesso ma per me è buono, giacché allena le mie virtù.
Queste sono le sue parole: “-E’ dunque possibile trarre giovamento da questo?- Da tutto. -Anche da chi ingiuria?- Che giova all’atleta il preparatore atletico? Il massimo. E pure costui diventa mio preparatore atletico: allena la mia capacità di tolleranza, il mio dominio sull’ira, la mia mitezza. Chi avvinghia il mio collo e mi rimette in ordine lombi e spalle mi giova; ed il maestro di ginnastica fa bene a dirmi ‘Solleva il pestello con entrambe le mani’; e quanto più quello è pesante tanto più io ne traggo giovamento. E se uno mi allena al dominio sull’ira non mi giova? Questo è non saper trarre giovamento dagli esseri umani. Un cattivo vicino? Per lui stesso, ma per me è buono: allena la mia buona intelligenza, l’acquiescenza. Un cattivo padre? Per lui stesso, ma per me è buono”.
[ VI,21 ] Quando io ti dico che i tuoi desideri soffrono di infiammazione, che le tue avversioni sono da servo nell’animo, che i tuoi progetti sono incoerenti, che hai impulsi in disarmonia con la natura delle cose, concezioni avventate e mendaci, perché ti ritieni oltraggiato?
Ti ho dimostrato che ti mancano le cose più necessarie e grandi per la felicità, che fino a questo momento di tutto sei stato sollecito tranne che di quel che conviene, che tu non sai né cos’è proairesi né cos’è diairesi né cos’è bene né cos’è male e che sei ignorante di te stesso, di chi è un uomo, perché ti esasperi?
Ti ho detto soltanto la verità. A meno che lo specchio non rechi danno a chi è laido, mostrandogli qual è. A meno che il medico non oltraggi l’ammalato quando gli dice: ‘Tu reputi di non avere nulla ma hai la febbre; oggi prendi gli antibiotici e stai a letto’.
[ VI,22 ] Uno dei campi fondamentali nei quali deve esercitarsi l’uomo che conosce la natura delle cose è quello degli impulsi e delle repulsioni, al fine di agire con posizionamento, con razionalità, senza trascuratezza verso ciò che è inanimato, animato ma privo di ragione e verso gli altri esseri umani, anche insipienti. L’uomo, infatti, non è chiamato ad avere il dominio che di sé ha una statua, ma a serbare anche le sue relazioni sociali, naturali ed acquisite, da virtuoso.
[ VI,23 ] L’uomo, creatura razionale, può usare tutto ciò che è aproairetico: oggetti, esseri irrazionali, esseri razionali, finché gli è dato; ma con la riserva di mantenere comunque la sua proairesi, qualunque uso faccia di essi, in accordo con la natura delle cose. E siccome dall’uso che di essi fa dipende il suo bene o il suo male, una buona vita sarà sinonimo di un uso che tenga conto delle loro peculiarità e differenze, e dunque di un uso attento, equilibrato, rispettoso, tale da non comprometta la naturale libertà della proairesi.
E qual è l’atteggiamento che l’uomo deve avere verso gli dei? Nel cosmo, dei e uomini condividono la stessa ragione e, in questo frammento, gli dei sono concepiti da Marco Aurelio come entità di perfezione superiore a quella umana cui è opportuno rivolgersi come ad esseri benevoli, con invocazioni di devota venerazione.
[ VI,24 ] Se la morte uguaglia tutti gli esseri riducendoli ai loro componenti fondamentali, Marco Aurelio ribadisce di intendere come radicalmente alternative la concezione stoica e la concezione epicurea del loro successivo percorso.
[ VI,25 ] La coscienza che abbiamo della complessità dei fenomeni che avvengono nel nostro corpo e nella nostra mente ci prepara ad accettare quella dei fenomeni che avvengono nell’immensità dell’universo.
[ VI,26 ] Ecco come il saggio porta a termine ciò che la sua proairesi ha giudicato doveroso fare.
[ VI,27 ] Diceva Epitteto che questa è la giustificazione che bisognerebbe dare ai genitori che fremono perché i figlioli studiano filosofia: “Dunque aberro, padre, e non so quel che mi spetta e conviene. Ma se questo non è né imparabile né insegnabile, perché mi incolpi? Se è insegnabile, insegnamelo; e se tu non puoi, lascia che io lo impari da coloro che dicono di sapere. Peraltro, cosa pensi? Che io incappi nel male e fallisca il bene perché lo voglio? Non è così! Cos’è, allora, causa del mio aberrare? L’ignoranza. Non vuoi che mi liberi dell’ignoranza? A chi mai l’ira insegnò l’arte di pilotare una nave o la musica? E tu reputi che io imparerò l’arte di vivere grazie alla tua ira?”
[ VI,28 ] Mentre la proairesi può morire mentre il corpo rimane ancora in vita, con la morte del corpo muore anche la proairesi.
[ VI,29 ] Capitolazione del corpo o capitolazione della proairesi? Capitolazione della proairesi è il suo negarsi come libera, infinita, inasservibile, insubordinabile, e il suo atteggiarsi controdiaireticamente.
[ VI,30 ] ‘Cesarificare’ se stessi vuol dire abbandonare la diairesi ed usare quotidianamente e sistematicamente la controdiairesi: dunque, al mondo succede che vi siano degli imperatori ma anche che vi siano miliardi di microimperatori, di ‘piccoli Cesari’.
Il frammento contiene un lungo riferimento ad Antonino Pio come al modello di imperatore che invece non si è ‘cesarificato’, e potrebbe essere una bozza della trattazione, più lunga ed articolata, dello stesso personaggio in [ I,16 ].
[ VI,31 ] Nel sonno la proairesi è spenta. I sogni, dunque, sono entità aproairetiche e come tali non sono né bene né male, né virtuosi né viziosi. Ma aproairetica, e con le stesse caratteristiche, è anche la realtà che abbiamo davanti quando siamo svegli e la proairesi è attiva.
Se, dunque, un sogno ci ha sconcertato, quando la nostra proairesi si risveglia ci rendiamo però conto di non avere alcun motivo di sgomento e tiriamo un sospiro di sollievo. Allo stesso modo possiamo guardare senza alcun motivo di sgomento alla realtà che abbiamo davanti, giacché essa è un materiale indifferente del quale possiamo fare un uso che, però, è in nostro esclusivo potere.
[ VI,32 ] Tutto ciò che è aproairetico è indifferente quanto ad essere male e bene. Anche l’attività passata o futura della proairesi, in quanto priva della dimensione del presente, è qualcosa di aproairetico. L’attività presente della mia proairesi è invece in mio esclusivo potere, è cosa proairetica e può essere bene o male.
[ VI,33 ] Il dolore fisico non è contrario alla natura: esso è cosa aproairetica e dunque per l’uomo non è né un male né un bene, poiché male è soltanto ciò che è proairetico e contrario alla natura delle cose.
[ VI,34 ] Se anche gli insipienti possono godere dei piaceri della carne, allora il piacere fisico non può essere che un’entità aproairetica, un indifferente, qualcosa che non è né bene né male.
[ VI,35 ] Tutti i comuni lavori manuali, come quello del falegname, del pescatore, dell’architetto o del medico possono essere definiti come opere dell’Antidiairesi. Infatti, proairetica è la decisione di costruire una sedia, di uscire a pesca, di edificare una casa, di curare un ammalato, di rapinare una banca, di uccidere un uomo; ma la realizzazione di queste decisioni avviene poi sempre attraverso una serie di operazioni standard guidate da giudizi che rimangono subordinati alla decisione originaria.
L’antidiairesi può dunque essere proficuamente definita come l’insieme di giudizi subordinati operante su quanto non è in nostro esclusivo potere e che, in quanto complementare alla diairesi o alla controdiairesi, è competente a realizzare il progetto dell’una o dell’altra.
L’antidiairesi, il nostro comune quotidiano lavoro, può essere immaginata come il tronco di un albero. Diairesi e controdiairesi sono allora come le radici dell’albero. Insieme al lavoro finito, libertà e felicità oppure schiavitù e infelicità sono come i frutti che pendono dai rami dell’albero, a seconda che alla radice noi vi abbiamo posto la diairesi oppure la controdiairesi.
Se gli artigiani sanno che per realizzare come si deve un lavoro qualunque occorre seguire strettamente le indicazioni dell’antidiairesi e non tener conto dei giudizi degli incompetenti, è stupefacente come noi invece ignoriamo che la realizzazione di noi stessi come uomini, ossia la saggezza, significa rispetto della natura delle cose, ossia mettere la diairesi alla radice dell’antidiairesi.
[ VI,36 ] Il cosmo è uno ed uno è il suo egemonico. Sappiamo già che alla domanda cruciale se l’egemonico del cosmo sia da considerarsi autoteoretico come la proairesi umana oppure no, Marco Aurelio ha risposto affermativamente.
Così come gli è impossibile pensare che se un oggetto si muove uniformemente in linea retta non vi sia una forza che lo spinge, per lui è impossibile pensare che la ragione provenga da una materia che non contenga già in sé la ragione ‘come tale’ nei propri elementi, e dunque che la Prònoia o Logos del cosmo non sia autoteoretica visto che egli pensa al cosmo, secondo la tradizione stoica, come ad un organismo vivente e in continua trasformazione molto più grande e più perfetto del semplice uomo e della sua proairesi. Se la Prònoia è autoteoretica, pensa inoltre Marco Aurelio, essa non può contenere in sé nulla di contraddittorio e dunque dai suoi buoni e solenni impulsi è derivato anche tutto ciò che a noi può apparire deleterio o cattivo.
[ VI,37 ] La natura delle cose è invariante: essa fu, è, e sarà sempre la stessa per qualunque essere umano di qualunque cultura.
[ VI,38 ] Uno sguardo che vede il cosmo come un unico organismo vivente.
[ VI,39 ] La retta proairesi non chiede compiti diversi da quelli che la sorte le ha assegnato, giacché sa di poter fare uso corretto di qualunque materiale le sia dato di lavorare.
[ VI,40 ] Con un coltello si può tagliare il salame oppure uccidere un uomo. Dunque l’uso del coltello non è incluso nel suo essere coltello. Grazie alla proairesi, l’uso che l’uomo fa di se stesso è invece incluso nel suo essere uomo, in quanto vivere in armonia con la natura umana significa vivere virtuosamente e vivere virtuosamente significa vivere in armonia con la natura delle cose.
[ VI,41 ] Chi pone il bene e il male negli oggetti esterni ed aproairetici deve ineluttabilmente accettarne le terrificanti conseguenze; e sono conseguenze che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni.
[ VI,42 ] Comunque si atteggi la proairesi dell’uomo, in modo diairetico o controdiairetico, essa è sempre atteggiata secondo natura e coopera in ogni caso al succedersi degli eventi cosmici. Tuttavia la proairesi atteggiata diaireticamente è anche atteggiata in armonia con la natura delle cose, mentre la proairesi atteggiata controdiaireticamente è atteggiata in contrasto con la natura delle cose. Ma questo contrasto è vano, vizioso e stupido perché ha di mira l’impossibile, in quanto intenderebbe mutare la natura delle cose che invece è e rimane invariante, eterna, inviolabile. Mentre la proairesi atteggiata in armonia con la natura delle cose ottiene così felicità, quella atteggiata contro la natura delle cose ottiene infelicità e Plutarco riferisce che Crisippo paragonava l’infelicità, la viziosità, la stupidità umana alle battute scherzose e alle facezie che sono in sé prive di valore ma che sono utili all’andamento generale di uno spettacolo.
[ VI,43 ] Ogni cosa ha nel cosmo un compito diverso, ma tutte collaborano per un medesimo fine.
[ VI,44 ] Si può discutere all’infinito sul fatto che gli dei esistano o non esistano; che essi esistano ma non deliberino nulla oppure deliberino qualcosa; che essi deliberino bene o male sul cosmo oppure anche su di me personalmente. Quello che io so però con certezza, sembra dire Marco Aurelio, è di avere una proairesi che mi permette di deliberare su me stesso e su ciò che mi è utile in quanto creatura razionale e politica, in quanto imperatore di Roma e cittadino del mondo.
[ VI,45 ] La proairesi dell’uomo, quando operi rettamente, è capace di rendere utile qualunque cosa ci accada.
[ VI,46 ] E’ possibile che la felicità venga a noia? È possibile preferire, per sazietà, l’infelicità alla felicità?
[ VI,47 ] Dovunque volga lo sguardo, l’uomo scopre che la sola cosa davvero degna di lui è la virtù.
Filistione, Febo e Origanione sono personaggi del tutto sconosciuti.
Eraclito di Efeso (V° secolo a.C.), Pitagora di Samo (circa 570-496 a.C.) e Socrate di Atene (470-399 a.C.) sono personaggi notissimi e per essi non è il caso di spendere ulteriori parole.
Eudosso di Cnido (circa 391-338 a.C.), Ipparco di Nicea (II° secolo a.C.) e Archimede di Siracusa (287-212 a.C.) sono celebri matematici ed astronomi.
[ VI,48 ] Bella è soltanto la virtù e quanto della virtù partecipa.
[ VI,49 ] Le vite sono peggiori o migliori a seconda che siano brevi o lunghe?
Una libbra è l’equivalente di 327 grammi, e dunque 300 libbre corrispondono a 98,1 chilogrammi.
[ VI,50 ] Usare l’impulso ‘con riserva’ significa desiderare qualcosa e insieme, grazie all’uso della diairesi, desiderare di mantenere la propria proairesi in accordo con la natura delle cose.
Per chi decide di fare i primi passi sulla strada che porta alla virtù, è fondamentale imparare ad usare l’avversione esclusivamente nell’ambito di ciò che è proairetico e ad usare ‘con riserva’ il desiderio nell’ambito di ciò che è aproairetico.
[ VI,51 ] Bisogna porre il nostro bene e il nostro male in ciò che aproairetico, come la fama e l’oscurità, il piacere e il dolore fisico, o in ciò che è proairetico, nelle opere della nostra proairesi? Bisogna porre la felicità e l’infelicità in mani altrui o nelle nostre?
[VI,52 ] I giudizi sono entità proairetiche, in assoluto nostro dominio. Infatti, le cose esterne ed aproairetiche come tali non hanno accesso alcuno alla nostra proairesi poiché devono, in ogni caso, sempre essere prima trasformate nelle corrispondenti rappresentazioni mentali.
[VI,53 ] Nessuna sciatteria verso ciò che è aproairetico, giacché dall’uso che di esso facciamo dipende il nostro bene o il nostro male, la nostra libertà o la nostra schiavitù.
[VI,54 ] Ciò che è utile all’ape è utile anche allo sciame. Se dunque è utile all’uomo mantenere la sua proairesi in accordo con la natura delle cose: libera, infinita, inasservibile, insubordinabile; ciò sarà anche utile alla società. La politica è questo. Ragion per cui, visto in quest’ottica vera, il grande politico era Socrate, non Pericle; Diogene, non Alessandro Magno; Epitteto, non Marco Aurelio.
[ VI,55 ] Dov’è la salvezza dell’uomo? Gli Stoici hanno ampiamente dimostrato che tutto ciò che è aproairetico non può essere né bene né male e che soltanto ciò che è proairetico può essere tale.
La Natura, il Cosmo, il Fato, la Prònoia, la Materia Immortale, il Dio delle religioni monoteiste e così via, sono entità proairetiche o aproairetiche?
Se essi esistono indipendentemente da me, se non sono in mio esclusivo potere, essi sono entità aproairetiche. E se tali sono, nessuna di esse può e deve essere per me bene o male.
Infatti, se io le giudicassi essere un bene, ponendo il bene fuori di me farei inevitabilmente dipendere da esse e dal loro volere la mia libertà e la mia felicità e dunque le odierei e le bestemmierei quando ritenessi di non ottenere da esse quei beni dei quali le faccio depositarie. Se le giudicassi essere un male, ponendo il male fuori di me cercherei inevitabilmente di avversarle in ogni modo, ma farei comunque dipendere da esse e dal loro volere la mia libertà e la mia felicità, giacché le odierei e le bestemmierei quando incappassi in qualcuno dei mali dei quali le faccio depositarie.
Il solo atteggiamento corretto di fronte a tutte queste entità è dunque quello di riconoscere che esse non sono e non possono essere altro per me che né bene né male. Il che significa che l’uomo può benissimo immaginare di provare l’esistenza di un Dio malvagio come Arimane, ma resta il fatto che questo è affar suo, è affare di Arimane.
Come Epitteto ha insegnato a Marco Aurelio, e come invece Marco Aurelio continuamente mostra di fraintendere, Arimane o Zeus possono benissimo essere entità malvagie o buone ma per l’uomo virtuoso, per l’uomo che usa correttamente la proairesi e la diairesi, essi sono malvagi o buoni per se stessi ma comunque buoni per il virtuoso. La divinità può benissimo essere pensata non soltanto buona ma anche connotata dalla malvagità, da una provvidenzialità perversa che ha di mira il nostro danno. In quel caso l’uomo virtuoso perdona Dio ed usa con lui la bacchetta di Ermete e gli dice: ‘Tu, divinità, porta quel che vuoi ed io, uomo, ne farò un bene. Porta malattia, morte, difetto di mezzi di sussistenza, ingiurie, una condanna ingiusta. Io, uomo, ne farò un bene, una cosa attraverso cui mostrare nei fatti cos’è una creatura che comprende il tuo piano. Tutto ciò che mi darai lo farò beato, felicitante, solenne, da emulare’.
Allo stesso modo, abbiamo miriadi di esempi tutt’altro che immaginari di medici che non sono affatto interessati alla salute dei pazienti e di piloti la cui preoccupazione non è affatto l’attenzione alle esigenze dei passeggeri.
Sto per fare un viaggio per mare. Cosa mi è possibile? Mi è possibile scegliere la nave con cui partire e dunque, in un certo senso, il pilota e i marinai; il giorno; il porto da cui partire. Succede poi che una tempesta si abbatta sulla nave. Quale altra parte posso fare? La parte che mi spettava io l’ho già assolta. La tempesta è ipotesi di altri, del pilota e dell’equipaggio. Ma la nave affonda pure! E cosa posso fare per evitarlo? Quel che posso, questo soltanto faccio. E se non posso null’altro, affogo senza avere paura né strillando né incolpando Dio o la natura o chi altro, ma sapendo che quanto nasce deve anche perire. Giacché non sono eterno; sono un uomo, una parte del tutto, come un’ora di un giorno. Io devo come l’ora venire e come un’ora trapassare. C’è differenza sostanziale se trapasso annegando o per la febbre? Giacché per qualcosa devo pur morire.
È dunque controdiairetico, è da schiavi, è vizioso è stupido credere nell’esistenza di un Dio aproairetico e giudicarlo buono, provvidente, amoroso o il contrario di questi attributi.
[ VI,56 ] La morte, anche quella delle persone più care, è ineluttabile.
[ VI,57 ] Gli oggetti esterni ed aproairetici non hanno come tali accesso diretto alla nostra proairesi e sono sempre prima trasformati nelle corrispondenti rappresentazioni mentali. Ciò è tanto vero, che gli stessi oggetti sono valutati diversamente da persone diverse.
La controdiairesi, d’altra parte, è il supergiudizio non adeguato alla natura delle cose, sia proairetiche che aproairetiche, perché le assume in una prospettiva diversa da quella che effettivamente loro compete; ed è la più terribile delle malattie dell’uomo, perché è capace di ucciderlo pur mantenendolo in vita.
[ VI,58 ] L’uomo può vivere in modo contrario alla natura delle cose ma non può mai vivere in modo contrario alla natura.
[ VI,59 ] Prima ancora che sia il tempo a cancellarne la memoria, dice Marco Aurelio, meglio stendere un velo pietoso sui cortigiani che ho intorno.
*****
[ VII,1 ] Di una malattia del corpo a decorso rapido, violento, tumultuoso si dice che è una malattia acuta. Così, un episodio acuto di quella malattia della proairesi che è la controdiairesi va chiamato ‘aberrazione’.
Di una malattia ad andamento prolungato, con scarsa tendenza alla guarigione si dice che è una malattia cronica. Così, la scarsa o nulla tendenza alla guarigione, ossia alla diairesi, di quella malattia della proairesi che è la controdiairesi va chiamata ‘vizio’.
Tutti i differenti vizi non sono altro che forme di abitudine inveterata, di pratica sistematica della controdiairesi in contesti diversi. È sempre la stessa storia.
[ VII,2 ] Se la malattia della controdiairesi non è cronica, la proairesi può facilmente riprendersi da un accesso acuto ossia da un’aberrazione. Rappresentazioni catalettiche, retti giudizi, diairesi sono infatti in esclusivo potere della nostra proairesi. Inoltre, il timore di non potersi riprendere è intrinsecamente contraddittorio giacché si tratta di un’operazione proairetica, nella quale gli oggetti esterni e aproairetici non hanno alcun potere. La natura ha dato alla proairesi, quasi araba fenice, la possibilità di rivivere da se stessa, dalle proprie ceneri.
[ VII,3 ] Diceva Epitteto che se noi fossimo concentrati sulla nostra proairesi così energicamente come i senatori, a Roma, sono concentrati sulle cose esterne ed aproairetiche per le quali si industriano, probabilmente concluderemmo qualcosa anche noi. I senatori tutto il giorno e tutti i giorni consigliano, dibattono, votano su forniture di grano, su proprietà immobiliari, su profitti ottenuti o attesi.
In un certo senso, le faccende di quei senatori sono simili alle nostre, giacché ricevere da qualcuno una lettera e leggere: ‘Ti prego di delegarmi l’ esportazione di una certa quantità grano in cambio del mio voto favorevole alla tua elezione a quella certa carica’ non è diverso dal riceverne un’altra e leggervi ‘Ti prego di esaminare qual è per Crisippo il governo dell’ordine del mondo e quale ufficio vi ha l’animale logico; esamina anche chi sei tu e cosa sono il tuo bene ed il tuo male’. Si tratta di istanze diverse quanto agli oggetti ma che hanno bisogno di eguale impegno.
Lo zelo che i senatori pongono nelle loro faccende non sarebbe, dunque, degno di opere migliori? Alla fin fine ognuno di noi tanto vale quanto vale ciò su cui si industria.
[ VII,4 ] Nel caso dell’uomo, nessun progresso verso la virtù è possibile se egli usa parole del cui significato non ha piena comprensione e dà spazio ad impulsi all’azione che contrastano con quanto è per lui doveroso.
[ VII,5 ] Se io sono cittadino del mondo, qual è l’opera che la natura della quale sono figlio richiede da me?
Che io rispetti la natura delle cose serbando la mia proairesi libera, infinita, inasservibile e insubordinabile.
Se io sono anche cittadino di una città più piccola che è parte del mondo, qual è l’opera che questa seconda città richiede da me? Che io rispetti le leggi che essa si dà per promuovere la pacifica convivenza tra i suoi cittadini.
Il fatto che il rispetto della natura delle cose sia intrinsecamente in mio esclusivo potere e dunque che la mia proairesi sia sempre adeguata a quest’opera; e soprattutto la possibilità che qualcun altro possa compiere l’opera in questione al mio posto, porta ad escludere che Marco Aurelio, in questo frammento, pensi alla prima città. Egli si riferisce evidentemente alla seconda città, alle sue leggi e al suo ruolo in essa; ruolo che, a seconda delle contingenze, egli porterà a termine, da imperatore, in uno dei tre modi che qui dettaglia.
[ VII,6 ] La virtù è premio a se stessa. Lasciate che scompaiano i virtuosi, e anche la fama della virtù è destinata a scomparire.
[ VII,7 ] Chi non capisce cosa siano proairesi, diairesi, controdiairesi e antidiairesi non deve vergognarsi di ammetterlo e, se ha bisogno di aiuto, deve accettare che qualcuno lo aiuti a comprendere chi è e che cos’è venuto a fare in questo mondo.
[ VII,8 ] Se la morte dell’uomo è cancellazione della sua proairesi, il problema non si pone neppure. Se la proairesi invece permanesse, essa sarebbe comunque capace di dominare lo sconcerto domani, come lo è oggi e lo era ieri.
[ VII,9 ] Il cosmo è un’unica sostanza e un’unica polis.
[ VII,10 ] Tutto è sottoposto a rapide trasformazioni.
[ VII,11 ] Qualunque azione umana è in accordo con la natura, ma non tutte le azioni umane sono in accordo con la natura delle cose ossia con la ragione.
[ VII,12 ] Dice il proverbio che l’occasione fa l’uomo ladro. Meglio sarebbe dire che essa rivela il ladro. Rettitudine o soltanto correttezza?
[ VII,13 ] Socrate affermava che Anito e Meleto potevano farlo uccidere ma non fargli del male.
Senza bisogno di attribuirgli la profondità del sapiente stoico, se Socrate giudica rettamente che nessun uomo può fare dal male ad altri che a se stesso, allora giudicherà anche che nessun altro può fargli del male. Ma è altrettanto evidente che nessun uomo può fare del bene ad altri che a se stesso, e che dunque nessuno può fargli del bene.
Questo accade poiché bene e male esistono soltanto nella proairesi dell’uomo, laddove ‘bene’ è il retto uso delle rappresentazioni, che significa -in questo caso- libertà e infinità della proairesi di Socrate; e ‘male’ l’uso scorretto delle rappresentazioni, che significa schiavitù e miseria delle proairesi di Anito e Meleto.
Dove nasce dunque l’aberrazione di giudicare che il bene e il male siano entità aproairetiche e, ancor peggio, che esista qualcosa come il ‘bene comune’? Ancora e sempre nella proairesi dell’uomo.
Infatti, ‘bene comune’ e ‘male comune’ non hanno maggiore realtà dell’esistenza di un fantomatico ‘pene comune’. Sono pure e vere contraddizioni in termini, concetti aberranti usati per giustificare se stessi e il proprio operato da menti deboli, immature, infantili, non sviluppate, anche se sui loro volti ondeggiassero barbe lunghe due spanne, anche se sedessero su un trono.
[ VII,14 ] Il dolore fisico è un’entità aproairetica, l’afflizione è un’entità proairetica. Il dolore fisico non è né un bene né un male. L’afflizione è un male.
[ VII,15 ] Se l’oro rimane oro pur frammisto ad altri materiali, la proairesi può e deve rimanere virtuosa anche quando sia circondata da proairesi viziose.
[ VII,16 ] Marco Aurelio parla, in questo frammento, di due diversi egemonici o proairesi.
Nei primi due paragrafi il soggetto è la Prònoia, l’egemonico di quell’unico essere vivente che è il cosmo. Sappiamo che egli la concepisce come autoteoretica e non è difficile capire che la Prònoia, comunque muovesse il cosmo, lo muoverebbe verso il proprio bene, poiché qualunque essere fa sempre quello che giudica essere il proprio bene e mai il proprio male. E ovviamente nulla e nessuno potrebbe deviare la Prònoia del cosmo dal suo corso.
I paragrafi seguenti sono invece riferiti all’uomo, che Marco Aurelio vede composto, come ha già detto in precedenti frammenti, di: corpo, animo o pneuma, ed egemonico.
Il corpo può patire, provare dolore o piacere, ma non ha la capacità di esprimere giudizi su quello che prova. L’animo può avere reazioni istintive di paura o di afflizione che precedono la formazione dei giudizi da parte della proairesi, semplicemente perché esse sono reazioni animali rapidissime, utili all’individuo per sfuggire determinati pericoli e che gli conferiscono pertanto dei vantaggi di sopravvivenza. La proairesi è invece autoteoretica, è essa e soltanto essa quella che produce i giudizi ai quali corpo e animo ubbidiranno. E l’egemonico dell’uomo, quando operi rettamente è, sempre secondo Marco Aurelio, una fedele immagine dell’egemonico del cosmo.
[ VII,17 ] Non si deve confondere ciò che ci viene in mente con ciò che pensiamo. Le rappresentazioni scabrose sono una cosa; l’assenso ad esse o il dissenso da esse è un’altra e la proairesi rettamente operante non confonde le due cose.
[ VII,18 ] Il cosmo del quale siamo parte è un’unità in spontaneo, continuo e inarrestabile mutamento.
[ VII,19 ] Di quanti Crisippo, di quanti Socrate, di quanti Epitteto ha bisogno il mondo?
[ VII,20 ] Dà un certo conforto sentire Marco Aurelio dichiararsi risoluto a non usare la controdiairesi.
[ VII,21 ] Come il lento richiudersi di un vecchio cofano.
[ VII,22 ] Le aberrazioni sono figlie dell’ignoranza e dunque chiunque può uccidermi, ma nessuno può recarmi danno.
[ VII,23 ] Nulla si crea e nulla si distrugge.
[ VII,24 ] I vizi altrui possono indignarci e l’indignazione trasparire nel nostro volto. Ma il giudizio che l’aberrazione altrui debba essere motivo di indignazione fino a diventare infelicità per me è, a sua volta, male. E quando io non mi renda più conto che essendo infelice sto aberrando, ho passato il confine che separa il ‘vivere’ dall’ ‘essere in vita’.
[ VII,25 ] Per il cosmo nel suo complesso il tempo non esiste e dunque esso è l’unico essere vivente non soggetto ad invecchiamento.
[ VII,26 ] Chi trascura la natura delle cose e dunque aberra, è in contraddizione e diventa nemico di se stesso. Deve pertanto essere considerato per quello che è in simile stato: un infelice che non merita né stupore né ira da parte di una retta proairesi ma quel distacco che si confà a chi invece rispetta la natura delle cose.
[ VII,27 ] Rallegrati pure di ciò che è aproairetico, ma con riserva; ossia non tanto da essere infelice per la sua mancanza.
[ VII,28 ] La proairesi, quando opera rettamente, è pace vivente.
[ VII,29 ] In questa sorta di breve memorandum Marco Aurelio ricorda a se stesso, tra altre cose, di disciplinare l’assenso alle rappresentazioni, l’impulso all’azione, il desiderio e l’avversione. Di particolare rilievo è il pressante invito alla diairesi tra ciò che è proairetico, che qui egli chiama ‘componente causale’ e ciò che è aproairetico, che egli chiama ‘componente materiale’.
[ VII,30 ] È importante comprendere da quali cause basilari siano prodotti gli eventi. E noi sappiamo che anche per Marco Aurelio queste cause basilari sono quattro: Prònoia o Proairesi, Natura, Necessità, Fortuna.
[ VII,31 ] Vestiti di virtù.
Il filosofo cui la citazione si riferisce è Democrito.
[ VII,32 ] Il frammento ripropone le due prospettive che Marco Aurelio concepisce come radicalmente alternative: l’atomismo di Democrito ed Epicuro, che egli considera inaccettabile; e la visione stoica, che egli tende a colorare di un forte finalismo e di un intenso provvidenzialismo.
[ VII,33 ] Di dolore fisico acuto si può morire? Epicuro pensa di sì. E il dolore fisico cronico, che Epicuro giudica sopportabile, come va affrontato?
Ricordiamoci che il dolore fisico è un’entità aproairetica e che proairetico è invece il giudizio che la proairesi ha di esso.
Ora, se la proairesi giudicasse il dolore fisico essere di per sé un bene, essa lo ricercherebbe attivamente, cosa che invece nessuna proairesi vediamo fare. Ma anche se lo facesse si tratterebbe di una aberrazione, in quanto la proairesi si sarebbe atteggiata in modo contrario alla natura delle cose, la quale stabilisce inviolabilmente che bene e male siano entità proairetiche e non oggetti esterni e aproairetici come il dolore fisico.
Se la proairesi giudicasse il dolore fisico essere di per sé un male, essa lo avverserebbe in ogni modo; ma anche in questo caso si tratterebbe di una aberrazione, in quanto la proairesi si sarebbe atteggiata in modo contrario alla natura delle cose, secondo la quale il dolore fisico è invariantemente un’entità aproairetica, non in esclusivo potere della proairesi: tant’è vero che essa vi è incappata suo malgrado.
Qual è allora l’atteggiamento della retta proairesi dinanzi al dolore fisico? A diairesi operata, ossia dopo avere correttamente giudicato che il dolore fisico non è né un bene né un male ma un ‘indifferente’, la proairesi ha il dovere di mantenere se stessa libera, infinita, inasservibile e insubordinabile; dunque ha il dovere di comandare all’antidiairesi di allontanare, secondo le circostanze e per quanto è possibile, un dolore fisico che esige per se stesso un’attenzione abnorme e che si propone niente meno che come agente limitante le caratteristiche naturali della proairesi. La retta proairesi fa dunque quel che può per allontanare il dolore fisico, senza trasformarlo in un motivo di paura e di afflizione (che sono proairetiche e male) né in noncuranza e trascuratezza (che sono anch’esse proairetiche e male). E lo fa con riserva, giacché sa che il successo in questa operazione non è in suo esclusivo potere. E quando l’opera dell’antidiairesi avesse fatto sparire il dolore fisico, la retta proairesi continuerebbe a serbare retti giudizi su di esso, senza inorgoglirsi e senza sentirsene per sempre al riparo. Quando invece fosse il dolore a sposarsi con la morte e ad avere il sopravvento, ebbene la retta proairesi farebbe vivere i suoi retti giudizi sulla morte e potrebbe salutare degnamente la fine della sua avventura con le parole che Socrate rivolgeva all’amico di una vita: ‘Critone, siamo debitori di un gallo ad Asclepio. Dateglielo e non ve ne dimenticate’.
[ VII,34 ] Proairesi che inseguono e fuggono cose aproairetiche ed in esse pongono il loro bene ed il loro male: una fama fatta di sabbia.
[ VII,35 ] In quanto entità aproairetiche, vita e morte non sono né un bene né un male.
Salvo un pronome ed un sostantivo, il frammento è la citazione testuale di un brano della ‘Repubblica’ di Platone nel quale Socrate, dialogando con Glaucone, spiega come gli uomini capaci di giungere all’apprensione di ciò che sempre permane invariabilmente costante siano filosofi di una filosofia, mentre coloro che non vi giungono ma vanno errando e si arrestano alla molteplicità del variabile siano filosofi di un’altra filosofia.
[ VII,36 ] L’uomo che sa di bene operare non si duole di sentir parlar male di sé. Come tale, Marco Aurelio invita se stesso a non affliggersi delle maldicenze che corrono al suo riguardo.
Epitteto nelle ‘Diatribe’ cita le parole del frammento come parole che Antistene rivolge al persiano Ciro.
Amico e compagno di Socrate, Antistene è la grandissima personalità filosofica cui possono essere fatti risalire i fondamenti del cinismo e, in un certo senso, dello stesso stoicismo.
[ VII,37 ] Quando Epitteto intendeva richiamare qualcuno alla verità che la nostra proairesi può atteggiarsi diaireticamente o controdiaireticamente, gli diceva: ‘Se qualcuno ti imponesse di prostituire il tuo corpo al primo individuo che casualmente ti viene incontro, ne fremeresti. E che tu prostituisca la tua proairesi al primo che capita così che, se sarai ingiuriato, essa ne sia sconcertata e confusa: per questo non ti vergogni?’
[ VII,38 ] Il brano è un frammento dal ‘Bellerofonte’ di Euripide, e si può immaginare dedicato alle schiere dei combattenti contro i mulini a vento.
[ VII,39 ] Il frammento è tratto da un’opera di autore sconosciuto.
[ VII,40 ] Il frammento proviene dalla ‘Ipsipile’ di Euripide.
[ VII,41 ] Il frammento proviene dalla ‘Antiope’ di Euripide.
[ VII,42 ] La citazione è un frammento di un’opera sconosciuta di Euripide.
[ VII,43 ] Il frammento proviene dall’opera di un autore sconosciuto. È comunque irresistibile la tentazione di intitolarlo: ‘Cent’anni di piagnistei’.
[ VII,44 ] Marco Aurelio cita parole di Socrate, come le riferisce Platone nella sua ‘Apologia’.
[ VII,45 ] Altre parole di Socrate, come le riferisce Platone nella sua ‘Apologia’.
[ VII,46 ] Anche per Socrate, la vita di per se stessa non è né un bene né un male.
Il frammento è una citazione proveniente dal ‘Gorgia’ di Platone.
[ VII,47 ] Soltanto il nitore della saggezza, simboleggiata dal moto ordinato dei corpi celesti e dalle regolari trasformazioni dei quattro elementi, è capace di ripulire la sudiceria prodotta dall’insipienza umana.
[ VII,48 ] Un invito a guardare le vicende umane dall’alto della natura delle cose e della diairesi.
[ VII,49 ] Quando si sia seguito l’invito del frammento precedente, cosa si potrà vedere domani più di quanto si sia visto oggi?
[ VII,50 ] Il frammento proviene dal ‘Crisippo’ di Euripide.
[ VII,51 ] Il primo frammento proviene dalla ‘Supplici’ di Euripide. Il secondo frammento è di autore ignoto.
[ VII,52 ] Colui che vince una competizione ha anche, per il semplice fatto di avere vinto, retti giudizi sulla vittoria? E se non li ha, pur avendo primeggiato ha perso la gara fondamentale e decisiva della saggezza e della virtù.
[ VII,53 ] Comune agli uomini e agli dei è la ragione. L’attività che ha libero corso ed è in armonia con la nostra struttura è la diairesi. Dall’uso della diairesi non può certamente venire alcun male.
[ VII,54 ] Giusti desideri ed avversioni, doverosi impulsi e repulsioni, retti assensi e dissensi. Così una proairesi è libera dinnanzi agli eventi, agli uomini ed a se stessa.
[ VII,55 ] La proairesi è una facoltà naturale nata per primeggiare poiché, avendo essa soltanto la conoscenza della natura delle cose, essa soltanto è in grado di disciplinare correttamente i desideri e le avversioni, gli impulsi e le repulsioni, gli assensi e i dissensi dell’uomo in vista del suo perseguimento della felicità.
Se è vero che l’uomo è finora l’unica creatura razionale esistente nel cosmo, è falso che il possesso della proairesi significhi per lui ‘ipso facto’ garanzia di felicità. E mentre tutti gli altri esseri viventi coniugano la loro assenza di proairesi con l’assenza del problema di essere felici o infelici, l’autoteoreticità dell’uomo gli lascia la possibilità di atteggiarsi diaireticamente o controdiaireticamente e dunque gli apre anche le porte dell’infelicità.
Lasciandosi scivolare lungo il piano inclinato della necessità di giustificare, innanzi tutto a se stesso, il proprio ruolo di ‘imperatore’ e non insensibile al canto delle Sirene che lo attorniano, Marco Aurelio colora a volte il suo stoicismo di un acceso finalismo provvidenzialistico e di un futile antropocentrismo, ripetendo luoghi comuni della scuola che forse non ha neppure ben capito.
Marco Aurelio, infatti, dimentica o finge di dimenticare che gli uomini sono gli unici animali nel cosmo che si massacrano l’un l’altro a milioni e che, per fare soltanto un minimo esempio, le formiche, le api e i lupi sono animali molto più socievoli e socialmente organizzati dell’uomo.
È persino stucchevole ricordare la mistificazione che si nasconde nel concetto di ‘bene comune’. La socievolezza dell’uomo, infatti, non consiste nel votarsi a perseguire un fantomatico e inesistente ‘bene comune’, che comunque sarebbe qualcosa di aproairetico e dunque non potrebbe neppure mai essere di per sè un ‘bene’. E neppure nel votarsi a scongiurare, perchè ‘male’, il fatto aproairetico che gli uomini si massacrino l’un l’altro a milioni.
La socievolezza dell’uomo consiste nel riconoscere la libertà, infinità, inasservibilità, insubordinabilità delle proairesi altrui e nel salvaguardare con tali caratteristiche la propria. E la stessa manifesta impossibilità di eliminare universalmente l’uso della controdiairesi è semplicemente un altro modo per qualificare l’inesistenza del bene comune, così come l’impossibilità di annichilare la diairesi qualifica l’inesistenza del male comune.
Per comprendere fino in fondo cos’è in gioco, merita ascoltare al riguardo queste parole di Epitteto, che si possono benissimo immaginare rivolte ad un imperatore: “-Ma io posso far prendere a legnate chi voglio- Certo tu puoi farlo, come faresti prendere a legnate un asino. Sappi dunque che questo tuo comando non è un comando da uomo che comanda uomini. Comandaci invece come creature logiche, mostrandoci quanto è utile, e noi ti seguiremo. Mostraci quanto non è utile e noi ce ne distoglieremo. Fa di noi dei tuoi emuli, come faceva Socrate di sé. Socrate era colui che comandava gli uomini come uomini, poiché li invitava a subordinare ad essa, alla ragione, il loro desiderio, l’avversione, l’impulso, la repulsione. Tu invece dici: ‘Fa questo, non fare questo; se no, ti farò buttare in prigione’. Questo non è più comando di noi come creature logiche. Dì piuttosto: ‘Come Zeus ha costituito per natura delle cose, questo fa. Se non lo farai sarai punito, sarai danneggiato’. Chiedi quale sia il danno? Nessun altro se non quello di non fare quel che si deve. Infatti, avrai mandato in malora l’uomo leale, rispettoso di sé e degli altri, il cittadino del mondo che è in te. E non cercare altri danni più grandi di questi”.
[ VII,56 ] Marco Aurelio ci confessa, forse addirittura esagerando, di avere finora vissuto come se fosse morto.
[ VII,57 ] Natura, fortuna, necessità e Prònoia intessono tutto ciò che di aproairetico avviene all’uomo. Ma anche la proairesi è una delle cause basilari del nostro destino.
[ VII,58 ] I casi della vita sono materiale per la nostra proairesi e una proairesi pervertita li trasforma inevitabilmente in male. Se anche tu vuoi fare così non hai che da accomodarti. La natura non ti frapporrà alcun impedimento, e sappi che non te lo frapporrà neppure se deciderai di trasformali in bene.
[ VII,59 ] La fonte del bene, come del male, è dentro l’uomo ed è la sua proairesi.
[ VII,60 ] Anche l’atteggiamento del corpo può rispecchiare lo stato della nostra proairesi.
[ VII,61 ] Le giuste competizioni alle quali, nel corso della vita, non dobbiamo rifiutarci di partecipare.
[ VII,62 ] Vuoi essere lodato dagli insipienti?
[ VII,63 ] L’aberrazione della proairesi è ignoranza della diairesi, di cos’è bene di cos’è male.
La citazione che apre il frammento è molto nota e proviene da Epitteto il quale, a sua volta, la mutua da Platone.
[ VII,64 ] Finché la facoltà proairetica non è compromessa, un qualunque intralcio del nostro corpo va correttamente giudicato come cosa aproairetica, e dunque non è un intralcio di proairesi.
[ VII,65 ] Le proairesi atteggiate diaireticamente praticano il retto uso delle rappresentazioni. Chi pratica il retto uso delle rappresentazioni si chiama ‘uomo’. Gli uomini sono ‘pace vivente’.
Le proairesi atteggiate controdiaireticamente praticano l’uso scorretto delle rappresentazioni. Chi pratica l’uso scorretto delle rappresentazioni si chiama ‘essere umano’. Gli esseri umani non possono che odiare e odiarsi a vicenda: essi sono ‘inimicizie viventi’.
[ VII,66 ] Poiché i giudizi dai quali procedono i comportamenti delle persone non sempre si desumono facilmente dalle apparenze esterne, si può cautamente affermare di conoscere un uomo soltanto quando se ne conoscano a fondo i giudizi.
In questo frammento Socrate e Telauge sono presi da Marco Aurelio a modelli emblematici del filosofo noto e del filosofo ignoto, al fine di rilevare che la notorietà non è indizio, e tanto meno prova, di eccellenza interiore.
Un filosofo di nome Telauge è effettivamente citato, come figlio di Pitagora, nelle ‘Vite dei filosofi’ scritte da Diogene Laerzio nel III° secolo d.C.
Le vicende della vita di Socrate sono troppo note per meritare ulteriori precisazioni.
[ VII,67 ] Anche se hai avuto la sventura di sedere su un trono imperiale, sembra dire Marco Aurelio a se stesso, ricorda che comunque continui ad avere la proairesi che la natura ti ha dato e che essa è libera, infinita, inasservibile, insubordinabile; mentre il trono su cui siedi è schiavo di ambizioni viziose e cortigiane, finito nei suoi confini, asservibile da ogni sorta di nemici, subordinabile da popoli più ricchi e potenti.
Tutti ti conoscono come imperatore e nessuno, spesso neppure tu stesso, ti riconosce per chi tu davvero sei.
[ VII,68 ] La proairesi umana è una delle quattro cause basilari degli eventi del cosmo ed è grazie al corretto uso di essa che l’uomo può essere felice in questa vita.
In questo frammento Marco Aurelio dettaglia il funzionamento della sua propria proairesi atteggiata diaireticamente davanti ad un evento esterno e aproairetico quale, ad esempio, le rabbiose urla di disapprovazione che gli sono rivolte contro da uno dei suoi più intimi collaboratori. Il processo è analizzato in tappe che soltanto per comodità di esposizione sono successive e che sono sommariamente, pur con qualche leggera imprecisione, riassumibili così.
Poiché nulla di ciò che è esterno ed aproairetico ha accesso diretto ad essa, innanzitutto la proairesi assume la rappresentazione di ciò che è esterno ed aproairetico e lo lavora fino a produrne una rappresentazione catalettica cui dà il proprio assenso (‘Avidio urla contro di me’). Immediatamente dopo, impiegando la diairesi, essa passa al retto uso della rappresentazione (‘le urla di Avidio non sono nulla per me, non sono né bene né male’) e decide se desideri o impulsi che scaturiscono da quel giudizio di assenso e dal responso della diairesi, implicano operazioni che sono in suo esclusivo potere (‘taccio’; ‘prendo la parola per spiegare perché Avidio si sbaglia’) oppure non sono in suo esclusivo potere (‘convincerò Avidio che si sbaglia’). Se sono in suo esclusivo potere essa le mette immediatamente in pratica. Se non sono in suo esclusivo potere essa formula, con riserva, quei i giudizi che chiamerà poi l’antidiairesi a mettere in pratica ove, quando, e come possibile.
[ VII,69 ] La retta proairesi sa essere felice, e dunque può fare di ogni giorno il nostro potenziale ultimo giorno.
[ VII,70 ] Quando gli dei decidono di punire gli insipienti non fanno altro che esaudirne i desideri. Come un dio, l’uomo che usa la diairesi sa sopportare coloro che non la usano.
[ VII,71 ] La diairesi ci dice che nostri vizi sono per noi cosa proairetica e dunque evitabili, mentre i vizi altrui sono per noi cosa aproairetica e dunque inevitabili.
[ VII,72 ] Anche per negare l’utilità della proairesi e delle sue opere ci sarebbe bisogno della proairesi.
[ VII,73 ] La proairesi è autoteoretica: dunque è essa stessa premio o punizione a se stessa.
[ VII,74 ] Una retta proairesi accetta ben volentieri l’aiuto di un’altra proairesi, quando quest’ultima sia retta ossia non pretenda di diventare padrona della proairesi che aiuta.
[ VII,75 ] Se la Prònoia, ossia l’egemonico del cosmo, fosse una entità irrazionale, non riuscirei a spiegarmi come mai io, Marco Aurelio, sono una creatura razionale.
*****
[ VIII,1 ] L’uomo può certamente vivere facendo a meno di molti oggetti esterni ed aproairetici, ma può vivere facendo a meno della proairesi? Ovviamente no, poiché ‘vivere’ è, in ogni caso e per qualunque uomo di qualunque cultura, sinonimo di uso della proairesi. Uso della proairesi è elaborazione di assensi, giudizi, desideri, impulsi, progetti, regole, visioni del mondo e così via; ossia approntamento e quindi traduzione nella pratica del vivere di tutto ciò che di proairetico è a questo fine pregiudiziale e indispensabile. Quale pratica del vivere? Quella che per l’uomo è bene e lo conduce alla felicità. E questa, sia detto chiaramente, non è altro che una delle possibili veraci definizioni di filosofia!
Se dunque la filosofia è la ricerca e la pratica dell’arte di vivere bene e se per vivere comunque, bene o male, felicemente o infelicemente, bisogna necessariamente usare la proairesi; allora sono filosofi tutti gli esseri umani, anche coloro che non sanno o non credono di esserlo. Filosofi, tutt’al più, di filosofie differenti ma pur sempre filosofi, in quanto qualunque modo di vivere dell’essere umano, anche il più primitivo, il più biasimevole, il più rozzo, implica una teoresi.
Marco Aurelio è dunque cattivo filosofo e inganna se stesso quando afferma di essere ben lontano dalla filosofia. Egli non è lontano dalla filosofia, ma è filosofo di un’altra filosofia: una filosofia che egli afferma, con parole accorate, di disprezzare e di rifuggire ma della quale invece, nei fatti, egli è garante e custode.
Si possono dunque intendere rivolte anche a lui le parole che Epitteto mette in bocca ad un vecchio canuto con alle dita molti anelli d’oro il quale, dopo avere guardato negli occhi un figlio adottivo ed avere scosso la testa, gli aveva detto: “Ascoltami, figliolo: si deve anche fare filosofia, ma si deve anche avere cervello: queste sono stupidaggini. Tu dai filosofi impari il sillogismo, ma cosa tu debba fare, lo sai meglio tu dei filosofi”.
Il fatto è che i modi basilari in cui l’uomo può usare la proairesi non sono infiniti e non sono nemmeno pochi: sono soltanto due. Il primo è la diairesi, il secondo è la controdiairesi. Dunque tutte le teoresi e tutte le filosofie possibili possono essere fatte rientrare in una o nell’altra di queste due modalità filosofiche.
Diventa così facilissimo e chiarissimo capire di cosa Marco Aurelio si lamenti, cosa sogni invano, cosa si rimproveri e rimpianga e riprometta.
[ VIII,2 ] La natura delle cose è inviolabile: gli uomini sono dotati di proairesi, le istituzioni non hanno e non possono avere proairesi. Ogni volta che un’istituzione incontra delle resistenze oppure le regole di due diverse istituzioni entrano in frizione, che ne è degli uomini delle istituzioni? Quando simili conflitti si verificano, basta qualche manciata di parole di propaganda, di slogan affannosamente consolatori?
Si sa che presidenti, re e imperatori iniziano dal benessere e fanno inghirlandare e imbandierare i palazzi. Poi però, al terzo o quarto atto del dramma li senti gemere: ‘Ah, Citerone, perché m’accoglievi?’. Le corone sono sparite, le guardie del corpo non servono più a nulla.
Chi si avvicina ad un imperatore, un re, un presidente deve dunque sapere che si avvicina ad un personaggio tragico, non ad un attore ma ad Edipo in persona. Anche Edipo era ben lontano dal sapere di essere la causa della peste di Tebe.
[ VIII,3 ] La differenza basilare tra Alessandro Magno, Cesare, Pompeo e Diogene, Eraclito, Socrate sta tutta nel fatto che, pur con sfumature diverse, gli ultimi tre sono filosofi della diairesi, mentre i primi tre sono filosofi della controdiairesi.
[ VIII,4 ] Com’è ben noto, nessuno può essere padrone della proairesi altrui.
[ VIII,5 ] Chi ormai conosce la natura umana, fa quel che essa richiede.
[ VIII,6 ] Il cosmo è in eterna trasformazione.
[ VIII,7 ] La natura umana esiste ed è tale che qualunque essere umano tende ad ottenere per sé ciò che giudica bello, giusto, buono ed a fuggire da quanto giudica per sé brutto, ingiusto, cattivo. Siamo pertanto autorizzati a definire la natura umana come una natura che tende alla felicità e non al suo contrario. E la proairesi centra questo fine quando conosce e rispetta la natura delle cose nei desideri e nelle avversioni, negli impulsi e nelle repulsioni, negli assensi e nei dissensi; lo fallisce quando ignora la natura delle cose.
[ VIII,8 ] Anche quando la lettura e lo studio ci sono impossibili, la nostra proairesi è pienamente attiva e funzionante.
[ VIII,9 ] Scrivendo queste parole circa le delizie della vita di corte, Marco Aurelio doveva certo avere sott’occhio queste altre di Epitteto: ‘Punto capitale: ricordati che la porta è aperta. Non essere più vile dei bambini ma come quelli, quando non gradiscono più una faccenda dicono: “Non giocherò più”; anche tu, quando certe cose ti paiano di quel genere, dicendo: “Non giocherò più”, allontanati. Se però rimani, non lamentarti’.
[ VIII,10 ] Il piacere fisico non è né un bene né un male, e dunque il saggio lo conosce, ne ha pratica ma non lo ricerca come un bene né lo fugge come un male.
[ VIII,11 ] Queste sono le domande che vanno rivolte a ciò che è proairetico ed a ciò che è aproairetico.
[ VIII,12 ] La retta proairesi si vede già dal mattino.
[ VIII,13 ] Quella che Marco Aurelio ripete qui è la classica tripartizione stoica della filosofia in: fisica, etica, logica.
[ VIII,14 ] Dimmi che giudizi hai e ti dirò chi sei.
[ VIII,15 ] Di che cosa ti sbalordisci? Di essere un uomo?
[ VIII,16 ] Libero è colui cui tutto accade secondo proairesi, quindi colui che sa anche correggere i propri errori. La libertà, infatti, è retto uso delle rappresentazioni, obbedienza alla natura delle cose; e nulla ha a che fare con il volere che succeda tutto quanto abbiamo reputato a casaccio, con la cieca ostinazione o con la follia.
[ VIII,17 ] L’afflizione è cosa proairetica e quindi in nostro esclusivo potere. Ed è tanto vizioso l’affliggersi e il biasimare quanto è virtuoso il cercare, con riserva, di correggere chi sbaglia o il suo errore. Ma se questo non è possibile, perché fare del male a se stessi affliggendosi?
[ VIII,18 ] Immortalità e trasformazioni del cosmo.
[ VIII,19 ] L’uomo non è nato né per godere nella carne né per aborrire di godere nella carne.
[ VIII,20 ] Come la semplice morte dell’uomo non è un male, così la sua semplice nascita non è un bene.
[ VIII,21 ] Soltanto grazie ad una retta proairesi l’uomo può sopportare la vita e il declino del proprio corpo.
[ VIII,22 ] Cosa accade se la virtù è un domani destinato a non arrivare mai?
[ VIII,23 ] Essere un uomo nel cosmo significa rispettare la natura delle cose.
[ VIII,24 ] La diairesi è come un bagno caldo che ci ripulisce di ogni bruttura.
[ VIII,25 ] Gli uomini passano su questa terra come le nuvole nel cielo; e questo paragone valga come un complimento sia per le nuvole che per gli uomini.
Lucilla e Vero sono la madre e il padre di Marco Aurelio. Massimo è il già citato Claudio Massimo e Seconda è, verosimilmente, la moglie. Epitincano e Diotimo sono personaggi ignoti. Antonino è Antonino Pio, padre adottivo di Marco Aurelio e Faustina è Faustina maggiore, zia di Marco Aurelio e moglie di Antonino Pio. Caninio Celere e Claudio Adriano sono due retori coetanei di Marco Aurelio. Carace, Demetrio ed Eudemone sono personaggi difficilmente identificabili con certezza.
[ VIII,26 ] Cos’è peculiare dell’uomo?
[ VIII,27 ] Essere un uomo nel mondo.
[ VIII,28 ] Nulla di esteriore ha accesso, come tale, alla nostra proairesi. Se anche il dolore fisico fosse un male per il corpo, la sua traduzione in afflizione, che è cosa proairetica, non è però irriflessa ed automatica ma è operazione sulla quale la proairesi ha il più completo controllo.
[ VIII,29 ] La retta proairesi ricorda continuamente a se stessa ciò che è in suo esclusivo potere e come utilizzare, con riserva e secondo il suo valore, ciò che non è in suo esclusivo potere.
[ VIII,30 ] La retta proairesi si muove dovunque con naturalezza, senza ricercatezze e senza sotterfugi.
[ VIII,31 ] Viste con certi occhi -e sappiamo bene quali-, le vicende delle stirpi umane sono un unico, vero, immenso, continuo macello.
Marco Aurelio cita come emblematici, in proposito, i lutti della famiglia dell’imperatore Augusto (63 a.C. – 14 d.C). I personaggi citati sono nell’ordine: la terza moglie Livia Drusilla; la figlia avuta dalla seconda moglie Scribonia, Giulia, che egli fece confinare a Ventotene per immoralità e che morì nel 14 d.C.; il nipote Marcello, figlio di sua sorella Ottavia e primo marito di Giulia, morto nel 23 a.C.; i nipoti Caio e Lucio, figli di Giulia e di Marco Agrippa, da lui adottati e che morirono nel giro di diciotto mesi: Caio in Licia nel 2 d.C. e Lucio a Marsiglia nel 4 d.C.; i figliastri Tiberio e Druso (morto nel 9 a.C.), figli di Livia Drusilla e del suo primo marito Tiberio Claudio Nerone; la sorella Ottavia, morta nell’11 a.C.; Marco Agrippa, morto nel 12 a.C.; Ario Didimo, filosofo della corte augustea e il celebre Mecenate, morto nell’ 8 a.C.
[ VIII,32 ] Siccome la proairesi è la facoltà che usa le rappresentazioni, l’uomo è padrone assoluto unicamente dei propri giudizi e di quanto da quei giudizi discende.
Non si possono non ricordare qui le parole di Epitteto in proposito: ‘Vengo dunque da questo interprete e sacrificatore e gli chiedo: “Esaminami le viscere, dimmi cosa mi significano”. Allora lui le prende, le sbroglia e poi mi spiega: “Uomo, tu hai una proairesi per natura non soggetta ad impedimenti e non soggetta a costrizioni. Qui, nelle viscere, questo vedo scritto. Te lo farò capire innanzitutto nell’ambito dell’assenso. Può qualcuno impedirti di dire di sì a ciò che è vero? Nessuno lo può. Può qualcuno costringerti a dire di sì a ciò che è falso? Nessuno lo può. Vedi dunque che in questo ambito ciò che è proairetico non è soggetto ad impedimenti, non è soggetto a costrizioni, è senza impacci? Orsù, e le cose stanno diversamente nell’ambito del desiderio e dell’impulso? Chi può vincere un impulso se non un altro impulso? Chi un desiderio ed un’avversione se non un altro desiderio ed un’altra avversione?” Ma qualcuno dice che se uno mi minaccia di morte, io sono costretto ad ubbidire e non sono più libero. “Non è la minaccia a costringerti e a toglierti la libertà, ma è il giudizio che tu reputi meglio fare quel che ti viene imposto invece che morire. Dunque a costringerti è stato il tuo giudizio; ossia è stata la tua proairesi che ha costretto se stessa. Questo è scritto nelle tue viscere e questo è il suo significato. Se lo disporrai sei libero. Se lo disporrai non biasimerai nessuno, non incolperai nessuno, tutto accadrà secondo l’intelligenza insieme tua e di Zeus’.
Ecco il piano della natura, ecco quanto è scritto nel DNA umano.
[ VIII,33] Questa è la regola d’oro e queste sono le parole di Epitteto alle quali Marco Aurelio si riferisce in questo frammento: ‘E qual è la legge divina? Serbare il peculiare e non pretendere ciò che è allotrio, ma usare quanto ci è dato senza bramare quanto non ci è dato. Quando ci sia sottratto qualcosa, restituirlo con scioltezza ed immediatamente, riconoscenti per il tempo dell’uso, se decidiamo di non ridurci a invocare la balia e la mamma’.
[ VIII,34 ] Gli arti mozzati dei Quadi e le teste mozzate dei Romani non hanno più la possibilità di essere riattaccati al corpo.
La proairesi dell’uomo, invece, può atteggiarsi secondo diairesi oppure secondo controdiairesi e passare liberamente dall’una all’altra.
[ VIII,35 ] Ragione e proairesi sono capacità insite nella Materia e che da essa scaturiscono. E come la natura ingloba e comprende tutto ciò che esiste, la proairesi riesce a fare di ogni apparente impedimento, materiale per il raggiungimento del fine verso cui si muove.
[ VIII,36 ] Le difficoltà, le fatiche, le sfide dell’esistenza sono sopportabili se la proairesi si rende conto di essere superiore ad esse.
[ VIII,37 ] Non rifiutare di vivere, accampando la scusa che non sei immortale e che sei destinato a diventare putredine.
Pantea potrebbe essere il nome di una concubina di Lucio Vero. Pergamo, Cabria e Diotimo potrebbero essere nomi di liberti.
[ VIII,38 ] Anche la putredine è secondo natura, e dalla cosiddetta putredine scaturisce anche la proairesi.
[ VIII,39 ] Parlando dell’incoerenza degli esseri umani nei loro giudizi circa beni e mali, Epitteto afferma che essi ammettono facilmente certi loro difetti, mentre altri non li ammettono facilmente. Per esempio nessuno ammette di essere stolto o ingiusto, ma ammette facilmente di essere timido o geloso perchè immagina che vi sia in ciò qualcosa di involontario.
Ora, se la giustizia è una virtù, ogni virtù è bene; e un bene non può contraddire un altro bene. Il piacere fisico, invece, non è una virtù, ma qualcosa che non è né bene né male, un materiale lavorando il quale la proairesi potrà centrare il proprio bene o il proprio male.
[ VIII,40 ] Il dolore fisico è cosa aproairetica. L’afflizione è cosa proairetica. Essere o non essere proairesi? Questo è il problema.
[ VIII,41 ] Nei vegetali e negli animali privi di ragione hanno continuamente luogo miriadi di stimoli e controstimoli del tutto aproairetici che provocano reazioni organiche o spingono l’organismo a soddisfare determinate necessità fisiologiche. Marco Aurelio, usando la figura retorica dell’iperbole, chiama ‘male’ per la natura tutto ciò che è capace di intralciare tali stimoli e controstimoli, dimenticando di avere invece già ribadito più volte che bene e male esistono soltanto nella proairesi dell’uomo. Fuori di retorica, dunque, tutto ciò che è capace di intralciare tali stimoli e controstimoli può essere considerato come un impedimento non, si badi, della natura vegetale o animale ma del funzionamento fisiologicamente ordinario di quel certo specifico vegetale o animale.
Non vi è differenza alcuna tra l’uomo e gli altri esseri viventi quanto ai suddetti stimoli e controstimoli. Essi continuano ad essere del tutto aproairetici anche nell’uomo e sono alla base della sua sopravvivenza: si pensi soltanto, per esempio, al sofisticatissimo ed autonomo controllo del ritmo cardiaco di base, della frequenza del respiro, e così via.
L’uomo è però un animale dotato di ragione, proairetico. Questo significa che tutta una serie di stimoli aproairetici, come il piacere e il dolore fisico, attraverso i sensi diventano materiale per sua la proairesi, la quale è dotata per natura della capacità di elaborare giudizi su di essi. Sono questi giudizi che danno poi luogo a impulsi all’azione, a desideri e così via, ossia a tutta quella gamma di attività proairetiche cui continuamente Marco Aurelio fa riferimento.
Due sono, infine, le caratteristiche della proairesi che egli sottolinea in questo frammento e che sono anche le fondamentali. La prima è la sua assoluta autoteoreticità ossia il fatto che soltanto essa può intralciare se stessa; la seconda, la sua capacità di atteggiarsi diaireticamente o controdiaireticamente.
[ VIII,42 ] La mia afflizione, comincia correttamente Marco Aurelio, è qualcosa in mio esclusivo potere, è proairetica, dipende esclusivamente da me, non può essere causata da nulla di aproairetico. Poi immediatamente dopo afferma di poter essere, lui, causa dell’afflizione altrui; come se l’afflizione, dunque, non fosse più qualcosa di proairetico ma qualcosa di aproairetico. È un po’ come se l’imperatore proclamasse con sussiego: ‘La virtù è proairetica perché è aproairetica’, e ai suoi sudditi toccasse il compito di sviscerare la profondità del pensiero sulla base del pregiudizio che un imperatore non può dire delle castronerie.
Il frammento appare dunque come una specie di sconclusionato ossimoro che Marco Aurelio, in un momento di scarsa padronanza delle sue facoltà logiche oppure semplicemente in vena di figure retoriche, mette insieme contraddicendo nella seconda parte quello che ha affermato nella prima.
Sia detto con buona pace di tutti coloro che ancora non lo credono oppure credono il contrario: si può mettere al mondo, salvare la vita o uccidere qualcuno, ma è impossibile fargli del bene o del male e dunque tanto meno causargli felicità o afflizione.
[ VIII,43 ] Felicità non è il possesso di un qualunque oggetto esterno ed aproairetico ma una proairesi rettamente operante.
[ VIII,44 ] E’ desiderabile la mia fama presso i posteri a scapito della mia felicità nel presente?
[ VIII,45 ] Questa sorta di minidiscorso dell’Areopago dell’uomo libero si rifà certamente al seguente brano di Epitteto: “O uomo sii demente ormai, come si dice, per la serenità, per la libertà, per la magnanimità. Drizza una volta il collo come allontanato dalla servitù; abbi l’audacia di levare lo sguardo a Zeus e dire: orbene, usami per quanto disporrai; cointelligo con te; sono tuo pari; nulla schivo di quanto reputi; dove disponi, conduci; del vestito che disponi, cingi. Disponi che io occupi cariche, sia un privato cittadino, rimanga, vada in esilio, sia povero di denaro, sia ricco di denaro? Per tutto questo io parlerò in tua difesa di fronte alle genti; mostrerò qual è la natura di ciascuna cosa”.
[ VIII,46 ] Epitteto dice chiaramente che per l’uomo c’è qualcosa di insopportabile: ‘Per la creatura logica, insopportabile è ciò che è irragionevole’.
E cos’è irragionevole? Tutto ciò che contraddice se stesso. Può qualcosa di aproairetico contraddire se stesso? Non può, giacché neppure può semplicemente contraddire. Tutto ciò che di aproairetico accade all’uomo può dunque essere conflittuale ma mai contraddittorio. Pertanto esso è pur sempre sopportabile, fino alla morte.
Ciò che è proairetico, invece, può essere contraddittorio e irragionevole. Salvo l’essere, proprio per questo, insopportabile per la proairesi, la quale non ha per natura la possibilità di fermarsi al bivio ma deve sempre sciogliere, e sempre scioglie, la contraddizione scegliendo l’alternativa che giudica per sé, magari aberrando, ragionevole e non contraddittoria.
Se al bue, alla vite e alla pietra non possono dunque accadere contraddizioni, all’uomo esse possono accadere e sono per lui insopportabili; mentre anche per lui, come per il bue, la vite e la pietra, le avversità aproairetiche sono sopportabili.
[ VIII,47 ] Se la nostra proairesi usa la diairesi e dunque distingue ciò che è in suo esclusivo potere da ciò che non lo è, le avversità aproairetiche sono e rimangono avversità aproairetiche. Se invece la proairesi usa la controdiairesi, dimentica di avere in proprio esclusivo potere i giudizi su ciò che è aproairetico e pronuncia così giudizi inadeguati sulla natura delle cose, essa trasforma inevitabilmente se stessa in afflizione ed infelicità.
[ VIII,48 ] Che la proairesi sia autodeterminativa è attestato anche dal fatto che essa può disporsi contro la natura delle cose e dunque, in un certo senso, contro se stessa quando sceglie di atteggiarsi controdiaireticamente. Alla proairesi è permesso aberrare in questo modo proprio perché essa è libera, infinita, inasservibile e insubordinabile da tutto ciò che le è esterno.
Vale per la proairesi dell’uomo quello che valeva per la città di Ilio assediata dagli Achei: essa è sempre e comunque un’acropoli inespugnabile dall’esterno.
[ VIII,49 ] Le rappresentazioni cui dare il nostro assenso sono, come sappiamo, le rappresentazioni catalettiche. Le rappresentazioni cui negarlo sono quelle che la proairesi aggiunge di suo impropriamente, giacché non corrispondono a nulla di obiettivo se non alla possibilità della proairesi stessa di atteggiarsi controdiaireticamente, ossia di scotomizzare la diairesi tra ciò che è in suo esclusivo potere e ciò che non lo è. Quest’ultima operazione, com’è noto, è all’origine di tutte le passioni e di tutti i vizi.
[ VIII,50 ] La natura è onnicomprensiva, non ha nulla al di fuori di sé e dunque nulla, assolutamente nulla, può essere contro natura.
[ VIII,51 ] La nostra proairesi è una sorgente perenne di acqua pura quando riconosca se stessa per quello che è per natura: una facoltà capace di lavorare con arte e di trasformare in virtù qualunque materiale le venga sottoposto.
[ VIII,52 ] C’è qualcuno qui che applaude?
[ VIII,53 ] Ti ripeto la domanda: vuoi essere lodato dagli insipienti?
[ VIII,54 ] Paragonando l’aria alla Prònoia che pervade il cosmo e che egli vede dappertutto, Marco Aurelio invita a cointelligere con la mente della Materia Immortale così come respiriamo l’aria che ci circonda.
[ VIII,55 ] Sul frontone del tempio di Apollo a Delfi era scritto: ‘Riconosci te stesso’.
Riconoscere se stessi significa riconoscere che il cosmo è immune da qualunque bene e da qualunque male, giacché essi non esistono altro che nella proairesi degli esseri umani.
La proairesi, pertanto, non può fare del male o del bene né al cosmo né ad un’altra proairesi ma soltanto ed unicamente a se stessa.
[ VIII,56 ] Abbiamo già avuto modo di notare che Marco Aurelio definisce l’essere umano come la sintesi di tre componenti: una componente corporea risultante di terra e di acqua, una componente pneumatica derivata dall’aria e dalla quale risultano tutte le funzioni animali, e una componente proairetica derivata dal fuoco e che qualifica l’uomo come finora unico essere razionale nel cosmo.
La natura delle cose, inoltre, inviolabilmente dispone che nessuna proairesi possa essere padrona della proairesi altrui e che soltanto in questa stiano il bene ed il male. Dunque nessuno è signore né di procacciarmi il bene né di precingermi del male, ma io solo ho potestà su di me a questo riguardo.
[ VIII,57 ] Le caratteristiche della luce del sole che permea e riscalda la nostra atmosfera sono avvicinate da Marco Aurelio a quelle della Prònoia che permea e dà le sue leggi al cosmo.
L’etimologia che Marco Aurelio dà della parola ‘raggi’ è comunque errata.
[ VIII,58 ] La morte, essendo un evento aproairetico come la nascita, non è né un bene né un male e, come tale, non va né desiderata né temuta.
[ VIII,59 ] Cosa siete venuti al mondo a fare?
[ VIII,60 ] Il volo della freccia e il volo della mente tendono sempre ad un obiettivo.
[ VIII,61 ] Mostrami i tuoi giudizi e ti dirò chi sei. Guarda i miei giudizi e capirai chi sono.
*****
[ IX,1 ] Nella natura non esistono contraddizioni di sorta ma soltanto contrasti, contrarietà, conflitti, opposizioni reali. Così il dolore non contraddice il piacere ma è altra cosa, opposta ad esso. La morte non contraddice la vita ma è il suo contrario; il dolce non contraddice l’amaro né il ruvido il liscio, tant’è vero che due qualità opposte non possono coesistere allo stesso tempo nella medesima entità.
Neppure esiste nella natura qualcosa che possa essere chiamato falso, in quanto la sua mera esistenza fa di esso un ente la cui verità è per ciò stesso automaticamente e intrinsecamente qualificata. La natura fa dunque soltanto cose vere e, considerata come la più comprensiva e primigenia delle divinità, può essere chiamata Verità e fonte di ogni Verità.
Se essa fa soltanto cose vere, saranno altrettanto naturali e veri tanto il dolore che il piacere, il freddo ed il caldo ed ogni altra sorta di opposti, che saranno da considerarsi per natura equivalenti e da porsi sullo stesso piano.
Della natura fa parte anche l’uomo, che essa ha generato vero come qualunque altra sua opera. All’uomo la natura ha però dato qualcosa che, per quanto è finora a nostra conoscenza, non ha dato a nessun’altra creatura: la comprensione dell’uso delle rappresentazioni ovvero la proairesi, la capacità di distinguere il bene dal male, la possibilità di essere felice oppure infelice.
Comunque l’uomo usi la sua proairesi, evidentemente quest’uso sarà sempre, per definizione, naturale e non potrà mai essere contrario a natura. Se, infatti, questo fosse possibile, significherebbe che la natura ha generato qualcosa che natura non è più, ossia che l’uomo non è più parte della natura che l’ha generato: il che è assurdo.
È grazie alla proairesi fornitagli dalla natura che l’uomo è capace di riconoscere, nell’ambito dell’unico tutto da essa rappresentato e del quale egli è parte, un fatto empirico, constatabile, evidente: l’esistenza di due classi di cose. La prima classe è rappresentata dall’insieme di tutti quegli enti, come il corpo, che non sono in suo esclusivo potere. La seconda dall’insieme di tutti quegli enti, come i giudizi, che sono invece in suo esclusivo potere. Della prima classe fa parte tutto ciò che è aproairetico. Della seconda classe tutto ciò che è proairetico.
Questa bipartizione fondamentale delle cose, questa diairesi che le suddivide in due classi distinte e distintamente riconoscibili è naturale, è scritta nelle cose, è completamente indipendente dalla proairesi umana e la nostra proairesi ha soltanto la capacità di riconoscerla ma nessuna capacità di modificarla.
Questa struttura empiricamente vera della natura, così come essa si presenta alla proairesi umana può essere allora correttamente chiamata ‘natura delle cose’. La Verità della natura appare alla proairesi umana come esistenza della ‘natura delle cose’ e questa può essa stessa essere chiamata Verità.
È in relazione a questa verità, ossia alla natura delle cose, che l’uomo può disporsi in armonia oppure in contrasto; mentre qualunque atteggiamento l’uomo prenda esso sarà sempre e comunque in armonia con la natura. È in relazione alla natura delle cose che l’uomo prende, e non può non prendere, ogni istante posizione; che egli vive la sua virtù e il suo bene quando è in armonia con essa e la sua viziosità e il suo male quando è in contrasto con essa.
Siccome la natura è onnicomprensiva, diairesi e controdiairesi, virtù e vizio, giustizia e ingiustizia, menzogna e sincerità e insomma qualunque altra coppia di opposizioni possibili sono pienamente naturali. E siccome la natura delle cose non è neppur minimamente in nostro potere ed è per noi inviolabile, l’uomo può commettere i peggiori misfatti e nutrire le viziosità più perverse nella più completa e totale indifferenza, al riguardo, della natura e della natura delle cose, le quali proseguono imperterrite il loro cammino assorbendo e metabolizzando qualunque iniziativa umana.
L’ingiustizia e la menzogna, per fermarci ai primi due casi che Marco Aurelio cita nel frammento, sono empietà perché sono entrambe forme della negazione dell’esistenza della natura delle cose; poiché equivalgono a giudicare ed operare come se fosse in mio esclusivo potere ciò che in mio esclusivo potere non è, oppure come se non fosse in mio esclusivo potere ciò che invece è in mio esclusivo potere.
È soltanto l’uomo, e non la natura, a subire il contraccolpo della propria negazione della natura delle cose. Questo contraccolpo ha un nome: contraddizione. E contraddizione è sinonimo di aberrazione, passione, schiavitù, infelicità.
Medea entrò in contraddizione con se stessa perchè voleva Giasone ma contemporaneamente non voleva Giasone sposo di Glauce e re di Corinto. Limitandoci al caso specifico, Giasone invece non era in contraddizione con se stesso perché voleva Medea così com’era, donna e madre dei suoi figli. Le contraddizioni sono esclusivamente interne alla testa degli uomini, sono individuali e sono insopportabili. Credere che qualcosa sia contemporaneamente e nei medesimi riguardi giusto e ingiusto è impossibile. Epitteto al riguardo è, come al solito, chiarissimo quando afferma che volere in violazione della natura delle cose è ignorare di disporre così la propria infelicità, giacché ogni aberrazione dell’essere umano include una contraddizione. Chi aberra, infatti, non ha l’intenzione di aberrare ma di avere successo: dunque è manifesto che egli non fa ciò che vuole. Cosa vuole infatti effettuare il ladro? Il proprio utile, che egli identifica col rubare: ma rubare è appunto una forma di negazione dell’esistenza della natura delle cose. E dunque se rubare non gli è utile, non fa quanto vuole. La contraddizione è per natura delle cose invisa ad ogni animo razionale, ma finché questo non comprenderà di essere in contraddizione, nulla impedisce che faccia cose contraddittorie. Ma comprendendolo, è del tutto necessario che si distorni dalla contraddizione e la fugga; così com’è amara necessità per chi si accorge che una cosa è falsa, dissentire dalla falsità. Finché però non lo immagina, le assentirà come ad una cosa vera.
[ IX,2 ] L’ignoranza delle cause della peste uccide uomini e animali. Vi è una peste che uccide la proairesi e lascia l’uomo in vita: si chiama controdiairesi o ignoranza o negazione della natura delle cose.
Quando la proairesi abbia raggiunto la sua maturità fisiologica e l’essere umano abbia quindi appreso l’esistenza della natura delle cose, della diairesi e della controdiairesi, bisogna immaginare l’esistenza umana come composta da tante cellule di vita più o meno piccole i cui confini temporali sono segnati dai più diversi ed imprevedibili eventi aproairetici e che sono qualificate al loro interno, nella loro durata, dall’atteggiamento che vi ha assunto la proairesi. Se la proairesi vi ha assunto un atteggiamento diairetico si tratta di cellule virtuose, mentre se la proairesi vi ha assunto un atteggiamento controdiairetico si tratta di cellule viziose.
Ciò che Marco Aurelio si auspica in questo frammento è che tutte le cellule di vita siano virtuose. Ma è facile vedere che ciò, se non impossibile in astratto è però praticamente impossibile. Sarebbe come auspicare che tutti i pezzi di ferro fossero calamite o che al mondo non esistessero gli insipienti. Non è dunque né contro natura né decisivo il fatto che anche il saggio entri a volte in cellule di vita da stolto: l’importante è che la proairesi dell’uomo conservi la naturale qualità di spostarsi il più rapidamente possibile dalla controdiairesi alla diairesi e qui rimanga finché gli è possibile e dato.
Come la Sfinge pose ad Edipo la domanda rispondendo alla quale Edipo divenne re di Tebe e la Sfinge perì, così ogni cellula di vita pone sotto forme nuove e diverse sempre la stessa domanda, sapendo rispondere correttamente alla quale l’uomo diventa padrone di se stesso, almeno fino al prossimo errore.
[ IX,3 ] Come è stato già più volte ribadito, la morte è un evento del tutto naturale al pari della nascita, della crescita, della maturità della proairesi. La proairesi matura e retta non brama la morte e non la giudica un bene, così come non la aborre e non la giudica un male. Le proairesi di quasi tutti coloro che Marco Aurelio ha intorno la giudicano invece un male e si comportano in conseguenza. La compagnia di queste persone non è quella che si chiamerebbe la più auspicabile e il separarsi da loro con la morte non sarà un evento che si tingerà di rimpianto.
[ IX,4 ] Poiché bene e male sono giudizi e i giudizi sono entità proairetiche, l’uomo può fare del male soltanto a se stesso, non certo alla natura né ad un altro individuo.
[ IX,5 ] Chi capisce che omettere un’azione non è un ‘non fare’ ma il farne un’altra capirà anche facilmente quanto sia insensato omettere di farsi del bene.
[ IX,6 ] Di cosa c’è bisogno? C’è bisogno di un assenso, di un impulso, di un desiderio in accordo con la natura delle cose, quale soltanto la retta proairesi sa fornire all’uomo.
[ IX,7 ] La proairesi è signora assoluta dei nostri desideri, dei nostri impulsi e dei nostri assensi.
[ IX,8 ] L’unità del cosmo.
[ IX,9 ] Tutto ciò che partecipa di una comune natura ha la potente tendenza a riunirsi con ciò che gli è congenere. Così fa ciascuno dei quattro elementi e così fanno tutte le forme di vita, uomo compreso.
Siccome però la proairesi è una formidabile facoltà umana che ha tuttavia la caratteristica di essere a doppio taglio, in quanto può atteggiarsi diaireticamente o controdiaireticamente, questa tendenza coesiste nell’uomo con una tendenza opposta ad allontanarsi dai suoi simili.
Notevole, nel frammento, è la spiegazione della combustione con la nota teoria chimica del ‘flogisto’, che avrà corso fino al tardo Medio Evo e oltre.
[ IX,10 ] Mentre sono altri a fruire dei frutti dei vegetali, il frutto della proairesi è fruito dalla proairesi stessa, in quanto capace di rendere se stessa tale quale decide di essere. Questo vale per il cosmo, ossia dio, su scala generale; e per l’uomo, come parte del cosmo, su scala individuale.
[ IX,11 ] La retta proairesi ha in se stessa le risorse per fronteggiare qualunque situazione ed essere pace vivente.
Allo stesso tempo bisogna aver chiaro che se la proairesi non è rettamente atteggiata essa si è gia comunque punita da se stessa, in quanto infelice per non essere riuscita a soddisfare i propri desideri.
E va anche ricordato che essa sarebbe comunque altrettanto infelice pur se gli dei ne avessero esaudito i desideri, in quanto non avrebbe retti giudizi su ciò che ha ricevuto e quindi ne farebbe un uso aberrante.
[ IX,12 ] Augia aveva una sterminata ricchezza di greggi e di armenti ed Eracle ebbe da Euristeo l’ordine di ripulire in un solo giorno le stalle di Augia dalla enorme quantità di letame che vi si era accumulata. Cosa che egli, come il mito racconta, riuscì a fare; e l’impresa è annoverata come una delle dodici fatiche di Eracle.
L’impresa cui Marco Aurelio si era assoggettato, ossia quella di ripulire almeno parzialmente l’impero dall’immensa quantità di merda che lo ricopriva, era impossibile e non ebbe successo. Perciò potrebbe ben essere chiamata ‘la tredicesima fatica di Eracle’.
[ IX,13 ] Dove stanno di casa le circostanze difficili? Esse non stanno fuori della proairesi ma dentro di essa, nel giudizio che quelle circostanze siano difficili.
[ IX,14 ] Che cosa mi sia trovato davanti e che odore abbia sentito quando ho aperto la porta dell’impero, lo lascio dire a voi.
[ IX,15 ] Le cose esterne ed aproairetiche non parlano mai da sole. È la proairesi dell’uomo che mette loro in bocca le parole.
[ IX,16 ] Passività è per Marco Aurelio sinonimo di cose esterne e aproairetiche; attività sinonimo di cose proairetiche ossia in nostro esclusivo potere. Bene e male dell’uomo, dunque, sono entità proairetiche.
[ IX,17 ] È evidente, è solare che per tutto ciò che è aproairetico non esistono né bene né male.
[ IX,18 ] Tutti gli insipienti sono esseri che hanno reso se stessi vili, schiavi, infelici. Perché, dunque, temere il giudizio di chi non sa rettamente giudicare né gli altri né se stesso?
[ IX,19 ] Il cosmo, come è già stato spesso ribadito, è in perenne trasformazione; e il corpo stesso dell’uomo vivente è in continua distruzione e ricostruzione.
[ IX,20 ] Un ordine morale in cui un individuo faccia il male e sia un altro, che non vi ha alcuna responsabilità, a subirlo è inconcepibile.
[ IX,21 ] Non la morte, ma il giudizio che la morte sia qualcosa di male e di terribile: questo è il male terribile.
[ IX,22 ] 10, 100, 1000 egemonici congeneri e parti dell’unico cosmo.
La proairesi incline alla giustizia è ovviamente quella atteggiata diaireticamente. Pare altrettanto ovvio che la proairesi sia ignoranza se atteggiata controdiaireticamente e sia invece intelligenza se atteggiata diaireticamente.
[ IX,23 ] Quanto all’essere animali proairetici, ossia capaci di diairesi e di controdiairesi, non v’è alcuna differenza tra un imperatore e un comune cittadino. Ma non vi è alcuna differenza tra di essi anche per quanto attiene alle loro funzioni fisiologiche e quindi quanto all’essere produttori di escrementi. Una data società composta da un dato numero di individui produrrà mediamente una data quantità di escrementi in un dato tempo.
Epitteto dedica un intero capitolo delle ‘Diatribe’ alla ‘pulizia’ del naso, dei piedi, dei denti, della pelle e così via per far comprendere come la produzione di escrementi sia normale, inevitabile e vada correttamente giudicata, in quanto aproairetica, come né un bene né un male; e come sia altrettanto doveroso, e dunque proairetico, trattarla in modo razionale, senza eccentricità e senza stravaganza, per fare opera da uomo e non infastidire gli altri uomini. Sono dunque aberrazioni tanto la coprofilia quanto la coprofobia.
La metafora escrementizia è particolarmente adatta a far comprendere cosa siano in realtà il sistema politico e la vita politica, nella quale sono sempre ed esclusivamente in gioco entità proairetiche come giudizi, ambizioni, programmi, progetti e così via. Infatti, se è vero, com’è vero, che non v’è differenza alcuna tra cittadini qualsiasi e imperatore quanto a capacità proairetica e se è altrettanto vero che il ‘male’ è l’uso scorretto delle rappresentazioni e dunque l’atteggiamento controdiairetico della proairesi, sarà anche vero che la quantità di male e di bene in una data società sarà altamente variabile in funzione del numero delle proairesi impegnate nella controdiairesi e nella diairesi e del rilievo relativo che i giudizi di proairesi diverse, con il loro esempio, possono avere sul funzionamento del sistema politico.
Limitiamoci a considerare unicamente l’uso della controdiairesi e lasciamoci ancora guidare nell’analisi da Epitteto: ‘Ma non troveresti l’impurezza dell’animo visibile come quella del corpo, poiché quale altra impurezza dell’animo troveresti se non quanto lo fa sozzo nelle sue opere? Ora, opere dell’animo sono impellere, repellere, desiderare, avversare, prepararsi, progettare, assentire. Cos’è mai, dunque, che procura un animo sozzo ed impuro in queste opere? Null’altro che le sue determinazioni depravate. Sicché impurezza dell’animo sono i malvagi giudizi, mentre è purificazione l’infusione di giudizi quali devono essere. Puro è l’animo che ha giudizi quali deve, giacché soltanto questo è senza confusione e sudiciume nelle proprie opere’.
È evidente, e non richiede più spiegazioni del sorgere del sole, il fatto che in qualunque società una percentuale variabile di proairesi saranno comunque sempre atteggiate controdiaireticamente. Bisogna dunque trovare innanzitutto pace nel giudizio che il male e le aberrazioni, sotto le forme più varie, sono realtà socialmente ineliminabili. Male che comunque ciascun cittadino fa a se stesso. Ma mentre fa quel male a se stesso, il cittadino, nel medesimo momento, produce qualcos’altro, ossia delle azioni, le quali sono entità aproairetiche per coloro che gli stanno intorno, e questi sono a loro volta necessariamente obbligati a tenerne conto.
Queste azioni sudice, in quanto derivanti da giudizi aberranti e depravati, sono gli escrementi della metafora.
Bene sarà allora il giudizio che ci spinge a fare un certo uso di questi escrementi, rimanendo in terreno diairetico col seppellirli senza toccarli e lasciando che la natura li conduca al loro destino. Male sarà il giudizio che ci spinge a cibarcene, ossia l’atteggiare controdiaireticamente la nostra proairesi e pascere a nostra volta altri individui, stabilendo così quella catena magica di merda che si chiama comunemente sistema politico e vita politica. Sistema politico e vita politica i quali, travestiti, truccati, occultati nella loro essenza e propagandati come appetibili, non possono che condurre necessariamente, prima o poi, alla guerra civile, alla guerra fra nazioni, a inevitabili stermini di massa.
Di quale fine socievole, infatti, si può parlare per l’uomo se questo fine non è un fine riferito al rispetto della natura delle cose e alla libertà della proairesi? Soltanto il cittadino che si appropria di colui che l’uomo è davvero per natura delle cose ha fatto l’azione più socialmente utile che si possa fare.
Un sistema politico sano è dunque quel sistema politico in cui vi è da parte dei cittadini un uso di massa della diairesi, un’assunzione di responsabilità individuale a livello molecolare, una difesa della libertà della proairesi a qualunque prezzo e che pertanto necessita anche di un ridotto, anzi ridottissimo, numero di ‘leggi’. Soltanto in questo modo la produzione di escrementi è contenuta entro limiti ragionevoli.
Un sistema politico è, ovviamente, malato e inquinato quando accade il contrario, e coloro che hanno poteri e responsabilità più ampie dei comuni cittadini operano attivamente per moltiplicare invece che per diminuire la quantità degli escrementi prodotti: moltiplicazione che Marco Aurelio, in questo frammento, si augura, forse invano, di poter scongiurare.
[ IX,24 ] L’evocazione dei morti e la pratica della controdiairesi.
[ IX,25 ] Nel sonno la nostra proairesi è spenta.
[ IX,26 ] È impossibile non pagare il prezzo che la controdiairesi esige.
[ IX,27 ] La verace e virtuosa benevolenza consiste appunto nel fare presente agli insipienti il lezzo che le loro proairesi emanano.
Quanto agli dei, quando essi decidono di punire gli insipienti non fanno altro che esaudirne i desideri.
[ IX,28 ] I mutamenti continui e incessanti cui il cosmo e le sue creature vanno soggetti non sono altro che ondate successive di trasformazioni dell’unica Materia Immortale che lo sostanzia.
Di fronte a questa evidente realtà, la domanda che Marco Aurelio sempre si pone è la seguente: “Questo mutamento è guidato da un egemonico oppure risulta dalla pura casualità dei movimenti degli atomi?”.
Si tratta, come sappiamo, della classica alternativa tra la prospettiva finalistico-provvidenzialistica e quella materialistico-meccanicistica; e sappiamo anche che Marco Aurelio rifiuta la seconda, propria di Democrito e di Epicuro, in quanto gli riesce impossibile immaginare che qualunque moto non abbia una causa, che la materia organica derivi da quella inorganica e che la mente sia una ‘dimensione’ della Materia Immortale.
All’interno, dunque, della prima prospettiva e senza prendere al riguardo una posizione netta, egli si chiede allora se l’egemonico del cosmo abbia dato un impulso iniziale al mutamento una volta sola oppure se intervenga di volta in volta nel succedersi dei singoli eventi.
Ai suoi occhi, in ogni caso, la garanzia dell’esistenza di una proairesi del cosmo riposa sulla constatazione empirica dell’esistenza della proairesi umana. Questo fa sì che, anche se il cosmo fosse irrazionalità pura, l’uomo godrebbe però del privilegio di poter operare razionalmente.
Ma per operare razionalmente la proairesi dell’uomo deve usare la diairesi ossia riconoscere, secondo le parole con le quali si apre il ‘Manuale’ di Epitteto, che: “Delle cose che sono, alcune sono in nostro esclusivo potere mentre altre non sono in nostro esclusivo potere. In nostro esclusivo potere sono concezione, impulso, desiderio, avversione e, in una parola, quanto è opera nostra. Non sono in nostro esclusivo potere il corpo, il patrimonio, la reputazione, le cariche e, in una parola, quanto non è opera nostra. Le cose in nostro esclusivo potere sono per natura libere, non soggette ad impedimenti, non soggette ad impacci; mentre le cose non in nostro esclusivo potere sono deboli, serve, soggette ad impedimenti, allotrie.” E che pertanto chi è dotato di una proairesi per natura libera, non soggetta ad impacci e ad impedimenti può giudicarsi superiore a tutto ciò che è debole, servo e soggetto ad impedimenti.
[ IX,29 ] I celebri e celebrati Alessandro Magno, suo padre Filippo di Macedonia, Demetrio -‘Falereo’ secondo alcuni o ‘Poliorcete’ secondo altri studiosi-, sono qui presi da Marco Aurelio a simboli eminenti di chi?
Di quei filosofi della controdiairesi i quali proclamano che l’ordine della natura è ingiusto e dunque che essi sono venuti al mondo per cambiarlo. Nella più totale ignoranza della differenza tra ‘natura’ e ‘natura delle cose’ essi e i loro seguaci promettono ai popoli di costruire la Repubblica di Platone e di portare libertà e giustizia a genti e popoli che gemono e simulano di obbedire. Mocciosi cialtroni tanto gli uni quanto gli altri, in quanto si ostinano a non imparare, e forse non impareranno mai, a distinguere ciò che è proairetico da ciò che è aproairetico.
Nel cosmo, invece, tutto avviene in armonia con la natura e la natura è radicalmente indifferente al bene e al male, al vizio e alla virtù, alla felicità e all’infelicità di esseri umani che essa potrebbe annientare e far sparire in qualunque momento senza neppure accorgersene.
E allora che fare? Certo non mettere mano a ciò che è impossibile, ossia a persuadere tutti gli esseri umani di quali siano i beni ed i mali. Ma a quello soltanto che è possibile e ci è stato dato: persuadere noi stessi dell’esistenza della natura delle cose, educarci ad operare la diairesi ed imparare l’arte di essere felici nel mondo così com’è.
Alessandro Magno e Filippo di Macedonia sono personaggi troppo noti perché vi sia bisogno di precisazioni. Demetrio Falereo visse tra il 345 e il 283 a.C. Fu allievo di Teofrasto e resse il governo di Atene dal 317 al 307 a.C., quando ne fu scacciato da Demetrio Poliorcete. Quest’ultimo visse tra il 337 e il 283 a.C. quando morì ad Apamea, in Siria. Ebbe vita avventurosissima e fu al centro delle vicende politiche e militari che coinvolsero in quegli anni la Grecia, il vicino Oriente e l’Africa.
[ IX,30 ] Lo spettacolo della enorme varietà delle vicissitudini umane è un’immagine dell’immensità del cosmo e una incontrovertibile testimonianza del fatto che la memoria di qualunque avvenimento è comunque destinata a scomparire.
[ IX,31 ] Dominio sullo sconcerto davanti agli eventi esteriori ed aproairetici, e conformità alla virtù per quelli che originano nella nostra proairesi.
[ IX,32 ] Soltanto l’uomo ha il privilegio di quello sguardo dall’alto che gli permette di abbracciare il cosmo intero e di riconoscere come felicità ed infelicità siano in suo proprio esclusivo potere.
[ IX,33 ] Come ogni cosa, anche l’Impero Romano è destinato inevitabilmente a scomparire. Poi la stessa sorte toccherà a ciò che l’avrà sostituito e così via all’infinito.
[ IX,34 ] Intorno a me, sembra dire Marco Aurelio, la controdiairesi è una pratica di massa.
[ IX,35 ] La morte è trasformazione naturale tanto quanto la vita, e siccome nulla di ciò che avviene nel cosmo può dirsi contro natura è evidente che al di fuori della proairesi umana non esistono né bene né male. Neppure alla proairesi umana è dato di atteggiarsi contro ‘natura’, ma soltanto in armonia o contro la ‘natura delle cose’ generando così il proprio bene o il proprio male.
[ IX,36 ] L’uomo è la sua proairesi, ma l’uomo non è soltanto proairesi bensì anche Materia immortale in continua trasformazione.
[ IX,37 ] Pure se tre sarebbero già anche troppi, gli insipienti scelgono sempre per se stessi almeno cent’anni di solitudine e di sconcerti.
[ IX,38 ] Bene e male abitano soltanto nella nostra proairesi, non in ciò che è aproairetico.
[ IX,39 ] Poiché è una facoltà autoteoretica, la proairesi può anche dubitare di se stessa.
[ IX,40 ] La preghiera in senso proprio può essere definita come una forma di relazione ‘senza riserva’ che la proairesi dell’essere umano pratica nei confronti di entità che immagina onnipotenti al fine di ottenere, in ogni caso, qualcosa di esterno ed aproairetico che non è in suo esclusivo potere. Qualunque preghiera, pertanto, implica l’atteggiamento compiutamente controdiairetico della proairesi e su di esso si fonda.
Alcuni individui, ad esempio, pregano una entità che chiamano ‘Padre’. Dopo averne definito la residenza ‘nei cieli’ e dunque lontano dalla terra che abitano, invocano l’avvento del suo ‘regno’, con ciò implicando che di esso non vedono traccia alcuna intorno a loro. Quindi passano subito ad esplicite e pressanti richieste di prestazioni ed oggetti esterni ed aproairetici simboleggiati dal ‘pane quotidiano’, dalla ‘remissione dei debiti’, dal ‘non essere indotti in tentazione’ e dall’essere ‘liberati dal male’.
L’auspicio, a sua volta, può essere definito in senso proprio come una forma di relazione ‘con riserva’ che la proairesi dell’essere umano pratica nei confronti di se stessa al fine di introdursi all’ottenimento di qualcosa di interiore e proairetico che è in suo esclusivo potere. L’auspicio implica, pertanto, l’atteggiamento compiutamente diairetico della proairesi e su di esso si fonda.
Se pregare dicendo: ‘Dacci oggi il nostro pane quotidiano’ definisce una civiltà; allora auspicare dicendo: ‘Possa io non avere paura di non avere il pane quotidiano’ ne definisce una diversa. La vita di ciascuno di noi non è altro che la pratica del giudizio su quale delle due civiltà ci meritiamo.
[ IX,41 ] Nel sublime passo di Epicuro che Marco Aurelio non esita qui a citare, abbiamo l’esempio di un comportamento esemplare nella malattia e, in genere, nelle circostanze difficili. Ed è corretto e sufficiente intendere ‘intelletto’ come equivalente del termine ‘proairesi’, per rendersi conto di quanto affini siano epicureismo e stoicismo su questioni nient’affatto secondarie.
[ IX,42 ] Lo sfacciato, il furbastro, le persone sleali fanno comunque opere possibili e dunque altrettanto naturali di quelle di chi è virtuoso. E come sarebbe insensato richiedere che quanto è naturale non accada, così sarebbe aberrante richiedere che accada l’impossibile.
Ora, poiché la natura delle cose inviolabilmente dispone che premio e pena, bene e male, felicità e infelicità siano incorporati, per ciascuno di noi, nei suoi stessi atti di pensiero, il saggio ha pienamente ragione di non affliggersi delle aberrazioni altrui e di farle anzi diventare altrettante occasioni, da un lato, per eventualmente correggere la sua superficialità o la sua imprudenza al riguardo e, dall’altro, per fare opera di filosofica educazione alla diairesi nei confronti di chi ha aberrato. Con riserva, ovviamente: ossia senza pretenderne una qualunque ricompensa né dolersi di non essere ascoltato o di essere frainteso.
*****
[ X,1 ] Socrate dice ad Anito e Meleto: “Voi potete farmi uccidere ma non potete farmi del male”. Identiche sono le parole che la proairesi dell’uomo può rivolgere a tutto ciò che è aproairetico.
Essa, infatti, è per natura libera, infinita, inasservibile, insubordinabile e ciò che è aproairetico può spegnerla, cancellarla, estinguerla ma non farle del male né traviarla. Essa soltanto può traviare se stessa e rendersi schiava, finita, asservibile e subordinabile.
Come? Atteggiandosi controdiaireticamente, ossia negando l’esistenza della natura delle cose e rifiutando la diairesi in cose in nostro esclusivo potere e cose non in nostro esclusivo potere. Natura delle cose per la quale tutto ciò che è aproairetico è, per la nostra proairesi, indifferente e dunque né bene né male: natura, cosmo e Zeus compresi.
Nel presente frammento Marco Aurelio descrive se stesso come lontano da questo stato di naturale perfezione. Perfezione che comunque attesta di conoscere molto bene, giacché egli non soltanto diagnostica con esattezza la malattia da cui è affetta la sua proairesi ma ne propone anche la prognosi e i rimedi necessari per curarla.
[ X,2 ] Natura inanimata, natura animale e natura razionale possono e devono coesistere armoniosamente nell’uomo.
[ X,3 ] L’uomo può agevolmente tollerare tutto ciò di cui è in grado di concepire la tollerabilità. Per la creatura logica intollerabile è soltanto ciò che è irragionevole ossia tale da contraddire se stesso. Tutto ciò che non contraddice se stesso, invece, è tollerabile.
Dunque le opposizioni reali tra entità aproairetiche diverse sono tollerabili, mentre le contraddizioni tra giudizi nell’ambito di una singola proairesi sono intollerabili.
Perciò noi abbiamo bisogno di educazione alla diairesi soprattutto per questo: per imparare ad adattare il preconcetto di tollerabile e di intollerabile ad ogni particolare circostanza in armonia con la natura delle cose.
[ X,4 ] Ogni aberrazione dell’essere umano include una contraddizione.
Pur tenendo ben salda la verità che nessuno è padrone della proairesi altrui, il saggio ha però la pazienza di additare a chi glielo richieda la contraddizione per cui aberra, facendogli riscontrare chiaramente come egli stia compiendo, per dir così, qualcosa che non vuole.
[ X,5 ] Prestabilito fin dall’eternità è l’evento con il quale la tua proairesi dovrà confrontarsi, ma non il come la tua proairesi si atteggerà di fronte ad esso.
[ X,6 ] Nulla nel cosmo può mai essere contro natura ed io, Marco Aurelio oppure uomo qualunque, sono una parte dell’insieme governato dalla natura.
Che poi la proairesi degli uomini si atteggi diaireticamente o controdiaireticamente, ossia in armonia con la natura delle cose oppure contro la natura delle cose, è del tutto indifferente per il cosmo.
Un simile evento, infatti, ha rilievo unicamente in relazione alla felicità o infelicità degli uomini come parti individuali dell’insieme cosmico alla cui perfezione, comunque, essi collaborano inevitabilmente anche quando credessero di poterla ostacolare o danneggiare.
[ X,7 ] Bene e male esistono soltanto nella proairesi dell’uomo, il quale è materia immortale destinata, come tutte le altre parti del cosmo, ad una continua e incessante trasformazione.
[ X,8 ] L’uomo è un essere capace di mettersi in viaggio verso le Isole dei Beati oppure verso le popolarissime isole dei Disperati.
In queste ultime, gente incosciente e pusillanime, mezza divorata dalle belve, piena di ferite e di sangue coagulato implora nondimeno di essere conservata in vita per la caccia dell’indomani e di essere offerta in quello stato agli stessi artigli e agli stessi morsi ferini.
[ X,9 ] Sacra è la diairesi ossia il supergiudizio che ci fa capaci di distinguere ciò che è in nostro esclusivo potere e ciò che non lo è, ciò che è proairetico e ciò che è aproairetico. Può ciò che è aproairetico essere superiore a ciò che è proairetico? Può ciò che è superiore essere vinto da ciò che è inferiore? La natura delle cose lo vieta in modo assoluto, tanto quanto la natura vieta la possibilità che un corpo materiale in moto superi la velocità della luce nel vuoto.
Nei suoi stucchevoli e anche troppo frequenti momenti di sbandamento e di debolezza, una proairesi come quella di Marco Aurelio lo dimentica e, affacciandosi sulle quotidiane vicende del mondo, intona su se stessa queste stupide e penose litanie, come se non fosse lei la sola ed unica responsabile di ciò di cui si lamenta.
[ X,10 ] Di cosa si vantano gli insipienti? Dei loro successi in tutte quelle attività che hanno di mira oggetti esterni ed aproairetici.
Ingannarsi, essere precipitosi, desiderare con smania viziosa non fa per essi differenza alcuna, se soltanto la imbroccheranno in ciò che è aproairetico. Dove invece ci sono morte o esilio o dolore o discredito, là essi arretrano, là entrano in agitazione.
Perciò, com’è verosimile che accada a coloro che sbagliano nelle questioni più grandi, ciò che nell’uomo è naturalmente coraggioso essi lo strutturano sfrontato, demenziale, protervo, sfacciato; mentre ciò che in noi è naturalmente cauto e rispettoso di sé e degli altri, lo strutturano vile e miserabile e pieno di paure e di sconcerti.
[ X,11 ] L’uomo virtuoso non si vanta e non ha alcun bisogno di vantarsi, ma se si vantasse di cosa si vanterebbe? Certamente di far vivere la saggezza nel campo di ciò che è proairetico e dunque di mostrare accettazione e gratitudine alla sorte nell’ambito di tutto ciò che è aproairetico.
[ X,12 ] La diairesi è il nostro sole.
[ X,13 ] Subito dopo il risveglio, a Marco Aurelio tocca fare ogni giorno un bagno di folla.
[ X,14 ] Queste sono le parole che il saggio, l’uomo educato alla diairesi, rivolge alla natura.
[ X,15 ] Vivere in armonia con la natura delle cose è possibile dappertutto, a patto di capire che vi sono luoghi o incarichi laddove l’unico modo per vivere in armonia con la natura delle cose è quello di abbandonare il luogo, l’incarico o la vita.
[ X,16 ] Questa è, in poche parole, la differenza che passa tra il cibo e il vomito, tra il sangue e le chiacchiere.
[ X,17 ] Rispetto alla totalità del cosmo, un normale oggetto esterno ed aproairetico ci appare certo, nelle sue dimensioni, un semino di fico e, nella sua durata, un giro di trapano. Salvo che per la proairesi dell’uomo la stessa totalità del cosmo è un oggetto esterno ed aproairetico, proprio come un semino di fico e un giro di trapano.
[ X,18 ] Noi viviamo in un cosmo nel quale c’è sempre, per ogni cosa, un altro giro di giostra.
[ X,19 ] Dagherrotipo dei politicanti e degli uomini di potere, con incorporato autoritratto di Marco Aurelio.
[ X,20 ] Bene e male, utile e dannoso non sono cose aproairetiche ma giudizi proairetici.
[ X,21 ] La natura delle cose è inviolabile ed essa accoglie l’egemonico dell’uomo, quando sia atteggiato diaireticamente, come la sposa accoglie il suo diletto sposo. Dunque, l’egemonico che tentasse di violentare la natura delle cose atteggiandosi controdiaireticamente non otterrebbe altro risultato che quello di evirare se stesso.
La prima citazione proviene da un frammento di Euripide.
[ X,22 ] Queste sono le tre alternative di vita, tanto semplici quanto chiare, che Marco Aurelio mostra di vedere dinanzi a sé. E il fatto che la seconda, quella centrale, sia esplicitamente rappresentata dal volontario abbandono del trono imperiale certifica in modo inconfutabile la viltà della prima e la stupidità della terza.
Una proairesi che fa ciò che non vuole e vuole ciò che non fa, tanto per usare un modo di dire inappropriato ma universalmente comprensibile, ha davvero di che stare allegra!
[ X,23 ] La differenza circa la vivibilità di un posto oppure di un altro non la fa il posto stesso, la vera differenza la fa la proairesi.
La citazione, molto brachilogica e di complessa interpretazione, proviene dal ‘Teeteto’ di Platone.
[ X,24 ] La proairesi pone sempre a se stessa delle domande. Queste domande e le corrispondenti risposte sono l’esempio di cosa si debba intendere per ‘cose proairetiche’.
[ X,25 ] L’afflizione, l’ira, la paura sono entità proairetiche: frutti aberranti di una proairesi che presume di poter violare la natura delle cose.
[ X,26 ] Una è la Materia Immortale ed una è la forza che la plasma incessantemente in forme diverse e ne produce meraviglie di fronte alle quali è giustificato il nostro stupore. Ancor più straordinaria è la meraviglia rappresentata dall’intelletto umano fatto capace di cogliere, non con gli occhi ma con non minore evidenza, l’unicità di quella Materia e di quella forza.
[ X,27 ] Le aberrazioni delle quali è capace la proairesi umana sono sempre le stesse: cambiano soltanto i nomi dei personaggi che le compiono.
Adriano, Antonino, Filippo di Macedonia e Alessandro Magno sono personaggi già citati in precedenza. Creso è il ricchissimo sovrano salito al trono della Lidia intorno al 560 a.C. Egli fu l’ultimo re della regione prima della conquista persiana del 547 a.C.
[ X,28 ] Il destino guida chi lo segue di buon grado e trascina a viva forza chi gli è riluttante.
[ X,29 ] La morte è terribile perché ci priva di qualcosa di esterno ed aproairetico?
[ X,30 ] L’aberrazione di una proairesi non può mai essere il danno di un’altra.
[ X,31 ] I materiali delle vita sono altrettante occasioni di esercizio per la nostra proairesi. Ed è dall’uso che di essi noi facciamo che ne conseguiremo felicità o infelicità, bene o male.
Nessuno dei personaggi citati è identificabile con certezza. Tenendo conto del contesto nel quale essi vengono citati, parrebbe trattarsi di membri della corte imperiale.
[ X,32 ] Si può chiamare davvero ‘vita’ quella che fanno gli insipienti?
[ X,33 ] Il retto uso della proairesi è, per l’uomo virtuoso, fonte di vera e sublime gioia. Retto uso della proairesi è sinonimo di retti giudizi e dai retti giudizi discendono le azioni rette.
Vi è tuttavia una differenza sostanziale tra giudizi ed azioni. I giudizi sono entità proairetiche sempre e comunque in nostro esclusivo potere mentre le azioni, potendo incontrare gli impedimenti più svariati, non sono in nostro esclusivo potere e dunque vanno classificate come entità aproairetiche.
Aberra pertanto chiunque affermi, senza la dovuta ‘riserva’ riferita agli eventuali impedimenti, di avere la potestà di fare o dire una certa cosa; anche se si intuisce che la carica ricoperta potrebbe indurre Marco Aurelio a commettere un simile grossolano errore.
Bisogna allora intendere il ‘fare’ e il ‘dire’ di cui qui si tratta, come riferentisi entrambi strettamente ed esclusivamente all’attività che la proairesi opera su se stessa, sotto forma di ‘fare una certa operazione proairetica’ e di ‘dire a se stessa’. Soltanto questa interpretazione permette di evitare la contraddizione e dà al testo un significato coerente.
Ciò è confermato dal paragone conclusivo del frammento, nel quale entrano in gioco la città, il cittadino e la legge. Senza entrare in analisi più sottili e più complesse, basti qui considerare l’assurdità di sostenere che se Atene subisce un danno ad opera di Sparta, Socrate ne ha subito un danno; poiché sarebbe come sostenere che ciò che è aproairetico può recare danno alla proairesi. Questo è invece impossibile, giacché ciò che è aproairetico può bensì uccidere la proairesi ma non può in alcun modo recarle anno. Ragion per cui appare evidente che ‘città’ è sinonimo di ‘proairesi’, ‘cittadino’ è sinonimo di ‘diairesi’ e ‘legge’ è sinonimo di ‘natura delle cose’.
[ X,34 ] Soltanto i retti giudizi ci fanno capaci di dominare afflizione e paura, ed il virtuoso li ha continuamente a portata di mano.
Le citazioni provengono da un celebre e notissimo passo dell’Iliade di Omero.
[ X,35 ] La retta proairesi è pronta a confrontarsi con qualunque evento aproairetico.
[ X,36 ] Se la morte di un uomo saggio è comunque salutata da molti con intima soddisfazione, cosa accadrà a te che saggio non sei?
Tralasciando ogni altra considerazione, è irresistibile la tentazione di leggere questo frammento di Marco Aurelio in chiave strettamente autobiografica. Non è richiesto un grande sforzo per vederlo circondato di cortigiani che se la ridono di quelle che considerano le sue manie pedagogiche mentre simulano di lodarle; di generali che ubbidiscono a colui che hanno soprannominato ‘vecchiarella filosofa’; e di un figlio, Commodo, da poco associato all’Impero e che mostra già le inclinazioni nefande cui darà pieno sfogo nel corso del suo regno.
[ X,37 ] Cos’ha di mira quel tale? È egli cosciente del fatto che può correttamente avere di mira qualcosa di aproairetico ma che deve allora sempre accompagnare questo progetto con una ‘riserva’, ossia con la ferma determinazione di conservare in ogni caso la sua proairesi in armonia con la natura delle cose: libera, infinita, inasservibile, insubordinabile, leale, rispettosa di sé e degli altri?
E io cos’ho di mira?
[ X,38 ] La proairesi.
*****
[ XI,1 ] Quello che Marco Aurelio chiama ‘animo razionale’ è, ovviamente, la proairesi atteggiata diaireticamente, della quale sono ben note le principali caratteristiche: libertà, infinità, inasservibilità, insubordinabilità.
Ad essa si possono ben adattare le due note locuzioni latine ‘Frangar non flectar’ e ‘Omnia mea mecum sunt’, che possono essere approssimativamente tradotte: ‘Mi spezzo ma non piego’ e ‘Ho con me tutti i miei beni’.
È anche facile notare come l’uso della diairesi ponga la proairesi fuori dallo spazio-tempo, dandole quel ‘respiro’ e quello ‘sguardo dall’alto’ che sono caratteristiche prettamente umane.
Tutto ciò, tuttavia, non vale per la proairesi che si atteggia controdiaireticamente. Allora, infatti, ognun vede come ad essa si adattino piuttosto altre due locuzioni, opposte alle precedenti: ‘Non mi spezzo perché sono pronta a piegarmi ed asservirmi’ e ‘Tutti i miei beni sono fuori di me’ ovvero ‘Flectar non frangar’ e ‘Omnia mea mecum non sunt’.
[ XI,2 ] L’uso della diairesi permette alla nostra proairesi di distinguere infallibilmente ciò che è proairetico da ciò che è aproairetico e di giudicarsi superiore a quest’ultimo.
[ XI,3 ] Ecco lo spettacolo della infinità della proairesi umana.
L’accenno ai Cristiani, se non si tratta di una interpolazione, è fatto da Marco Aurelio per rilevare come ciò che può apparire esteriormente un comportamento virtuoso possa a volte derivare non da razionalità ma da fede irrazionale, da cieca ostinazione, dal credere non perché se ne comprende la necessità logica ma perché è assurdo.
[ XI,4 ] Soltanto quando davvero giova a se stesso, l’uomo è utile anche alla società. Dunque l’azione più socievole che l’uomo possa fare è quella di atteggiare la sua proairesi secondo diairesi.
[ XI,5 ] L’arte di essere felici è un’arte che si può apprendere. Essa consiste nel riconosce la natura delle cose e nell’atteggiare diaireticamente la nostra proairesi.
[ XI,6 ] Questo breve excursus di Storia della Letteratura Greca serve a Marco Aurelio per ribadire in un’ottica stoica che cosa, secondo lui, in quella letteratura è eternamente vivo e proficuo e che cosa non lo è.
Anche Epitteto afferma esplicitamente che Omero ha composto le sue opere a bella posta affinché noi vediamo che nulla impedisce agli individui di stirpe più nobile, ai più forti fisicamente, ai più ricchi di denaro, ai più formosi di essere, qualora non abbiano i retti giudizi che si devono avere, individui meschini, infelici, preda di cattiva fortuna.
I frammenti qui citati sono tratti, nell’ordine, da: l’Edipo re di Sofocle, l’Antiope di Euripide, il Bellerofonte di Euripide, l’Ipsipile di Euripide.
[ XI,7 ] Felice è colui che può affermare di non avere trascorso tutta la vita a cercare invano, ma di avere trovato.
[ XI,8 ] Le relazioni che nella proairesi umana intercorrono tra diairesi, antidiairesi e controdiairesi possono essere facilmente esemplificate pensando alle relazioni che intercorrono tra le radici, il tronco e i rami fruttiferi di un albero.
Se la diairesi è la radice dell’albero e l’antidiairesi ne è il tronco, dai suoi rami pendono frutti che si chiamano libertà, felicità, pace. Se, invece, la controdiairesi è la radice dell’albero e l’antidiairesi ne è il tronco, dai suoi rami pendono frutti che si chiamano infelicità, servitù, guerra.
Nel periodo in cui un individuo defeziona da chi l’uomo è per natura delle cose, ossia mentre impiega sistematicamente la controdiairesi, la pace cessa per lui di esistere, in quanto gli altri uomini non gli appaiono più come esseri proairetici capaci di diairesi e di retti giudizi ma unicamente come oggetti esterni ed aproairetici qualsiasi da manipolare, da dominare, da uccidere, da vendere e da comprare.
È tuttavia peculiare della natura umana il fatto che sia sufficiente riatteggiare diaireticamente la proairesi per rientrare a buon diritto nella società degli uomini e nella pace, anche se l’operazione diventa via via più difficile quanto maggiore è il tempo che si trascorre in atteggiamento controdiairetico.
[ XI,9 ] L’essere miti non contraddice l’essere determinati e la pace non va confusa con l’arrendevolezza.
Sulle bandiere della pace sta scritto: ‘Ora e sempre resistenza a tutti i tiranni, quelli di fuori e quelli di dentro’.
Infatti, non c’è pace senza diairesi.
[ XI,10 ] La giustizia, come ogni altra virtù, è figlia della diairesi tanto quanto l’ingiustizia ed ogni altro vizio sono figli della controdiairesi. Ma la diairesi presuppone la proairesi umana operante e dunque la giustizia implica necessariamente l’esistenza di uomini giusti, senza i quali essa non viene al mondo e non vive.
Ora, è noto che per la tradizione classica l’arte è imitazione della natura e che l’opera di un vero artista è l’opera di un allievo che imita il maestro. Se dunque la proairesi dell’uomo è l’opera più eccellente della natura, l’uomo imiterà la natura se farà dell’uso quale deve essere della proairesi la sua opera più eccellente. Ma quest’opera è precisamente la virtù, che è riconoscimento della natura delle cose e pratica della diairesi.
D’altra parte non sorprende che Marco Aurelio, da imperatore chiamato quotidianamente a prendere delle decisioni tenda a privilegiare, tra le quattro virtù cardinali, la giustizia.
[ XI,11 ] Come dice Epitteto, a sconcertarci non sono le cose ma il giudizio della nostra proairesi che esse siano sconcertanti.
[ XI,12 ] La proairesi e il mistero della ‘Pala di Brera’.
La cosiddetta ‘Pala di Brera’ è un celebre dipinto su tavola attribuito a Piero della Francesca o alla sua scuola, databile intorno al 1470 e raffigurante la Madonna col Bambino, sei santi, quattro angeli e il duca Federico II da Montefeltro. Il dipinto pervenne a Brera nel 1810 dalla chiesa di San Bernardino a Urbino.
Varie ipotesi sono state proposte sul significato del misterioso uovo di struzzo sospeso al catino absidale, che sarebbe da intendere come simbolo cristiano dei quattro elementi (secondo vari accenni in tal senso contenuti nella letteratura medioevale) e simbolo della creazione, poiché con questo valore viene usualmente appeso nelle chiese dell’Abissinia e dell’Oriente cristiano. Di conseguenza, nel dipinto sarebbe evidente l’allusione alla nascita di Guidobaldo da Montefeltro la cui madre, Battista Sforza, morta nel 1472, fu sepolta proprio in San Bernardino.
Sempre a proposito del mistero dell’uovo, non è da tacere che esso richiama pure l’idea rinascimentale dello spazio centralizzato, perfettamente armonico e simmetrico. Anche il ripristino ideale della struttura originaria della Pala trova sostegno nel fatto che l’uovo appeso sopra il trono si qualifica come centro geometrico della composizione completa: a ribadire, in certo modo, il collegamento con l’assoluta simmetria vagheggiata dai rinascimentali.
Si legga ora il frammento di Marco Aurelio e si tenga a mente che l’italiano ‘di fulgida luce’ traduce l’aggettivo greco ‘augoeidès’ il quale significa basilarmente ‘che ha la natura della luce’ e quindi ‘luminoso’, ‘splendente’, ‘fulgido’.
L’uso dell’aggettivo ‘augoeidès’ si riscontra soltanto due volte negli ‘Stoicorum Veterum Fragmenta’.
In un primo frammento di Galeno (SVF II,219,10) il quale fu, tra l’altro, medico personale di Marco Aurelio, l’aggettivo è riferito al sostantivo ‘astri’, per dire: ‘gli astri hanno natura e sono fonte di luce, sono secchi e dotati di estrema intelligenza’.
In un secondo frammento sempre di Galeno (SVF II,231,20), l’aggettivo è riferito al sostantivo ‘pneuma’, per dire: ‘la facoltà visiva si dissolve quando lo pneuma che ha natura di luce cessi di affluire, in parte o del tutto, (agli occhi) dalla sua causa (arkè) cerebrale.
Ora, come è stato ben dimostrato da molti studiosi, l’elenco canonico delle 4 cause (arkài) basilari di tutti gli eventi del cosmo, in Aristotele e nella seguente tradizione filosofica, è questo: proairesi (proàiresis), natura (fùsis), necessità (anànke), fortuna (tùke).
È del tutto evidente che il secondo frammento di Galeno avvalora l’interpretazione che ad avere natura di luce e dunque ad essere sorgente di essa non sono le tre restanti cause basilari, ma la causa basilare ‘proairesi’, che viene anche correttamente localizzata come avente sede nel cervello. È dunque la ‘proairesi’ dell’uomo ad essere ‘augoeidès’.
Il primo frammento di Galeno, poi, conferma questa interpretazione in quanto, secondo la tradizione filosofica cui ci stiamo riferendo, anche il cosmo ha una ‘proairesi’ avente la stessa natura di luce. È questa ‘proairesi’ del cosmo che fa splendere gli astri, li fa intelligenti; come quella dell’uomo ne fa splendere gli occhi e gli permette vista e intelligenza. Se ne può concludere che ad essere ‘augoeidès’ è anche la ‘proairesi’ del cosmo.
Chiediamoci ora: come rappresentare pittoricamente questa concezione della ‘proairesi’ del cosmo e dell’uomo? Certamente, nella pittura antica, come una sfera di fulgida luce.
Passano dodici secoli. Mutano genti e linguaggi e l’oblio stende le sue ali inesorabili.
È fuori discussione che nel Quattrocento fosse in pieno sviluppo in Occidente il poderoso movimento di recupero della tradizione greca, legato alle critiche vicende che attraversava in quel periodo Costantinopoli, assediata e conquistata dagli Ottomani. Ci si risveglia, dunque, dopo secoli e ci viene insegnato che in greco moderno e popolare ‘avgà’ indica adesso le ‘uova’ e l’aggettivo ‘avgoeidès’ significa ‘che ha forma di uovo’, ‘ovale’.
I pittori non devono fare anche i filologi. Se Piero della Francesca o chi per lui, tramite i suoi più che colti amici, è venuto a conoscenza del fatto che l’uomo e il cosmo hanno una ‘proairesi’, ne ha compreso il valore e se, nel corso di tante discussioni gli è stata sempre offerta la ovvia e popolare traduzione dell’aggettivo ‘avgoeidès’, perché avere dei dubbi?
Dipingerà la Pala di Brera e metterà al suo centro, tanto geometrico che filosofico, l’oggetto-simbolo di ciò che nell’uomo e nel cosmo è più possente e li fa splendere.
Per un ulteriore chiarimento sul profondo significato filosofico e fisico-matematico di questo frammento XI,12 di Marco Aurelio clicca qui
[ XI,13 ] La diairesi insegna all’uomo virtuoso che il disprezzo o l’odio altrui nei suoi confronti sono cose aproairetiche, e dunque vanno giudicate essere né un bene né un male. Sarà poi l’uso che egli farà di esse a diventare il suo proprio bene o il suo proprio male.
Una biografia di Focione fu scritta da Plutarco e fa parte delle sue ‘Vite parallele’. Generale e politico dell’Atene del IV secolo a.C., Focione ebbe fama di probità e di sopportazione delle ingratitudini altrui.
[ XI,14 ] Dagherrotipo del popolo dei micropoliticanti e delle élites dei macropoliticanti.
[ XI,15 ] Chi si scusa di qualcosa senza esserne stato richiesto, con ciò stesso si accusa di ciò di cui intenderebbe scusarsi. La virtù, dunque, non ha bisogno né di tante né di poche parole, giacché parla da sola.
[ XI,16 ] Per vivere il meglio possibile bisogna cercare e trovare il proprio vero bene. E il nostro proprio vero bene sta nella conoscenza della natura delle cose e in una proairesi rettamente operante in armonia con essa.
[ XI,17 ] Il destino di tutto ciò che è aproairetico.
[ XI,18 ] Memorandum in dieci punti per Marco Aurelio.
[ XI,19 ] Quattro pervertimenti della proairesi ai quali la proairesi stessa deve porre rimedio.
[ XI,20 ] Pur essendo di per sé distinti e separabili, i quattro elementi naturali (fuoco, aria, terra e acqua) possono essere disposti e mescolati in infiniti modi senza che neppur uno di tali modi vada considerato contro natura.
La proairesi dell’uomo non può atteggiarsi in infiniti modi ma in due soltanto: diairesi e controdiairesi; ma anche in questo caso nessuno dei due modi può essere considerato contro natura.
Se diairesi e controdiairesi sono entrambi modi egualmente naturali di atteggiarsi della proairesi, essi sono però modi ben diversi e del tutto opposti di atteggiarsi nei confronti della natura delle cose.
Con la diairesi, infatti, la proairesi riconosce ed accetta la natura delle cose e la sua fondamentale bipartizione in cose che sono in nostro esclusivo potere e cose che non lo sono, ottenendone libertà e felicità.
Con la controdiairesi essa invece nega questa bipartizione e mentre proclama in nostro esclusivo potere cose che non sono in nostro esclusivo potere oppure non essere in nostro esclusivo potere cose che invece sono in nostro esclusivo potere, procura inevitabilmente a se stessa infelicità e schiavitù.
[ XI,21 ] Anche un assassino, anche un politicante è un individuo secondo natura ed è perfettamente capace di rimanere per tutta la vita un assassino e un politicante. Dunque non basta avere per tutta la vita uno scopo qualunque per essere degno di chiamarsi uomo, ma bisognerà avere per tutta la vita lo scopo specifico di essere e di rimanere un uomo.
Si giudica forse ciascun essere dalla sua mera conformazione? Se così fosse, allora anche quella di cera sarebbe una mela. Invece deve anche averne la fragranza ed il gusto, non basta il connotato esteriore. Neppure naso ed occhi sono dunque adeguati a fare l’uomo, se non avrà giudizi da uomo.
E quali giudizi fanno un uomo? I giudizi che fanno un uomo sono la conoscenza della natura delle cose, il suo rispetto grazie alla diairesi, il retto uso delle rappresentazioni.
Soltanto questo diventa anche bene comune ed è socialmente utile.
[ XI,22 ] L’accenno del frammento è ad una celebre favola dell’antichità che, nella redazione di Esopo, contrappone la vita frugale e senza sconcerti alla vita lussuosa tra continue paure ed affanni.
Non è difficile vedervi il richiamo allegorico alla proairesi atteggiata diaireticamente ed a quella atteggiata controdiaireticamente.
[ XI,23 ] Nella tradizione popolare, le ‘lamie’ erano mostri che si diceva succhiassero il sangue dei bambini.
Anche Epitteto riferisce espressamente che Socrate considerava spauracchi per bambini l’afflizione per cose aproairetiche come il dolore fisico e la morte.
[ XI,24 ] Quella che potrebbe apparire semplice cortesia spartana serve invece a Marco Aurelio come allegoria della retta proairesi: squisita con gli altri, capace di accettare gli eventi aproairetici e di trarne serenità e fortezza.
[ XI,25 ] L’episodio è citato anche da Aristotele e da Seneca, secondo i quali però l’invito a Socrate partì non da Perdicca ma da suo figlio Archelao.
L’interpretazione di Seneca è che la risposta di Socrate fu motivata dal suo rifiuto di diventare un cortigiano e di cacciarsi in volontaria servitù. Se, infatti, già la patria Atene faceva fatica a sopportare la sua libera proairesi, cosa sarebbe successo a Socrate alla corte di un re?
[ XI,26 ] Una nobile prescrizione epicurea sulla quale anche gli stoici non possono non essere d’accordo.
[ XI,27 ] Le stelle non hanno bisogno di vestiti, sono nude: come la verità.
[ XI,28 ] Anche Socrate era rimasto nudo, dopo che sua moglie Santippe s’era portata via i suoi vestiti. Quali furono allora le parole che la proairesi di Socrate disse a se stessa?
L’episodio non ci è noto da altre fonti.
[ XI,29 ] Siccome la virtù è conoscenza della natura delle cose e questa conoscenza non è innata, i buoni maestri ci sono essenziali.
[ XI,30 ] Il frammento si presta a molte interpretazioni possibili. Una delle più semplici consiste nel riferirlo a qualunque essere privo di ragione.
[ XI,31 ] Questa risata omerica è una citazione proveniente dal IX libro dell’Odissea.
[ XI,32 ] Lo spettacolo della virtù fa esasperare gli insipienti.
La citazione proviene da ‘Le opere e i giorni’ di Esiodo.
[ XI,33 ] Volere un fico d’inverno è, anche per Marco Aurelio, una cosa da pazzi.
Il frammento è una citazione di Epitteto, proveniente dal capitolo 24 del III libro delle Diatribe.
[ XI,34 ] La natura delle cose e le parole di malaugurio.
Anche questa citazione proviene dal capitolo 24 del III libro delle Diatribe di Epitteto.
[ XI,35 ] Nel cosmo il nulla non esiste, e la Materia Immortale semplicemente si trasforma.
Questa citazione, come le due precedenti, proviene dal capitolo 24 del III libro delle Diatribe di Epitteto.
[ XI,36 ] La nostra proairesi è al riparo da qualunque possibile rapina.
La citazione proviene dal capitolo 22 del III libro delle Diatribe di Epitteto.
[ XI,37 ] Questo frammento è attribuito all’opera di Epitteto con il numero XXVII.
[ XI,38 ] Anche questo frammento è attribuito all’opera di Epitteto con il numero XXVIII.
[ XI,39 ] Queste parole di Socrate non sono riferite da nessun’altra fonte e potrebbero essere una citazione autentica tratta da uno dei libri di Epitteto che non ci sono pervenuti.
Si noti come Socrate definisca correttamente ‘razionali’ anche gli animi degli ‘insipienti’ ossia di coloro la cui proairesi è atteggiata controdiaireticamente.
*****
[ XII,1 ] Non bisogna avere paura di morire ma di non avere mai neppure cominciato a vivere in armonia con la natura delle cose.
[ XII,2 ] La proairesi dell’uomo è la meraviglia delle meraviglie delle quali è stato finora capace Zeus ossia la Materia Immortale.
Quali sono le parole di Epitteto al riguardo? Eccole: “O uomo, non essere ingrato né immemore delle cose migliori; ma per il vedere, il sentire, per lo stesso vivere e per quanto ad esso coopera, per i frutti secchi, per il vino, per l’olio ringrazia la Materia Immortale. E ricorda che essa ti ha dato qualcos’altro migliore di tutto questo: quanto le userà, le valuterà, conteggerà il valore di ciascuna. Cos’è infatti che dichiara per ciascuna di queste facoltà, quanto una di esse merita? Forse ciascuna facoltà lo fa da sé? Hai mai sentito la facoltà visiva dire qualcosa di se stessa? Forse quella uditiva? Esse sono invece state posizionate per essere servitrici, come ministre e serve, della facoltà atta ad usare le rappresentazioni”.
[ XII,3 ] All’interno del rigoroso monismo caratteristico degli stoici, il quale presuppone la completa equivalenza di materia ed energia, vi è ovviamente posto per gli aggregati materiali più diversi.
Certi specifici aggregati materiali permettono l’emersione dalla materia di caratteristiche che altrimenti sono normalmente celate. È il caso dell’uomo la cui proairesi, lungi dall’essere una straniera giunta da un altro mondo (il mondo dello spirito) per essere incarcerata nella materia, come pretenderebbero le teorie dualistiche, è invece l’arcobaleno che appare nella quiete dopo la tempesta.
L’uomo, tuttavia, non è soltanto proairesi, così come l’arcobaleno non è soltanto luce di diversi colori. L’uomo è anche, per Marco Aurelio, il corpo che ha in comune con minerali e vegetali; e il soffio vitale, o pneuma, che egli ha in comune con tutti gli altri animali, seppure sia evidente che a caratterizzarlo e qualificarlo come uomo non sono questi due ultimi componenti bensì la proairesi.
E, in verità, neppure soltanto la proairesi senza altre specificazioni, ma la proairesi rettamente operante cioè la proairesi che sa donde è venuta, che conosce se stessa e la natura delle cose.
[ XII,4 ] Qual è l’opera cardinale della proairesi rettamente operante? Opera cardinale della proairesi rettamente operante è quella di conservare se stessa in armonia con la natura delle cose grazie all’uso della diairesi. Ossia quella di conservare, in ogni circostanza, se stessa tale e quale è per natura: libera, infinita, inasservibile, insubordinabile.
Si può dire che una proairesi così operante ‘ama’ se stessa? Certamente, giacché si deve intendere per ‘amore’ di qualcosa il dare a quella cosa il suo giusto valore. Il che significa che soltanto il saggio è capace di amare, giacché amare implica inevitabilmente la conoscenza del valore di ogni cosa e dunque la capacità di distinguere tra ciò che è proairetico e può essere bene o male, e ciò che è aproairetico e invece non può mai essere né bene né male.
Dunque l’insipiente è ben lontano dall’amare se stesso giacché, tutto al contrario, è campione olimpico nel dividere per zero e nel prendere fischi per fiaschi: ossia nell’usare sistematicamente la controdiairesi. E usare sistematicamente la controdiairesi vuol dire disprezzare la propria proairesi giudicandola, ad esempio, inferiore a qualcosa di aproairetico come il giudizio di un altro su di noi.
Pertanto lo stupore di Marco Aurelio, ammesso che sia sincero, risulta piuttosto fuori luogo e testimonierebbe, in questo specifico caso, un momento di sua scarsa capacità di comprensione logica ed analisi creativa di un aspetto non secondario ma cruciale di quella dottrina stoica che pure professa di voler seguire.
[ XII,5 ] Desiderare l’immortalità della proairesi umana è una stolida assurdità, appena si rifletta sul fatto ovvio, evidente e certo che ad essere immortale è già la materia che forma il corpo umano e dalla quale la proairesi è espressa.
Il desiderio della vittoria sulla morte, poi, è una stupida volgarità in quanto implica il giudizio che la nascita dell’uomo sia un bene in sé e che la morte sia un male in sé: concezioni entrambe caratteristiche degli insipienti sia in cielo che in terra.
[ XII,6 ] L’abitudine è una forza potente, che tende scorrettamente ad essere sottovalutata.
Nulla è tanto produttivo di felicità quanto il maturo esercizio quotidiano e sistematico della diairesi; e nulla spiega meglio l’infelicità del genere umano quanto il rifiuto di imparare dai propri errori e l’ostinazione nel praticare in massa l’infantile controdiairesi.
[ XII,7 ] Lontano dalla preoccupazione di essere letto, Marco Aurelio può permettersi di registrare anche i suoi momenti peggiori: quelli in cui la sua proairesi dubita di se stessa, è preda dello sgomento davanti alla morte, si scorge nuda di virtù, inorridisce dinanzi all’abisso d’eternità che le si spalanca dinanzi e alle spalle, si sente di una debolezza estrema.
[ XII,8 ] E questa è la immediata reazione di Marco Aurelio alle confessioni del frammento precedente: come il tentativo di risveglio da un incubo, il disperato sforzo di darsi uno scossone e quindi di far riprendere alla sua proairesi il posto che le spetta.
[ XII,9 ] La nostra proairesi deve e può avere sempre a portata di mano i giudizi adeguati ad ogni circostanza.
[ XII,10 ] Ciò che Marco Aurelio indica, in questo frammento, come il ‘materiale’ è certamente rappresentato da tutto ciò che è aproairetico. La ‘causa’ va sicuramente riferita all’elenco delle quattro cause basilari di tutti gli eventi cosmici: proairesi, natura, necessità, fortuna. Il ‘riferimento’ va fatto, verosimilmente, all’impiego, che è proairetico, della diairesi o della controdiairesi.
[ XII,11 ] Tutto ciò che è proairetico è in nostro esclusivo potere e tutto ciò che è aproairetico non è in nostro esclusivo potere.
[ XII,12 ] Nelle opere della natura non si dà aberrazione alcuna.
E per parte loro gli uomini, anche quando aberrano, fanno sempre ed esclusivamente ciò che a loro appare bene.
[ XII,13 ] Che c’è dunque di strano se gli asini non volano, se dalle rape è impossibile cavare sangue e se le immense masse degli insipienti, ricchi o poveri di denaro, si ostinano a dividere qualunque cosa per zero, col risultato di produrre infelicità per se stessi?
[ XII,14 ] Qualunque cosa ne possa dire qualunque filosofo, qualunque sia l’organizzazione del cosmo, è certo che l’uomo è un essere proairetico e che la proairesi dell’uomo, come ben dice Epitteto, ‘neppure Zeus può vincerla’.
Del resto, a ben riflettere, non ha fondamento alcuno la polemica di quanti affermavano, e affermano ancora, che se tutto fosse governato dal destino allora la proairesi dell’uomo non sarebbe più libera. Non vi è affatto contraddizione tra l’esistenza di un destino che governa rigidamente e ineluttabilmente ogni cosa e la libertà della proairesi. Qual è, infatti, il destino che governa la proairesi umana, ossia il nostro destino di uomini? Il nostro destino di uomini è, per l’appunto, quello di essere liberi, cioè di essere il destino di noi stessi.
[ XII,15] O invece la luce della lucerna risplende e non perde fulgore finché non sia spenta, mentre la verità, la giustizia, la temperanza che sono in te si estingueranno prima?
[ XII,16 ] Come può non essere insipiente chi si fa sistematicamente guidare dalla controdiairesi? E come può non essere infelice l’insipiente, il quale desidera e non ottiene mai ciò che desidera, avversa ed incappa sempre in ciò che intende avversare?
Tu stesso, poi, proprio tu che immagini di poter persuadere tutti gli esseri umani di quali siano i beni ed i mali sei, per ciò stesso, un insipiente.
[ XII,17 ] Stabilità nella diairesi e dunque nella virtù.
[ XII,18 ] Nella nostra proairesi, le rappresentazioni possono essere originate da un’entità proairetica o da un’entità aproairetica.
[ XII,19 ] Nell’uomo, la proairesi è la facoltà superiore a tutte le altre facoltà e quella alla quale tutte le altre facoltà sono sottoposte.
[ XII,20 ] Il fatto che la proairesi sia una facoltà tanto potente vuol forse dire che essa è onnipotente? Nient’affatto, e perciò essa non va usata a casaccio.
[ XII,21 ] Un’eterna trasformazione delle cose che adesso esistono, non nel nulla ma in cose che adesso non esistono.
[ XII,22 ] I giudizi e le concezioni sono in nostro esclusivo potere, sono entità proairetiche, parlano. Gli oggetti esterni non sono in nostro esclusivo potere, sono entità aproairetiche, sono muti.
Prova a disciplinarti secondo questa verità e vedi che effetto ti fa.
[ XII,23 ] Poiché bene e felicità sono semplicemente due modi per indicare lo stesso stato della proairesi umana è poiché gli insipienti non sono felici pur condividendo la vita con i saggi, ne consegue che il puro e semplice essere in vita non può essere definito di per sé un bene.
Se poi si osserva che la morte coglie tanto i saggi, i quali vivono nel bene e sono felici, quanto gli insipienti, i quali vivono nel male e sono infelici; e inoltre si tiene presente che non possono patire alcun male coloro che vivono nel bene: ne consegue che la morte di per sé non può essere definita un male.
Pertanto sia la nascita dell’uomo quanto la sua morte vanno correttamente giudicati come eventi aproairetici, non in suo esclusivo potere; e dunque tanto la nascita che la morte vanno concepiti come qualcosa che non è né un bene né un male.
Quale vita e quale morte, allora, potranno essere giudicate un bene? La risposta è semplice: una vita e una morte virtuose come quelle di Socrate, illuminate dalla diairesi e dal rispetto della natura delle cose.
E quale vita e quale morte potranno, al contrario, essere giudicate un male? Una vita e una morte viziose come quelle dei carnefici di Socrate, oscurate dalla controdiairesi e dalla negazione dell’esistenza della natura delle cose.
[ XII,24 ] Le tre considerazioni che Marco Aurelio si invita a tenere a portata di mano sono, nell’ordine, le seguenti: la prima concerne la distinzione tra ciò che è proairetico e ciò che è aproairetico, e l’uso della diairesi.
La seconda concerne le caratteristiche della Materia Immortale di cui siamo composti e il fatto che da essa si esprime anche la nostra proairesi.
La terza concerne la vastità del cosmo e l’infinita molteplicità delle sue vicende, paragonata al fatto che la proairesi dell’uomo può atteggiarsi soltanto ed esclusivamente in due modi diversi: diairesi o controdiairesi.
[ XII,25 ] L’infelicità, a ben pensarci, non è altro che il giudizio di essere infelici.
[ XII,26 ] Tanto il saggio quanto l’insipiente vivono secondo natura, ma l’insipiente non sa, o ha dimenticato, o finge di non sapere qual è la natura delle cose e di avere una proairesi per natura libera, infinita, inasservibile e insubordinabile.
[ XII,27 ] È straordinaria la bassezza di ciò verso cui la controdiairesi spinge le turbe dei fortunati e degli sfortunati.
I personaggi citati (fatta eccezione per Tiberio imperatore e per Velio Rufo, destinatario di una lettera di Frontone) sono sconosciuti e i dettagli delle vicende cui si accenna nel frammento ci sono del tutto ignoti.
[ XII,28 ] Il rigoroso panteismo degli stoici fa sì che Zeus, ossia la Materia Immortale, sia dappertutto. Dunque, gli dei sono visibili anche a occhio nudo.
[ XII,29 ] Detto fra di noi: l’uomo stoico è l’unico che sappia davvero godersi la vita perché è l’unico attrezzato per comprenderla.
[ XII,30 ] Il frammento ribadisce il saldo monismo stoico e la sostanziale unità della Materia Immortale.
Unità della sostanza del cosmo, che discende dal fuoco generatore e nel fuoco è destinata periodicamente a risolversi; unità della vita di tutti gli esseri privi di ragione; unità di natura e di funzionamento delle proairesi degli esseri dotati di ragione. Quanto agli altri elementi (aria, acqua e terra) essi sono privi di sensazioni ma pure tendono ad unirsi tra di loro per effetto della gravità.
Questa è certamente una lettura possibile del frammento.
Ma è curioso che ne sia possibile anche un’altra, legata al fatto che tanto le osservazioni astronomiche di Claudio Tolomeo, le quali avvengono tra il 127 e il 151 d.C., quanto la pubblicazione del suo celebre ‘Grande Sistema di Astronomia’ o ‘Almagesto’ sono coeve di Marco Aurelio, e che dunque non sembra azzardato supporre che quest’ultimo ne conoscesse l’opera.
Il presente frammento si presta infatti anche ad essere letto come una breve sintesi di cosmologia Tolemaica, lumeggiante la distribuzione degli elementi nei vari cieli e l’affinità della proairesi umana con il fuoco.
Se il riferimento di Marco Aurelio è qui davvero al sistema geocentrico tolemaico, allora la terra va posta al centro dell’universo e ruotano intorno ad essa, nell’ordine, i seguenti corpi celesti con i relativi cieli: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, Stelle Fisse.
La Terra e il cielo sublunare sono ritenuti sede dei quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco; e sono soggetti al cambiamento, alla nascita e alla morte. I corpi celesti e i cieli oltre la Luna, invece, sono immuni da tali fenomeni, non ospitano né acqua né terra né aria, e sono composti di un fuoco sempre più puro man mano che si sale verso il cielo delle Stelle Fisse. Dei quattro elementi, inoltre, quello generatore di tutti gli altri e quello in cui essi sono destinati periodicamente a risolversi è il fuoco.
Nella prima metà del frammento, la parte di universo in cui una sola è la comune sostanza separata in molti corpi diversi e uno solo è l’animo separato in nature diverse, potrebbe allora essere un chiaro riferimento al Sole, ai Pianeti e alle Stelle dell’universo sopralunare la cui comune ed unica sostanza è il fuoco. Si tratta di corpi celesti dotati anche di un unico animo cognitivo, di un intelletto del quale fanno fede i loro moti diversi ma perfetti ed eterni.
Nella seconda metà del frammento, la restante parte di universo è rappresentata dalla Terra e dal cielo sublunare, nella quale compaiono, oltre a piccole quantità di fuoco, anche l’aria o pneuma e poi gli elementi terra e acqua che hanno tendenza a congiungersi verso il basso.
Infine la proairesi dell’uomo, che è considerata una scintilla di puro fuoco divino sulla terra e che con esso tende a ricongiungersi.
[ XII,31 ] Il desiderio dell’immortalità personale non è un desiderio da uomini liberi che conoscono la natura delle cose, ma da schiavi stolti che la ignorano.
[ XII,32 ] Vivere da uomini e morire da uomini.
[ XII,33 ] La proairesi è autoteoretica ed è infinita libertà, mentre ciò che è aproairetico è cadavere e fumo.
[ XII,34 ] Quando c’è la proairesi non c’è la morte e quando c’è la morte non c’è la proairesi.
[ XII,35 ] A chi la morte non fa paura.
[ XII,36 ] Un addio pacificato.